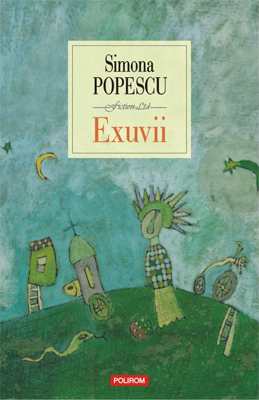|
|
Simona Popescu e il suo romanzo «Exuvii / Crisalidi». Anteprima
 Nel nostro Focus dedicato al tema della scrittura negli autori romeni figura Simona Popescu, nata nel 1965 a Codlea, nel distretto di Brașov, una delle più rilevanti prosatrici e poetesse del panorama letterario romeno attuale. Laureatasi nel 1987 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest, attualmente è docente nella stessa università dove insegna Storia della letteratura romena e tiene corsi di Scrittura creativa. È stata insignita di numerosi premi letterari. Ha partecipato a festival, workshop e a sessioni di letture in Germania, Austria, Francia, Italia, Polonia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Nel nostro Focus dedicato al tema della scrittura negli autori romeni figura Simona Popescu, nata nel 1965 a Codlea, nel distretto di Brașov, una delle più rilevanti prosatrici e poetesse del panorama letterario romeno attuale. Laureatasi nel 1987 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest, attualmente è docente nella stessa università dove insegna Storia della letteratura romena e tiene corsi di Scrittura creativa. È stata insignita di numerosi premi letterari. Ha partecipato a festival, workshop e a sessioni di letture in Germania, Austria, Francia, Italia, Polonia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il suo romanzo del debutto, Exuvii, uscito per l’editrice Nemira (Bucarest) nel 1997, ha avuto una seconda edizione per l’editrice Paralela 45 (Piteşti) nel 2004 e ben tre edizioni presso l’editrice Polirom (Iași) rispettivamente nel 2004, 2007 e 2011, e ha avuto un grandissimo successo (ottenendo il prestigioso Premio dell’Associazione degli Scrittori della Romania)
Le «crisalidi» del titolo sono i nostri vecchi involucri, le nostre età precedenti, destinate all’oblio, che l’autrice insegue e colleziona, chiamandole a raccolta nel presente della propria scrittura. Exuvii è una autobiografia fantastica e, allo stesso tempo, è un’opera mondo, che si immerge negli abissi dell’Io femminile, cercando di ricostruire dalle sue fondamenta non solo le diverse età e identità di una vita, ma anche l’intero mondo circostante e la lingua che serve per descriverlo. In una sorta di postmoderna «ricerca del tempo perduto», Simona Popescu fa rivivere sulla pagina il mondo enigmatico e oscuro dell’infanzia, gli anfratti dell’immaginazione e le fantasticherie dell’adolescenza, i luoghi dimenticati del proprio passato, le cucine, gli armadi, i cassetti, i libri, i giochi, le parole, gli odori, le persone che, strato dopo strato, crisalide dopo crisalide, hanno rappresentato le diverse incarnazioni del proprio eterno presente. Scritto in uno stile immaginifico e ricchissimo di registri e tonalità, in cui si mescolano il comico e il tragico, il libro è uno spettacolo funambolico di storie e di immagini, che sorprende a ogni pagina. Si tratta sicuramente di una delle opere più vive e interessanti che ci sono arrivate in questi ultimi anni dall’Est europeo.
Il libro non ha mancato di trovare eco anche all’estero dove è stato tradotto in polacco (Wylinka) dalle Edizioni Czarne nel 2002, in ungherese (Vedlések) dalle Edizioni Pont Kiadó nel 2008, e in francese (Exuvies) dalle Edizioni Non Lieu nel 2016.
Frammento da «Exuvii / Crisalidi»
Prologo
Cosa speri tu, tessendo infinite trappole di parole, attorcigliate, alla stregua di un ragno impazzito che stende la propria tela unicamente al fine di lasciarla brillare al sole, per un istante, per poi abbandonarla? In quel reticolo, a rimanere impigliati sono soltanto fantasmi, vecchie parvenze, rumori, voci, frastuoni, fragranze, forme invisibili, intuizioni. Ti paralizzano dolcemente, ti risucchiano, vecchi vampiri che non intendono morire.
[…]
Colleziono crisalidi.
Una volta ogni sette anni le tue cellule mutano. Ogni sette anni il tuo ciclo si conclude, subisci una mutilazione. Ricomincia tutto da capo. In un corpo che è lo stesso ed un altro. Solamente il cervello rimane fedele a se stesso, è lui il vecchio generale che impartisce ordini alle reclute chiamate a costituire il tuo nuovo involucro. È lui l’equilibratore degli ectoplasmi delle tue esistenze soppresse (che avendo perduto il proprio corpo, esigono incessantemente di essere risarcite). Lui li riconosce, ti riconosce. Famelico, ingurgita e annienta tutto nella sua furia divoratrice. Sembra aver amato ogni singola carcassa che ti ha avvolta, dato che le rammenta impeccabilmente. È un cervello privo di nostalgia, poiché nulla è davvero perduto (lo sa fin troppo bene, lui).
[…]
Ora hai quasi 28 anni. Avverti in maniera sempre più nitida la consapevolezza di non essere sola. Di essere la rappresentante di una piccola comunità femminile i cui membri sono tutti i bambini che tu sei stata, una sorta di maschietti e femminucce messi insieme, fra cui anche tenere fanciulle in procinto di sbocciare, ognuna di loro ossessionata dalla propria fortunata (o malaugurata) eventualità di trasformarsi in un’anziana e distinta signora, in una decrepita, rigida mummia, in una vecchia rimbecillita oppure in nessuna di queste. Ad attendere i tuoi comandi vi sono 27 esseri indefiniti, semiperduti, pseudopassati. Raccogli più materiale possibile in modo da avere la prova concreta della realtà di tutti quegli avatar che ti hanno formata. La loro esistenza terrena ha lasciato impronte fantomatiche. Indosso sotto la mia pelle il loro segno invisibile, così come altri celano sotto i vestiti il proprio tatuaggio-portafortuna. I «neutrini» della mia essenza sono in perenne metamorfosi. Non sono altro che un ibrido astratto e concreto che respira. In un certo senso vivo quello che pare vivano le persone alle quali è stata amputata una parte del corpo, una mano oppure un piede e che, si dice, le sentono proprio come se fossero ancora lì, esattamente dove dovrebbero essere. Tutte queste Simone, a modo loro, sopravvivono. In altre sembianze forse, fatto sta che le avverto. Prendo in prestito le loro impressioni. Mi hanno lasciato un’immensa eredità e allo stesso tempo un mare di debiti. Mi domando come possano vivere in armonia il maschiaccio che ero quando avevo 4 anni con la larva che ero a 6, oppure con la bimbetta ambiziosa di 9; la secchiona di 11 con l’ignava di 16, lo stecchino che ero a 15 con il bidone che ero a 17, la diciannovenne anemica con la ventunenne vigorosa, la bruttina che ero a 10 anni con la graziosa bimbetta di 13, la sognatrice di 16 con la quindicenne stupidotta; l’allieva con l’insegnante, la vergine con la donna, l’inibita con la spudorata, la fifona con la rivoluzionaria, l’insopportabile tronfia con la creatura tormentata e confusa che ora ho modo di apprezzare di più, la bimba viziata con quella severa e tagliente, e così via. Semialleanze, compromessi, negoziati... Oh, ma tutte loro, stupide e intelligenti, belle e brutte, insopportabili e carine, sciocche e selvagge, convivono giudiziose, in un tacito accordo, mentre i miei occhi (moltiplicati) contemplano per l’ennesima volta la riproduzione di un quadro di Arcimboldo, Eva e la mela, accanto al suo vis-à-vis: un mezzobusto femminile nella cui mano è racchiusa una mela e di fronte a lei, un uomo con una pergamena e un libro tra le braccia. Il volto della donna è un agglomerato, una geometria formata da miniature di corpi, nudi e avviticchiati, di figure puerili, mentre quello dell’uomo una composizione di graziosi putti. Ho afferrato questa immagine, la tengo fissa nella mia mente proprio come il ragazzo ricurvo su se stesso – che costituisce l’orecchio della donna – sorregge l’oneroso pendente madreperlato.
Ho 28 anni e mi dissocio soprattutto dalle signorine, mentre mi dirigo speranzosa verso l’autorevole bambino di 5, 6, 7 anni che viveva come un essere immortale, oppure verso quell’onesta diciottenne che si è trovata a fare i conti con le menzogne e le scempiaggini di un’adolescenza appena tramontata, o ancora verso quella di 20, intransigente, a suo modo, verso se stessa e radiosa (in quanto detentrice di quella forza che soltanto l’adolescente impaurito avverte di possedere).
«Parlami di te», mi ha detto una volta un ragazzo che diceva di amarmi. In quell’attimo ho realizzato per la prima volta che non posso parlare di me stessa senza provare la sensazione di un atroce e inevitabile tradimento. Di quale me vuoi che ti parli? «Vuoi che ti racconti di com’ero a cinque anni?» ho risposto. «O vuoi che ti parli dell’idiota che ero a 15? Un anno fa ero estremamente grassa, senz’ombra di dubbio non ti sarei piaciuta, ma ero una persona terribilmente gentile».
Sul silenzio
Ho letto da qualche parte che il cianciare altrui (ovvero banali dissertazioni, quisquilie senza le quali certi individui ignorerebbero tanto la propria identità quanto i propri obiettivi), quei bla-bla quotidiani, quei borborigmi, l’umano fru-fru che ti perseguita giorno dopo giorno, possono renderti saturo di «energia negativa»: opprimendoti, depauperandoti, attraendoti verso orbite estranee, infine sviscerandoti. Inerme orecchio dalle molli cartilagini! Varco predisposto ad ogni sorta di contaminazioni...!
Nessuno che si presti ad ascoltare, nessuno che desideri veramente dire qualcosa. Non ho mai compreso fino in fondo gli Uomini del Rumore. Li osservo, e mi difendo tacendo; in questo modo li obbligo a togliermi di dosso il loro vano fervore, a ritirare le proprie truppe sonore da un’area inoppugnabile, a placare quel mormorio che avanza in tua direzione e che prontamente riesci a schivare, lasciando che scivoli oltre.
Nel corso della mia infanzia, una maestra d’asilo mi ha detto che ero una bimba cocciuta. Non volevo mai raccontare nulla, chiacchierare o prendere parte a quei giochi che presupponevano lo stare insieme. Non volevo partecipare in generale. Di fatto, provavo ribrezzo per tutte quelle baldorie, carnevalate o affini. Cocciuta, ovvero avere la coccia dura, quel tuo nido sicuro al cui interno puoi startene rannicchiata, barricata, celarti dietro il plumbeo scudo del silenzio. È come se a ripararti fosse... una specie di ombrello dorato, ecco. Potrebbero pioverti addosso migliaia di ingiurie, scocciature e non so cos’altro, che non te ne importerebbe un fico secco.
«È tutta suo nonno», mormorava, digrignando i denti, una delle mie zie, data la mia scarsa voglia di raccontare quali attività svolgessi a scuola, che tipo di libri leggessi, eccetera eccetera... Somiglio a nonno Nicolae, pensavo, e mi sentivo onorata. Provavo quasi l’impulso di alzarmi in piedi, in segno di rispetto (per il nonno e per me stessa). Nonno Nicolae soleva rimanere adagiato su una seggiola a tre gambe, sostenendo il suo capo tra le mani e perdendosi nel vuoto, senza emettere alcun suono. Pareva una scultura vivente. E quando diceva qualcosa, tanto la sua voce quanto le sue parole rilasciavano un’eco la cui traccia sarebbe perdurata anni e anni all’interno della mia mente. Tra tutti i nipoti, solamente io ero in grado di tenergli testa. Non era facile rimanere in empatia con la sua quiete. Non era affatto semplice restarsene muti accanto a lui, domare l’istinto che ti portava alla loquacità. Lo osservavo. Era un bel vecchietto, a suo tempo era stato un bell’uomo. Me ne stavo accanto a lui. «Nonnino, ti somiglio» dicevo tra me e me. E nel far questo, qualcosa di simile all’orgoglio e alla vanità (ma che non erano né l’uno né l’altra) si riversava per tutto il mio cuore.
[…]
Si intrufola nella mia mente un pensiero: che le persone non avvertano, di fatto, la necessità di comunicare. Solo così riesco a dare un senso a quel loro rimanere imbambolate davanti alla tv, oppure al modo in cui si affezionano a discorsi del tutto irrilevanti. Ascolto un professore. I suoi concetti sono di una neutralità assoluta. Eppure sono tutti lì a prendere appunti, come dei deficienti. La sua sintassi è chiara, a lui cosa importa? Sa che verrà ascoltato per due ore esatte, senza essere interrotto. Lo contesto tacitamente per tutta la durata della lezione. È un passatempo dal quale traggo grandi soddisfazioni. Catturo alcuni «pezzi» del suo discorso, poi li giro e rigiro senza tregua, proprio come se fossero i quadratini mescolati e variopinti del cubo di Rubik.
Me ne sto immobile ad ascoltare qualcuno che parla. Il mio origliare è, talvolta, “contemplativo”. Le parole sono come musica: jazz, impromptu, melodie struggenti, romanze, hard rock, effimeri successi sulla cresta dell’onda. Mi rimane impressa, a volte sì e a volte no, la melodia emessa da chi mi sta di fronte. Invadono la mia mente, purtroppo, anche le totali idiozie che rispecchiano la tendenza del momento, come spesso accade. Ascolto. Pratico freneticamente l’arte del silenzio.
[…]
Hai 18 anni. Allo stesso tempo, 28. Circondata da uomini che hanno dimenticato di avere una vita propria. Così un giorno, mi è passata per la testa l’idea di rimproverare qualcuno che parlava «fuori da se stesso». Li riconosco da lontano, quelli che si comportano così. Sono in grado di blaterare a vanvera in merito a qualsiasi argomento; sono forti in ogni campo, loro, sono muniti di «pacchetti preconfezionati» di consigli inutili che riversano a destra e a manca. Il frigorifero della loro mente è sempre colmo di prodotti surgelati, semipronti (che, del resto, ingurgitano in solitudine).
Mi attraversa uno spettro di luce azzurra, metallica. Quando parlo così, tanto per fare, non faccio altro che avvelenare le bizzarre essenze che mi compongono, le quali si ingegnano poi nel trovare ogni sorta di azione vendicativa nei miei confronti (ed è allora che mi ritrovo a commettere gaffes, a complicare le inutilità, a dimenticare cose assolutamente banali o – peggio! – a divenire «stereofonica»). Una tra tutte queste mie essenze, più giovane e meritevole di me, si ribella al mio volere: controbatte. E quando non controbatto, mi rendo consapevolmente infantile. Sconcertata, la gente che ho di fronte si rilassa, mi sorride o se la svigna. Ho imparato a domare, col tempo, quel lato istintivo del mio essere che mi inondava di tristezza ma che, causa la spontaneità dei propri impulsi, aveva sempre ragione. Per ben due volte me l’ha fatta. Stavo prestando orecchio, una volta, alle chiacchiere di certi individui immaginari. Per un attimo, il mio volto è stato pervaso dall’immagine di alcuni uccelli che, a dispetto della loro stupidità, si pavoneggiavano. Me la sono data a gambe. Mi sono sforzata, in seguito, di trovare spiegazioni che giustificassero l’accaduto. La seconda volta mi trovavo per strada, ero parte di un gruppo: ed ecco che mi sento fuori luogo, realizzo di non avere nulla a che fare con tutti gli altri, di trovarmi nel mezzo di un branco di estranei. Scappo via di corsa, tra la meraviglia degli astanti. Qualcuno mi rincorre, cercando di capire cosa mi succede. Come se io lo sapessi! Ora ho un altro modo di fuggire. Balzo, con la mente, in un golfo di silenzio. Tiro un sipario invisibile che mi separa da loro. Poi sogghigno giudiziosa: sono un Buddha con tanto di occhiali.
Ho 16 anni. Leggo. Amo i libri molto più delle persone perché loro, quelli veri, non vogliono convincerti di nulla, non vogliono «avere ragione». Ascolti le loro voci. Se non vi è empatia con la tua voce interiore, puoi chiuderli. E nessuno di loro si arrabbia.
Ho 6 anni. Sono circondata da diverse donne. Ne raccontano di tutti i colori, ridono. Io me ne sto distesa su un divano. Ho sonno. Lascio che le loro voci mi cullino. Mi sento come avvolta da un guscio protettivo, caldo e velato. Non vi è gioia più grande. Vorrei che durasse all’infinito. Mi addormento sempre più lontana, percorrendo un corridoio fragrante e colorato. Ho dieci mamme che vigilano su di me. Tale sorveglianza femminile è qualcosa di incomparabile con quanto di terreno esiste.
Ho 4 anni. Tengo in braccio un enorme pallone giallo. Appoggio la guancia sulla sua superficie. Al suo interno vi è pace. Lì dentro se ne sta rinchiuso, galleggiando, il silenzio che sorreggo nell’arco di un istante. È rotondo il silenzio, e di colore giallo. Lo lascio andare.
Il sonno pomeridiano
[…]
Quando i miei dovevano allontanarsi da casa mi lasciavano dalla zia Marta. Lei mi faceva dormire in una stanza enorme, altissima, e accendeva una fragorosa radiolina dalla quale proveniva una musica sinistra, noiosa, insopportabili melodie sinfoniche e corali, una moltitudine di cori cantilenanti, madrigali, composizioni musicali per fanfara. Non dimenticherò mai il senso di nausea provocato da quella musica mortuaria, il mio sonno tormentato non era sonno: era uno stato di allerta e di attesa, che rendeva triste il fatto di trovarmi in questo mondo, di essere nata perché la zia Marta potesse prendersi gioco di me, costringendomi a vivere come una sventurata mosca finita in una ragnatela impolverata. In momenti come quelli, talvolta accompagnati da un profondo dolore fisico, di tacita disperazione e di disgusto, desideravo che il mondo esplodesse alla stregua di un sacchetto di carta rigonfio fatto scoppiare barbaramente.
Rimanevo con il viso rivolto verso la stanza, fissavo attraverso le mie ciglia tremule tutto ciò che si trovava intorno a me: le sedie, il tavolo, la teca in cui erano riposti solamente tre soprammobili (un gatto grigio, grossolano, un gallo bianco dal becco rosso e un ragazzino con le mutande calate) – le sole cose «umane» in mezzo a bicchieri e servizi da caffè. Osservavo anche la zia Marta, che sonnecchiava oppure lavorava ai ferri un pullover che non riusciva mai a finire. Le mie ciglia sembravano contemplare un film statico, una vecchia pellicola con le pulci, un’immagine velata dalla pioggia. Mi voltavo verso la parete e di fronte ai miei occhi vi era una tela gialla con delle macchie nere dalle svariate forme, punti e linee. Me ne stavo così, ad occhi aperti, a comporre «figure», combinando in diversi modi frammenti di linee e di punti; cercavo di leggere il futuro come dal fondo di un’enorme tazza da caffè. Quella tela gialla era un cielo qualche attimo prima del temporale, in cui fluttuavano scarafaggi, dischi volanti, cani senza testa, bambini senza gambe, giraffe stilizzate, stelle mutilate, funghi, griglie, cerchi, triangoli, orecchini, mestoli, lumache, patate, uova, radici filamentose, ali, profili agghiaccianti. Ogni giorno trovavo qualcosa di nuovo, ogni giorno lo schema generale mutava, comparivano altri oggetti, altre belve, il cielo era a volte paradiso, a volte inferno, fondale oceanico o giardino brulicante. Questa tela era il mio unico amico, mi aiutava a sopravvivere, le sono stata talmente riconoscente che – ecco! – l’ho portata via con me nella mia mente, posso riviverla quando voglio, anche adesso (l’ho già fatto). Avrei scoperto più tardi i dipinti di Miró, di Jackson Pollock oppure di Tanguy; mi piace la parola «tela» per riferirsi ai quadri, in essi amo proprio la tela, la sua consistenza tangibile, la trama in cui si impregnano forme immaginarie. Il mio primo «dipinto», frutto delle mie fantasticherie, era stato, in fin dai conti, un semplice pezzo di stoffa.
Sulla malattia
Giaci sotto la trapunta, hai la febbre alta. Il tuo posto è quello, lì ti senti a tuo agio come un pomodorino nel barattolo dei sottaceti. La tua temperatura corporea ha surriscaldato tutta la stanza. Ti appiccichi, mentalmente, alla parete gelata, per poi ritrarti immediatamente e raccoglierti in te stessa come una mimosa cruda e selvaggia. A letto, la tua consistenza diviene pari a quella del piombo, anche se avverti il tuo corpo come qualcosa di spugnoso: un enorme fardello di spugna carico d’aria. Quando sei fuori a giocare e corri, mentre parli, quando giochi a Uno oppure mentre leggi, il tuo corpo sembra cessare di esistere. Ad esistere sono unicamente la tua voce, i tuoi gesti, le tue parole, il tuo fragore cardiaco, movimenti riflessi, pura dinamica. Ora, sotto le coperte, riesci a percepire l’integrità del tuo corpo, tutto d’un pezzo, che è immenso, scotta ed è gonfio, avvolto da una materia ovattata che sembra essere proprio lui e allo stesso tempo no. Se provi ad alzarti svieni all’istante, un ronzio ti pervade, un disordine che riesce a dislocare gli oggetti all’interno della stanza e a generare asimmetrie. Tutto questo suscita in te una strana voluttà. Sei consapevole che si tratta solamente di un’influenza passeggera e gongoli quando vedi salire la temperatura, sposti la trapunta e il freddo ti attanaglia. Rabbrividisci esternamente e bruci interiormente. L’area più rovente è l’interno della bocca. Arriva la mamma e ti rimprovera perché ti sei scoperta. Ti piace quel rimprovero, come ti piace vederla sistemare di nuovo la trapunta, avvolgendoti del tutto.
Immobilizzata lì dove sei, assisti ad un risveglio che aderisce ad un altro livello. È come se dormissi, ad occhi aperti, su diversi strati...
[…]
Afferro lo specchio. È uno specchio rotondo, di quelli in cui non riesci a vederti la faccia in modo proporzionato, ma mettendo a fuoco una parte per volta. Contemplo a lungo uno dei miei occhi. Vi scorgo un’immensa astuzia. Quell’occhio ride, lo si può notare in maniera molto chiara. Lo conosco bene io, so quando il mio occhio ride e quando invece è triste. Posiziono l’abat-jour accanto a me, sul letto, poi sistemo la parte superiore di vetro rosa, con al centro la lampadina, in modo che punti in direzione della mia bocca spalancata. Cerco nello specchio le mie tonsille grosse e infiammate, ma non riesco a scorgere nient’altro che una lingua impertinente: innalzata verso il palato, cela al suo interno vene rivoltanti, di un colore a metà fra l’indaco e il nero, che solcano un pezzo di carne dalla pelle rossastra. Noto poi anche un «omuncolo» che si contrae di continuo, come un perfetto imbecille. All’interno della grotta carnosa alla quale sta appeso, individuo, ai margini, una tonalità più intensa. Allontano con disgusto lo specchio, tengo la lampada sopra la mia pancia fino a quando non avverto un capogiro, fin quando tutto ciò che è intorno a me non arriva a tingersi di verde, di un verde che migra attraverso le tenebre della stanza. Ho la febbre e ne sono felice. Mi metto di nuovo il termometro: quella maledetta temperatura torna giù, mi delude. Entra anche la mamma, le chiedo un tè e nel frattempo balzo giù dal letto per raggiungere il termosifone e far sì che salga oltre i 39 gradi. Quando la mamma rientra e me lo toglie da sotto l’ascella, svengo quasi dal piacere e dalla pena che provo per me stessa, mentre osservo il suo muso spaventato. La sento sussurrare qualcosa a mio padre, vogliono portarmi all’ospedale. L’ho fatta grossa! Insisto perché aspettino fino a domani, dico loro che me la sento persino di passeggiare avanti e indietro per la stanza.
Ti alzi in piedi e improvvisamente sei colta dalle vertigini, scorgi davanti a te una filigrana nera, rossa e azzurra, che tintinna. Per un attimo sei pervasa dal nero, poi ti scuote una fiamma giallo-violacea. Eccone un’altra sul porpora. Ti fai largo attraverso questi fasci di luce, poi tutto torna alla normalità, e tu pure. Cammini piano, sostenuta da tua madre, sei percorsa dai brividi e li trovi molto carini, li prendi in simpatia, stai tremando, ti battono i denti e ti viene da ridere. È piuttosto strana la sensazione che si prova quando i denti battono in questo modo, di loro iniziativa. Hai un corpo vecchio, rigido, che avanza a fatica e sembra scricchiolare. Osservi quel piccolo essere paffuto che è tuo fratello. È molto grazioso vestito così, tutto di rosa, con i calzini rosa. Somiglia ad un paggetto ciccione, ad un porcellino in carne ed ossa. È così terrorizzato che hai la tentazione di sussurragli all’orecchio che può stare tranquillo, che certo non morirai, ma lo lasci lì a straziarsi, povero piccolo, si comporta così bene ora e per di più sospira anche. Sono così buffi, i bambini a quell’età, quando sospirano. Mi dirigo verso di lui come uno spettro funesto, che batte i denti, e mentre gli accarezzo la testa lui mi chiede se voglio quella bottiglia di vetro che aveva trovato lui ma che io bramavo avidamente. Provo rimorso per tutte le volte in cui gli ho fatto del male, quando lo tiravo per i capelli o per le basettine. Gli rispondo che non voglio nulla, gli chiedo se può mangiare lui tutta la frutta, comprese le fette di limone con lo zucchero (lui adora i limoni, i rusticani e tutta quella robaccia aspra). Mi infilo di nuovo nel letto. Attendo che mi si porti qualcosa di buono da mangiare, come ad un malato che si rispetti. Chiudo gli occhi e rifletto su quali possano essere le mie sembianze vista dall’interno, a partire da quell’immagine sinistra che lo specchio mi aveva rivelato. Supero l’omuncolo, mi dirigo verso l’esofago, infine atterro nello stomaco, dove ci sono pezzi di pere e di pollo, più una scatola di vitamina C. Mi sento male e fuoriesco attraverso la pancia. Immagino le battaglie condotte dai globuli rossi e dai globuli bianchi contro l’esercito dei batteri. «Scivolo» di nuovo nel vuoto. È proprio come quando ti trovi in ascensore o sulla funivia e ad un certo punto – hop! – senti come scivoli in te, come un’onda che ruzzola impetuosa e poi tracolla su se stessa. Dopodiché, una buffa sensazione: il corpo si gonfia, sembra essere costituito da diversi lembi, diversi veli: una pastasfoglia cartacea e porosa. La sensazione diviene sempre più nitida. Non c’è alcun dubbio: sei un gigantesco rotolo di carta igienica! Respiro, mormoro, avvolta in falde enormi e tisiche. Sono sempre io, tanto le falde quanto la mole d’aria che le attraversa. È molto strano. Un rotolo di carta grande quanto la camera, vivo, fremente. E tutto ha luogo all’interno di un’immensa fissità marmorea, di una pace fossilizzata, una calma talmente potente che incute timore. Decisione del momento: voglio andare in bagno. Dopo arriva la mamma, con una bacinella piena d’acqua. Mi sento tutta imbacuccata, con i piedi immersi nell’acqua bollente. Mi hanno dato anche un’aspirina.
Rimango lì a sudare. Ho caldo, e calde sono anche le mie vertigini. Sono un vortice infuocato. Una stanchezza atroce mi riaccompagna sotto la trapunta. Attendo con pazienza la mia espansione; il cervello si scompone in fibre sottili, acquisisce lo spessore di una lamina, il mio corpo è un insieme di petali e sepali infiniti. Il cuscino è profondo, e il materasso un enorme fondo di torta su cui giace un diafano ippopotamo. Atterro con esasperante lentezza e mi sento bene. Poi mi sollevo. Sono la ventola che gira piano in alto sopra il letto, che muove l’aria attorno a sé. Mi assopisco e mi risveglio, poi mi appisolo di nuovo, e così via. Diverse notti in una sola notte. C’è pace attorno a me. Dirigo il mio sguardo verso quell’angolo in cui, nel corso della mia infanzia, soleva apparire un lupo dei cartoni animati, terrificante con quel suo ghigno malefico. È scomparso anche lui da qualche anno a questa parte. Non ho più paura qui, di notte. In camera niente mi incute più timore. Percepisco una strana forza in me, adesso. Potrei sollevare un armadio, sarei in grado di raggiungere la città più vicina pedalando. Nonostante tutto questo abbia luogo dentro di me, lascia delle tracce materiali, dovute a non so quale «imperfezione di sistema». La stanchezza mi spezza e mi attanaglia, mi addormento di nuovo su quell’immenso cuscino morbido. Quando mi risveglio la finestra è di un rosa tendente all’azzurro, ed io, l’albero che freme di fronte a lei.
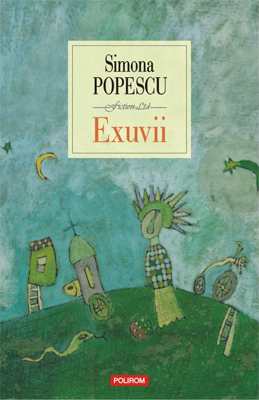
Presentazione e traduzione di Giulia Ambrosi
(n. 7-8, luglo-agosto 2022, anno XII) |
|