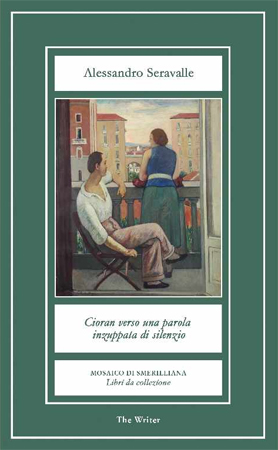|
|||
Con Alessandro Seravalle su «Cioran verso una parola inzuppata di silenzio»
Come musicista ho imparato che sovente il caso e la nostra capacità di reagire creativamente a esso si rivelano una fonte fruttuosa di traiettorie impreviste, foriere di occasioni di sviluppi in direzioni nuove e di meditazioni in grado di modificarci. Anche il mio incontro con Cioran è stato figlio di questa provvidenziale versione del caso. Mi trovavo a casa di Enrico Parisi, un caro amico e compagno di studi, per una cena quando questi mi passò Al culmine della disperazione aggiungendo che il libro probabilmente mi sarebbe piaciuto. All’epoca ero alle prese con una tesi di laurea in filosofia della scienza concernente i rapporti tra realismo e antirealismo alla luce della meccanica quantistica. Tuttora sono estremamente interessato agli sviluppi della fisica e della cosmologia; i miei rapporti con la scienza sono forse l’unico punto di divaricazione tra il mio modo di guardare al mondo e quello dell’autore dei Sillogismi dell’amarezza sebbene, in ultima istanza, io comunque concordi con Cioran quando afferma: «obiezione contro la scienza: questo mondo non merita di essere conosciuto». In ogni caso quella sera fatale aprii a caso il testo e come San Paolo rimasi folgorato sulla via di Damasco. L’aspetto che mi colpii con maggior forza fu l’impressione di leggere, in una versione incomparabilmente superiore, ciò che avrei sempre voluto scrivere. Cioran diventò nel giro di pochi giorni una specie di amico con cui instaurare una relazione intima, proficua e potentemente corroborante. Mandai all’aria la tesi su cui stavo lavorando da anni, contattati e andai a colloquio con Pier Aldo Rovatti che, nonostante o forse proprio perché non aveva mai incontrato l’autore rumeno, accettò la mia proposta di essere il relatore della tesi che avrei elaborato. Trovare il correlatore fu semplice perché lo individuai nella persona di Raoul Kirchmayr che era stato mio compagno di classe alle scuole elementari e alle scuole medie («carriere filosofiche» ben diverse come di tutta evidenza!). Quello che mi preme oggi e che mi spinge a dedicarmi al «mio amico rumeno» è il desiderio (istanza sommamente temibile per Cioran) di restituire qualcosa, una minima parte di quanto ho ricevuto da lui. So perfettamente che può suonare orribilmente retorico ma davvero, in un certo momento della mia vita, Cioran è diventato un’àncora, una «mano tesa», per dirla con l’altro grande mio faro Guido Ceronetti. Non so dire se mi abbia davvero «salvato la vita» ma senza dubbio alcuno l’ha modificata migliorandola con il suo fiele salutare, non ci si sente soli accanto a lui, si sviluppa invece una sorta di «complicità tra lucidi», si può trovare riposo nella sua prosa sterminatrice e sorridere sardonicamente assieme a lui dell’insensato brulichio in cui siamo immersi fino al collo.
«Parola inzuppata di silenzio» è un’illuminante espressione di Edmond Jabès che mi è subito apparsa capace di descrivere la potenza della parola cioraniana. Io credo, ma qui naturalmente siamo nel campo delle mie illazioni, che il Privatdenker di Răşinari, nel suo rincorrere il «silenzio melodioso» (l’ossimoro, altra «trappola retorica per atomi di verità») verso cui nutre un’inconsolabile nostalgia come manifestazione del «tempo prima del tempo», ossia di un tempo non ancora contaminato dalla «caduta», anteriore allo «scandalo della creazione», abbia avuto la capacità, attraverso un paziente e meditato lavoro di scavo, di rendere porose le sue parole allo scopo di iniettarvi generose porzioni di questo «salvifico mutismo». Il paradossale effetto che quest’operazione di scavatura ha sortito è stato quello di rendere le parole straordinariamente efficaci, le parole sono diventate potenti mediante un’opera di apparente indebolimento. Il «silenzio melodioso» conserva infatti la pluripotenzialità del «tempo anteriore al tempo» e a esso si deve l’asintotico avvicinamento della parola cioraniana all’ideale del «concepire un pensiero, un solo e unico pensiero, ma che mandasse in frantumi l’universo». Cioran a mio parere cerca un impossibile ritorno al «silenzio melodioso» e a quel tempo non funesto proprio attraverso la paradossale inserzione del silenzio all’interno delle sue parole. È evidente che l’operazione non può davvero riuscire, l’impossibilità rimane inaggirabile e tuttavia nel mettere in atto tale manovra egli ottiene un effetto terapeutico per sé e per i lettori che riescano a stabilire una connessione autentica con lui. Da qui quel sentimento di complicità cui ho fatto cenno e quel senso di amicizia che provo nei suoi confronti.
Credo che la stessa scienza, quando è supportata da una riflessione su sé stessa, non mostri la pretesa di catturare in modo forte il reale. Se parliamo di cosmologia ad esempio, gli scienziati sono perfettamente consci del fatto che conosciamo, e non in modo del tutto limpido, solo la materia ordinaria (è il famoso modello standard in cui tra l’altro ancora non si riesce a inserire la quarta e più debole delle interazioni fondamentali, la gravità) che contribuisce per circa il 5% a ciò che costituisce il nostro universo (il 95% essendo rappresentato da materia ed energia oscura della cui natura al momento non abbiamo la più pallida idea). Gli attacchi più feroci Cioran li riserva non tanto alla scienza verso cui mi appare tutto sommato piuttosto disinteressato, ma alla filosofia e a quelli che definisce «uomini astratti». Di nuovo, la costruzione d’impalcature sistematiche tipiche di tanta filosofia (a cominciare naturalmente dalla grande tradizione idealistica) è «incompatibile con lo scandalo del respiro» (Cioran usa quest’espressione parlando della lucidità assoluta ma mi andava bene riesumarla in questo contesto). Cioran sembra dirci che dovremmo «abbassare la cresta», prendere coscienza delle nostre dimensioni (che in termini matematici potremmo caratterizzare come «un intorno destro dello zero») e finirla finalmente con l’antropocentrismo e la sua pretesa di dominio incontrastato sulla natura di cui per altro siamo una parte ridicolmente piccola.
Probabilmente no e tuttavia le parole sono più o meno tutto ciò che abbiamo. L’iniezione del «silenzio melodioso» al loro interno le rende più potenti, efficaci, capaci di fornirci una qualche forma di appiglio. E poi, naturalmente, c’è la musica. Non credo sia un caso che Cioran l’amasse così tanto. La musica costituisce un’altra, ancora una volta, paradossale possibilità di accesso a ciò che nutre la nostra nostalgia. La musica, che, contrariamente alla vulgata, non è una forma di linguaggio in senso stretto (il famoso neurologo Oliver Sacks nel suo splendido Musicofilia sostiene che: «la musica non ha concetti, non formula proposizioni») ha nondimeno la capacità di evocare istanze che restano precluse alle parole, è l’altro grande fiume che ci conduce alle sorgenti di noi stessi.
Vi si riesce, o meglio si può tentare di riuscirvi, rinunciando a una concezione forte della parola stessa, indebolendola rendendola così in grado di accogliere al proprio interno porzioni di «silenzio melodioso», allontanandosi dalle affermazioni stentoree, eliminando le lettere maiuscole di concetti dati per acquisiti, coltivando il dubbio in modo pervasivo, assumendo un atteggiamento pudico, cercando non di illuminare con una luce forte e violenta ma di rischiarare discretamente, accettando la nostra (e per inciso dell’intero universo) fragilità. È chiaro che stare sul crinale tra parola e silenzio implica un incessante lavoro di equilibrismo, il rischio di cadere da uno o dall’altro lato è costante. Ancora una volta esce il musicista in me perché la libera improvvisazione creativa si basa proprio su questo continuo pericolo di cadere e, contestualmente, sul fascino che questo tipo di danza sull’abisso porta con sé. Un fascino che permea l’intera opera di Cioran.
Il tema dell’impossibilità è di quelli che si articola con tutti i nuclei del pensiero di Cioran, si tratta di uno snodo decisivo non soltanto sotto il profilo teoretico ma anche e soprattutto di quello esistenziale nel percorso del pensatore rumeno. Qualche breve esempio: la relazione tra illusione e disillusione (in-ludere – de-ludere) come possibilità di entrata e uscita «dal gioco» è caratterizzata appunto da un’impossibilità intrinseca. Cioran cita un non meglio precisato fisico che ha «tradotto» le tre leggi della termodinamica come segue: è impossibile vincere, si è sicuri di perdere, è impossibile uscire dal gioco. Mutatis mutandis l’uscita totale dell’illusorio è fuori portata poiché incompatibile con la vita, l’alternativa essendo tra «mentire» e «morire». E ancora, la relazione con il tempo è connotata dalla stessa impossibilità di uscirne senza risultarne annichiliti (la caduta «dal» tempo), la lucidità stessa, forse la caratteristica prima di Cioran, portata al parossismo risulta impraticabile pena l’abbandono della condizione umana («solo un mostro può vedere le cose per quel che sono», avverte Cioran). Ora, se la parola è il mezzo mediante cui tentare un accesso al «silenzio melodioso» (unica alternativa, la musica) appare chiaro che una reale entrata in quel regno risulta sbarrata. Tutto ciò che si può fare, nella migliore delle ipotesi, è tentare un avvicinamento asintotico a quell’istanza attraverso l’inserzione di porzioni di essa all’interno delle parole stesse. Quello che abbiamo a disposizione, lo spazio che ci è concesso è quello minimo del gioco meccanicamente inteso, lo spazio tra il bullone e il dado, «la nullità del qui e l’inesistenza dell’altrove…schiacciato da due certezze» rappresenta la nostra dimensione. Rainer Maria Rilke parlava di zwischen Dasein («esserci tra»), Fernando Pessoa, ne Il libro dell’inquietudine, propone per la natura umana la seguente definizione: «siamo due abissi – un pozzo che fissa il cielo». Il nostro spazio vitale è insomma di ordine claustrofobico. Il «silenzio melodioso» è perso per sempre, possiamo solo vagheggiarlo, evocarlo o assaporarlo da lontano utilizzando parole porose e «inzuppate di silenzio» ma un ingresso pieno e reale è precluso. Più proviamo ad approcciarci e più si manifesta la resistenza messa in azione dall’impossibilità, una resistenza che si palesa come una sorta di «rallentamento». Così il pensatore transilvano nei Quaderni: «Se non avanzo da nessun punto di vista e non produco niente è perché cerco l’introvabile…» L’origine della musica è in effetti il silenzio. Da grande amante delle esperienze musicali più radicali del secolo scorso (che si continuano a etichettare come «musica contemporanea» in modo direi sorprendente) e da musicista ho voluto inserire nel libro una digressione occupandomi di tre compositori che apprezzo profondamente e del rapporto che la loro musica instaura con il silenzio. Per farla breve, Luigi Nono, nelle estreme propaggini finali della sua carriera, ha utilizzato dinamiche estremamente basse nella speranza, temo andata a vuoto vista la terrificante deriva che la musica ha subito probabilmente a causa del fatto di essere la forma d’arte maggiormente investita dalla mercificazione che il compositore veneziano, da comunista, abborriva, di creare un orecchio nuovo pronto a scendere alle soglie dell’inudibile, di convocare un potenziale «ascoltante» e stimolare un nuovo e più consapevole ascolto (non è un caso che il sottotitolo del Prometeo noniano sia «tragedia dell’ascolto»). Lo statunitense Morton Feldman invece mette in campo una sorta di approccio pittorico al suono, egli era infatti amico personale di molti protagonisti della stagione dell’espressionismo astratto americano cui ha dedicato diverse composizioni (Mark Rothko, Jackson Pollock, Willem de Kooning e Franz Kline tra gli altri). Egli procede come se il silenzio fosse la tela su cui dipingere col suono, quasi bolle sonore che emergono dal silenzio e una volta scoppiate si lasciano ascoltare. Nel caso del transilvano di nazionalità ungherese György Ligeti invece osserviamo un andamento parabolico, in particolare per le sue realizzazioni più «celebri» degli anni ’60 come Atmosphères, Lux Aeterna, Requiem o Lontano: la musica affiora dal silenzio (molte sue composizioni iniziano con diverse misure di pausa), si sviluppa attraverso procedimenti micropolifonici spesso incardinati su clusters (non scendo in dettagli tecnici), raggiunge un’acme e poi lentamente s’inabissa, riconfluisce nel silenzio da cui aveva tratto origine. Da musicista posso testimoniare per esperienza diretta quanto l’interazione con il silenzio risulti decisiva in particolar modo durante i momenti improvvisativi. Naturalmente è una cosa che si acquisisce con l’esperienza, da adolescente tendi a voler suonare a tutti i costi (nefasti effetti dell’egotismo reattivo tipico di quegli anni). Il silenzio e il suono sono presi in un continuo movimento dialettico, la musica è forse una sorta di sintesi di queste istanze che sono tuttavia solo apparentemente antitetiche.
Credo che alla base del «successo» di Cioran (temo che lui ne sarebbe inorridito) vi siano due elementi strettamente connessi tra loro. La sua «onestà», la sua autenticità, la sua salutare volontà di non «indorare la pillola» se non attraverso una forma di umorismo ultra-amaro che lo rende ancora più efficace (così, apro a caso L’inconveniente di essere nati: «alzarsi, lavarsi e poi aspettare qualche varietà imprevista di tetraggine o di sgomento»…a proposito la tecnica di aprire a caso un suo libro, leggere la prima cosa capiti sotto gli occhi e riporre il libro al suo posto è tra le più raccomandabili) genera, ed ecco il secondo elemento, una peculiare forma di amicizia. Come scritto da Ceronetti nella splendida nota introduttiva a Squartamento dal titolo Cioran, lo squartatore misericordioso: «leggerlo è avvertire la presenza di una mano tesa, afferrare una corda gettata senza timidezza, avere alla propria portata una medicina non sospetta». Il piemontese ha saputo, a mio parere, cogliere l’esatta ragione del «successo» di Cioran. Non credo di avere altro da aggiungere.
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone |
|||
 Nel nostro
Nel nostro