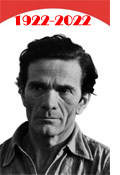|
|
Sciascia e Pasolini: intellettuali, aporie, verità
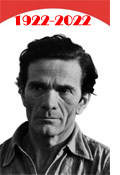 Premessa Premessa
Affronteremo qui solo alcuni aspetti dei molti importanti nell’opera di Sciascia e Pasolini, e con un taglio o uno sguardo per così dire trasversale, enucleando una serie di problematiche, a essi legate, che ci appaiono esemplari per meglio comprendere il nostro Novecento.
Quello che interessa è proporre delle riflessioni e porre dei quesiti che consentano di mettere a fuoco questioni teoriche fondamentali per l’esercizio della Letteratura e, in generale, per la cultura italiana di oggi. Questioni su cui non mi sembra che si mediti sempre abbastanza. In generale, questi due autori sono o amati o rifiutati, Pasolini in specie, ma la loro complessità è tale che gli aut aut poco giovano a comprenderne la molteplicità delle sfaccettature anche contraddittorie, per l’esattezza. Eppure individuarle significa affrontare un percorso di riflessione sulla letteratura che tocca profondamente anche le generazioni odierne. Pertanto, più che a una trattazione sistematica si mirerà a prendere in esame solo i nodi che continuano a riguardarci nel bene e nel male.
Nel bene Pasolini e Sciascia sono due personalità luminose che, rilanciando alcuni valori, come la libertà, la capacità di vedere il mondo attraverso la lente delle arti, indicano la strada del coraggio intellettuale e dell’urgenza di dare alla letteratura quanto spetta alla letteratura («Date a Cesare»…), e che le è stato invece tolto da un secolo e più di decadentismo e di suoi residui epigonali [1]. Nonostante il loro sguardo sulla realtà divenga sempre più pessimistico, continuano a credere nella necessità di pronunciare comunque la parola – una parola abitata da uno slancio etico – e di opporsi al mondo attraverso di essa. Proprio per questo pieno, per il confidare nei valori del significato, di cui si fa garante chi quella parola pronuncia, con l’intera sua persona, l’intera sua vita stessa, Sciascia e Pasolini ci parlano ancora oggi con un accoramento e una forza di verità che non possiamo non sentire nostra.
Nel male vi sono contraddizioni concettuali da sciogliere, evitando, soprattutto per Pasolini, di cadere nel ‘tranello’ psicologistico, implicito nella parte IV del componimento Le ceneri di Gramsci, che dà il titolo all’omonima raccolta:
Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere
con te e contro te; con te nel cuore,
in luce, contro te nelle buie viscere;
del mio paterno stato traditore
– nel pensiero, in un’ombra di azione –
mi so ad esso attaccato nel calore
degli istinti, dell’estetica passione;
attratto da una vita proletaria
a te anteriore, è per me religione
la sua allegria, non la millenaria
sua lotta: la sua natura, non la sua
coscienza; è la forza originaria
dell’uomo, che nell’atto s’è perduta,
a darle l’ebbrezza della nostalgia,
una luce poetica: ed altro più
io non so dirne, che non sia
giusto ma non sincero, astratto
amore, non accorante simpatia...
Come i poveri povero, mi attacco
come loro a umilianti speranze,
come loro per vivere mi batto
ogni giorno. Ma nella desolante
mia condizione di diseredato,
io possiedo: ed è il più esaltante
dei possessi borghesi, lo stato
più assoluto. Ma come io possiedo la storia,
essa mi possiede; ne sono illuminato:
ma a che serve la luce? [2]
Pasolini parla della «forza originaria // dell’uomo, che nell’atto s’è perduta»; sistematicamente, e in un modo che quasi non ammette repliche, spostando il discorso sul piano vitalistico («nelle buie viscere», «nel calore / degli istinti», «la sua natura, non la sua / coscienza» ecc.) e personalissimo dei sentimenti («l’ebbrezza della nostalgia», «giusto ma non sincero, astratto / amore, non accorante simpatia» ecc.), e ponendo ciò in contraddizione con l’ideologia: intesa secondo lo storicismo marxista e anche come falsa coscienza. In un tale aut aut (d’ascendenza binaria, dialettica), Pasolini evita di affrontare una serie di questioni cruciali, che dovrebbero rimanere sul piano rigoroso della forma, in cui tutto – puro e impuro – confluisce e viene vagliato nella coerenza dell’opera d’arte: tecnica esterna ed interna, verifica logico-razionale dei significati, argomentazione critica e autocritica ecc. L’estetica di Benedetto Croce sembra ancora agire in Pasolini. L’arte come intuizione ed espressione pura, come conoscenza prelogica, in cui la sovversione irrazionale irrompe come a oscurare il discorso, a impedire qualsiasi distinzione di arte e vita o, meglio, «viscere»: vitalità nella sua esplosiva potenza e dolore, carattere religioso e visionario e amarezza dentro un mondo deprivato [3]. Nella battaglia titanica che il Bene (i valori dell’antica civiltà pre-consumistica) combatte contro il Male di una «civiltà morta» e i suoi «servitori», il poeta si trasfigurerà nel Cristo, nella vittima sacrificale per eccellenza, poiché non potrà non continuare a rendere la propria testimonianza [4].
Pasolini è stato un critico notevole, attento agli sviluppi delle poetiche in atto del suo tempo, eppure ha fatto saltare così quel nesso di relazione e scambio continuo fra autonomia ed eteronomia della letteratura (per usare termini di Luciano Anceschi [5]); e non ha compreso fino in fondo quanto la sua posizione sia nutrita di residui romantici. Per prima cosa, nel proporre come indiscutibile la tesi che il mondo industrializzato contemporaneo sia inumano o anti-umano: idea che riecheggia la visione della Storia di Spengler [6], ma anche dei francofortesi da Adorno in poi. In realtà, anti-umane, o inumane, sono in un modo specifico tutte le epoche della Storia in cui una cultura voglia affermare una istanza umanistica. Compito della letteratura, dell’arte, però, dovrebbe precisamente essere quella di riaffermare tale istanza e di rappresentare l’inumano immettendovi un orizzonte alternativo di umanità. Ma quale prospettiva il vitalismo può mai aprire alla Storia, se non quella circolare di rimandare di continuo a se stesso?
Nel male, insomma, quella forza di verità, a cui accennavamo in precedenza, consente che ambedue gli autori possano indicarci gli errori da non ripetere, errori gravidi di significati; e impartiscono una lezione magistrale, perché si impara solo nel confronto con i maggiori e i migliori: coloro che, come Sciascia e Pasolini, hanno vissuto la letteratura, sono stati scrittori, non che hanno fatto letteratura o gli scrittori.
Entrambi hanno cercato di elaborare una visione del mondo, di costruire un universo concettuale in grado di attribuire profondità alla scrittura. Hanno cercato di non delegare tale compito ad altre discipline e più specifiche, da cui importare e di cui ricalcare magari le idee invece di verificarle. Non volevano deresponsabilizzare se stessi e la letteratura, esonerandola dal pensare il mondo in modo proprio.
Non ci si meraviglia che la letteratura abbia un posto sempre meno centrale nella cultura contemporanea. L’esempio di Sciascia e Pasolini richiama alla forza di essere inattuali, come inattuali ma limpide risuonarono le loro due voci.
Cenni su un’amicizia
Pasolini e Sciascia si sono subito riconosciuti e stimati. Pasolini recensì il libro d’esordio di Sciascia, Favole della dittatura, in «La libertà d’Italia», 9 marzo 1951. Le ventisette favole erano state edite a Roma, nel 1950, in duecentoventidue copie numerate dall’editore Bardi [7] e per la cura del poeta Mario dell’Arco [8]. Pasolini colse subito la parentela con le favole del mondo classico, e l’alone metafisico «di pagine così lievi», in una «lingua così ferma e tersa»: «un gusto della forma chiusa, fissa, quasi ermetica» e «un fondo di amarezza», in cui «l’elemento greve, tragico della dittatura [...] è trasposto tutto in rapidissimi sintagmi, in sorvolanti battute che però possono far rabbrividire», e attraverso cui «Sciascia condanna, nel ricordo, quei tempi di abiezione».
La letteratura, la cura della pagina, come denuncia e battaglia civile, dunque; e, aggiungiamo noi, l’idea tutta manzoniana che la letteratura può colmare i vuoti della storia, quello che essa non ci dice, come si evince dalla epigrafe consistente in una frase di Longanesi: «Gli storici futuri leggeranno giornali, libri, consulteranno documenti di ogni sorta, ma nessuno saprà capire quel che è accaduto. Come tramandare ai posteri la faccia di F. quando è in divisa di gerarca e scende dall’automobile?».
Nell’articolo Ero il solo con cui potesse parlare, del 3 novembre 1975, uscito su «L’Ora» di Palermo all’indomani dell’assassinio di Pasolini, Sciascia ne aveva sottolineato la sagacia del giudizio critico quasi «sapendo quello che avrei scritto dopo, fino a oggi», e ricordato l’affetto amicale, la condivisione delle idee e le tappe di un amicizia importante, che Collura ricostruisce nei suoi passaggi essenziali. Sciascia ora si sentiva solo [9]; non sarà un caso se il libro che cambierà la sua vita di scrittore, L’affaire Moro (1978) – sul sequestro e l’assassinio dello statista che sono tuttora avvolti da troppi misteri –, si apra e si chiuda nel nome di Pasolini, come è stato più volte notato [10]. Sciascia ha dichiarato in una intervista rilasciata a Lietta Tornabuoni: «Ho cominciato ad avere paura dell’immaginare. Se dieci anni prima mi avessero detto che Moro avrebbe cambiato la mia vita, avrei riso: invece è stato così. Dopo la morte di Moro io non mi sento più libero di immaginare. Anche per questo preferisco ricostruire vicende già avvenute: ho paura di dire cose che possono avvenire» [11].
Per la cura dell’amico, che ne stimava molto la poesia, Pasolini avrebbe pubblicato a Caltanissetta, nel 1954, presso la casa editrice di Salvatore Sciascia (nei Quaderni di Galleria), la silloge di versi Dal diario (1945-1947). Il volume sarebbe stato riproposto nel 1979 in seconda edizione presso il medesimo editore, con illustrazioni di Giuseppe Mazzullo e una Introduzione di Sciascia, che vi rievocava la nascita della collana, l’attività di quegli anni e come si era giunti alla pubblicazione dei versi pasoliniani. Da allora la stretta collaborazione fra i due amici avrebbe portato anche alla formazione del gruppo di autori poi riunitisi intorno alla rivista bolognese «Officina» (1955-1959). Infine i rapporti si erano diradati, ma non era venuta meno l’amicizia. Sciascia ha dichiarato in Nero su nero:
Io mi sentivo sempre un suo amico; e credo che anche lui nei miei riguardi. C’era però come un’ombra tra noi, ed era l’ombra di un malinteso. Credo che mi ritenesse alquanto – come dire? – razzista nei riguardi dell’omosessualità. E forse era vero, e forse è vero; ma non al punto da non stare dalla parte Gide contro Claudel, dalla parte di Pier Paolo Pasolini contro gli ipocriti, i corrotti e i cretini che gliene facevano accusa. E il fatto di non essere mai riuscito a dirglielo mi è ora di pena, di rimorso.
Io ero – e lo dico senza vantarmene, dolorosamente – la sola persona in Italia con cui lui potesse veramente parlare. Negli ultimi anni abbiamo pensato le stesse cose, dette le stesse cose, sofferto e pagato per le stesse cose. Eppure non siamo riusciti a parlarci, a dialogare. Non posso che mettere il torto dalla mia parte, la ragione dalla sua. E voglio ancora dire una cosa, al di là dell’angoscioso fatto personale: la sua morte – quali che siano i motivi per cui è stato ucciso, quali che siano i sordidi e torbidi particolari che verranno fuori – io la vedo come una tragica testimonianza di verità... […] Da quando non c’è più lui mi sono accorto, mi accorgo, di parlare più forte. Non mi piace, ma mi trovo involontariamente a farlo [12].
Nel 1957, nello scritto La confusione degli stili, nel 1960 raccolto in Passione e ideologia, Pasolini era tornato a parlare anche del volume Le parrocchie di Regalpetra (1956), «in cui la ricerca documentaria e addirittura la denuncia si concretano in forme ipotattiche, sia pure semplici e lucide: forme che non soltanto ordinano il conoscibile razionalmente (e fino a questo punto la richiesta marxista del nazionale-popolare è osservata) ma anche squisitamente: sopravvivendo in tale saggismo il tipo stilistico della prosa d’arte, del capitolo»13. Infine, il 24 gennaio 1975 il poeta di Casarsa recensirà con entusiasmo anche il romanzo Toto modo (1974) su «Tempo», il settimanale milanese:
Questo romanzo giallo metafisico (scritto tra l’altro magistralmente, come diranno i futuri critici letterari ad usum Delphini, perché Todo Modo è destinato a entrare nella storia letteraria del Novecento come uno dei migliori libri di Sciascia) è anche, credo, una sottile metafora degli ultimi trent’anni di potere democristiano, fascista e mafioso, con l’aggiunta finale di cosmopolitismo tecnocratico (vissuta però solo dal capo, non dalla turpe greggia alla greppia). Si tratta di una metafora profondamente misteriosa, come ricostituita in un universo che elabora fino alla follia i dati della realtà. I tre delitti sono le stragi di Stato, ma ridotte a immobile simbolo. I meccanismi che spingono ad esse sono a priori preclusi a ogni possibile indagine, restano sepolti nell’impenetrabilità della cosca, e soprattutto nella sua ritualità [14].
Così, quella complementarità fra i due che si era venuta definendo negli anni era ancora più evidente: l’uno aveva principalmente scelto la poesia e la multimedialità – il giornalismo, il cinema – per condurre le proprie battaglie contro le forze oscure del potere e il genocidio culturale; l’altro continuava a scrivere romanzi o comunque narrazioni dagli statuti aperti in cui rappresentare quelle zone d’ombra e di corruzione della società italiana. Senza di loro non avremmo oggi chiaro il punto da cui l’Italia potrebbe ripartire nella direzione di una più efficace azione politica e culturale, per rinnovarsi, se solo lo volesse.
Letteratura, conoscenza, verità
Sciascia e Pasolini sono due voci esemplari del Novecento italiano, delle verità lucidamente còlte e delle loro contraddizioni, voci che possono insegnarci tanto per evitare alcuni errori della cultura contemporanea e quella sua certa deriva – nella riduzione della letteratura a merce esclusiva, a spettacolo, a cronaca –, tra il superficiale e il volgare, che sembra connotare i nostri anni.
Due voci critiche dell’Italia nei tre/quattro decenni dopo la fine della Seconda guerra mondiale: diverse e per alcuni aspetti simili o complementari. Umanamente Sciascia e Pasolini erano agli antipodi: l’uno che «non ballò mai, non diede mai un calcio a un pallone, non guidò mai un’auto, non mise piede su una barca da diporto, non fece un bagno in mare» [15]; l’altro amante del ballo16, delle belle auto, e sportivo, soprattutto un calciatore («Dopo la letteratura e l’Eros, per me il football è uno dei grandi piaceri», dichiarò a Enzo Biagi [17]); forte nuotatore e proprietario, insieme con l’amico pittore Giuseppe Zigaina, della barca a vela e a motore Edipo Re.
Tuttavia, Sciascia e Pasolini furono entrambi scrittori, saggisti, giornalisti-polemisti, poeti, drammaturghi, traduttori [18], amanti del cinema (l’uno come spettatore, l’altro dietro la macchina da presa): nord e sud d’Italia, oramai non più scindibili. Giova però ribadirlo: nessuno e niente, in apparenza, sembrava più lontano dell’uno dall’altro, malgrado la vicinanza di età. Leonardo Sciascia era maggiore di Pier Paolo Pasolini di soli quattordici mesi: il primo era nato l’8 gennaio 1921 a Racalmuto, in un piccolo paese in provincia di Agrigento; il secondo a Bologna il 5 marzo 1922. Sciascia in una famiglia piccolo-borghese: sarebbe stato un maestro elementare fino al 1957, poi impiegato in un patronato scolastico, principalmente vivendo nella sua Sicilia e dividendosi fra Palermo (dove morirà il 20 novembre 1989) e la stessa Racalmuto, dove trascorrerà estati tranquille insieme con la sua famiglia, studiando, scrivendo e incontrando gli amici più cari.
Fa dei soggiorni a Parigi, dei viaggi in Spagna [19], in Svezia (sempre in treno), ovviamente in Italia quando ne ha l’opportunità, ma la Sicilia resta la sua terra, quella del suo personale viaggio per oltrepassare le varie colonne d’Ercole letterarie, conoscitive, che è normale incontrare se si è scrittori di razza:
C’è stato un progressivo superamento dei miei orizzonti, e poco alla volta non mi sono più sentito siciliano o, meglio, non più solamente siciliano. Sono piuttosto uno scrittore italiano che conosce bene la realtà della Sicilia, offre la rappresentazione di tanti problemi, di tante contraddizioni, non solo italiani, ma anche europei, al punto da poter costituire la metafora del mondo odierno [20].
Pasolini era nato in una famiglia di nobili ascendenze, per parte di padre: un genitore la cui condotta ne avrebbe causato la rovina. Pasolini era laureato e, dopo il noto scandalo sessuale di Ramuscello, si sarebbe trasferito a Roma, per diventarvi, fra le altre cose, scrittore e regista cinematografico, peraltro non raramente al centro di controversie legali per le reazioni che suscitavano le sue opere, e per vivervi irrequieto, amando viaggiare, condividere l’intimità, negli ultimi tempi violenta, con giovani se non proprio giovanissimi [21]. Il Friuli resterà per lui la terra della madre amatissima, del fratello ucciso nell’eccidio di Porzûs, della giovinezza, dell’incanto e della scoperta della poesia:
nostalgia e rimpianto di un bene perduto. «Per me, gran parte del futuro è passato; neppure una delle arrese, dei desideri, si è realizzata», dichiara ancora nel 1973 [22].
Eppure, due idee, anzi due ideali profondamente condivisi hanno affratellato Sciascia e Pasolini, lasciandone una testimonianza vitale per le nostre generazioni: il credere nella letteratura e il vivere la letteratura come modo per pensare il mondo, per opporglisi se non cambiarlo; il farne uno spazio, se non un filtro intellettuale attraverso cui distillare l’esperienza [23]. In breve, ferma restando la dimensione espressiva della letteratura o dell’arte, sia Pasolini sia Sciascia hanno cercato di restituirle anche quella che la letteratura ha sempre avuto principalmente da che ne abbiamo memoria, ossia la dimensione conoscitivo-argomentativa (da non confondere con il cronachismo): quella stessa che la cultura decadente, privilegiando l’intuizione, la percezione delle corrispondenze segrete fra le cose, aveva posto in una dimensione subordinata rispetto a quella espressiva. Letteratura come espressione e conoscenza, pur non senza aporie, come vedremo più avanti.
Se per Sciascia tale tensione, già presente fin dagli esordi, è assai palese specie a partire dagli anni settanta, nei suoi libri che potremmo definire variamente “d’inchiesta”, è un fatto che gli sviluppi poematici della poesia di Pasolini, da Le ceneri di Gramsci in poi, meglio si comprendono in un quadro in cui la poesia può diventare espressione delle urgenze interiori dell’io e, allo stesso tempo, discorso senza alcun senso di inferiorità nei confronti dell’ideologia e anche di altri campi della cultura umana, come l’economia e la politica [24].
Conoscendo diversamente, ma al pari degli altri linguaggi, la letteratura può parlare di tutto. Sia Pasolini sia Sciascia sono accomunati dallo slancio di cercare di conoscere il vero dei fatti per poter affermare a voce spiegata quella che ritengono in coscienza sia la loro verità, anche se impopolare; e sono accomunati dalla convinzione che il linguaggio della narrativa, per l’uno, e della poesia (e pure del cinema), per l’altro, non è superabile o sostituibile. La narrativa per Sciascia e la poesia per Pasolini diventano pertanto discorso riflessivo: le parole nella loro lettera, non simboli di simboli intellettualistici di alienazione o altro, bensì strumenti concettuali per capire, definire, dire, per fissare significati.
Non a caso, un intellettuale come Quadrelli ha osservato per Pasolini – ma il discorso può ben valere anche per l’ostinazione a capire e indagare i fatti, tipico dello Sciascia più maturo – che egli «ha rivendicato, dantescamente, il diritto della poesia a essere poesia totale» [25]. Ciò ha tanto più valore culturale in quanto è piuttosto la linea petrarchesca, quella di ripiegamento dell’io, in un dominio di elegia, malinconia, automacerazione, insomma di ipersoggettivismo, a essersi affermata in maniera maggioritaria nel Novecento italiano [26]. Simili aspetti non mancano nel discorso poetico di Pasolini, ma quel «diritto» è giustamente rivendicato, e va principalmente inteso come volontà di immettere nel discorso poetico materiali non solo ed esclusivamente lirici.
La letteratura afferma un’esigenza di totalità, non può essere identificata con l’assoluto [27], e Pasolini e Sciascia lo sapevano bene. La totalità della poesia è quella che abbraccia discorsivamente l’interezza dell’umanità del soggetto e immette nel mondo una possibilità di mediazione, una apertura di possibilità altre di realtà. È però anche vero che i saperi che confluiscono nella scrittura e nella poetica di Pasolini, e anche in quelle di Sciascia, sono parziali: pochi quelli scientifici; anzi, Pasolini condanna lo sviluppo industriale, la politica, la tecnologia e la chimica, che, insieme, avrebbero causato la sparizione delle lucciole (nel noto articolo Il vuoto del potere, in «Corriere della Sera», 1° febbraio 1975).
Allora come è possibile che la poesia, la letteratura, possano esprimere una tale esigenza di totalità, se alcuni o molti saperi sono esclusi dal loro ambito di verifica dei significati?
La conoscenza ne risulterà così dimidiata, mentre si afferma l’importanza dell’aspetto analitico-conoscitivo. La contraddizione è evidente.
Bisogna però anche osservare che tale aspetto analitico-conoscitivo si unisce strettamente in Sciascia e Pasolini a quello soggettivo, che implica una visione della vita e significati intenzionali, qualcosa che riguarda in profondità il singolo e lo scrittore come tali. In breve, per i nostri autori, le cose, il mondo non sono solamente un nodo conoscitivo, piatta mimesi; e ciò significa per entrambi fare i conti, cosa tutt’altro che facile, con alcune remore neorealistiche, con i concetti di realtà e realismo, di realtà e sogno, di realtà e linguaggio: tematiche che non possiamo approfondire in questa sede, ma che furono ben presenti, ad esempio, al Pasolini dei saggi Il neo-sperimentalismo (1956) e La libertà stilistica (1957). E, quanto a Sciascia, è evidente che il recupero fin da subito della favola, dell’apologo e dell’ironia, e la frequente mescolanza dei generi, scaturivano proprio dalla volontà di reagire alle semplificazioni formali del neorealismo per immettere nella scrittura una tensione critica e soggettiva più vibrante.
Qui conta dire che letteratura e verità diventano un binomio inscindibile, ed è questo uno dei lasciti più vitali delle opere di Sciascia e Pasolini. Il primo dirà: «E che cos’è uno scrittore? Da parte mia ritengo che uno scrittore sia un uomo che vive e fa vivere la verità, che estrae dal complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia – per sé e per gli altri – il piacere di vivere. Anche quando rappresenta terribili cose» [28]. Per ribadire subito:
«Lo scrittore rappresenta la verità, la vera letteratura distinguendosi dalla falsa solo per l’ineffabile senso della verità. Va tuttavia precisato che lo scrittore non è per questo né un filosofo né uno storico, ma solo qualcuno che coglie intuitivamente la verità. Per quanto mi riguarda, io scopro nella letteratura quel che non riesco a scoprire negli analisti più elucubranti, i quali vorrebbero fornire spiegazioni esaurienti e soluzioni a tutti i problemi» [29].
Così Sciascia riaffermava un rapporto fra piacere e cultura, piacere e letteratura, piacere e conoscenza che sembrava costituire pure una risposta indiretta all’Elio Vittorini delle «due tensioni», che proprio tale piacere (definito «mistico-estetico»), nei fatti, negava, anche in nome di un romanzo «a discorso congetturale» e scientifico [30]. Pasolini, a un’altra domanda o, piuttosto, constatazione di Biagi, che gli diceva: «Lei è instancabile.
Poesie, sceneggiature, saggi, dibattiti, viaggi; sembra quasi un’ossessione», rispondeva significativamente: «Se non lavoro sono triste» [31].
E, ancora, per Pasolini secondo cui la verità è tutto ciò che è autentico, non alienato dall’ingranaggio dell’omologazione, la verità stessa diventa (quella del)la poesia/arte, la vita che assume su di sé, in sé, la gioia di goderne e il dolore della catastrofe; e grida la verità [32], la denuncia: denuncia a voce spiegata la rovina della Storia italiana e occidentale, per giungere ad affermare che «il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia» [33].
La storia: popolo, dialetto
Sia Pasolini sia Sciascia sono stati fra coloro che, schierati con il partito comunista o comunque a esso vicini, tra gli anni cinquanta e sessanta, hanno preso le distanze dalle teorie ottimistiche della Storia di chi coglieva nel presente solo un progresso continuo e vantaggioso. In ciò, al di là delle differenze specifiche sulle quali non possiamo indagare
qui più a fondo, finivano con l’avere qualcosa in comune con il pensiero – espresso in articoli e nel volume Credere e non credere (1971) – di Nicola Chiaromonte, che comunista non lo era mai stato e che risultava per questo una personalità ancora più scomoda per la cultura italiana [34]. Per Sciascia, che non aveva certo bisogno di suggerimenti, ma che era sempre pronto a leggere, ad ascoltare e dialogare, potrebbero in particolare essere stati fertili, lo vedremo meglio più avanti, alcuni aspetti della riflessione di Chiaromonte sul giusto e l’ingiusto. Lo stesso Chiaromonte aveva rivolto critiche precise ai giovani del Sessantotto e alle loro proteste (di cui pure riconosceva delle ragioni) in alcuni memorabili articoli, come ad esempio La rivolta degli studenti o A lume di ragione, pubblicati nella rivista «Tempo presente», del marzo-aprile 1968 [35]. Con argomenti che sarebbero stati in più casi pure di Pasolini, in essi denunciava le istanze piccolo-borghesi del «ribellarsi contro tutto e contro nulla», le blandizie di politici e intellettuali rivolte a quei giovani, il loro «impulso di violenza che fatalmente accompagna l’idea di ottenere immediatamente e per via d’azione diretta ciò che – riforma della scuola o riforma della società – immediatamente e per via d’azione diretta ottenere non si può»; e «le idee prefabbricate e le formule fisse», il binomio di potere e irresponsabilità, la confusione tra l’idea di «potere studentesco» e «quella del potere sociale in senso lato». Critiche analoghe saranno, qualche tempo dopo, rivolte al movimento studentesco anche da una intellettuale rigorosa, a torto poco ricordata, come Edoarda Masi [36].
Per tornare a Pasolini, neanche lui aveva bisogno di spinte esterne, ma era pur sempre pronto a confrontarsi con il pensiero degli altri. Perciò non possono non colpire alcune consonanze di reazione con Chiaromonte, quando il poeta di Casarsa pubblicava su «L’Espresso» del 16 giugno 1968 gli ormai famosi versi de Il Pci ai giovani!!, nel 1972 riediti con alcune varianti in Empirismo eretico:
È triste. La polemica contro
il Pci andava fatta nella prima metà
del decennio passato. Siete in ritardo, figli.
E non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati...
Adesso i giornalisti di tutto il mondo (compresi
quelli delle televisioni)
vi leccano (come credo ancora si dica nel linguaggio
delle università) il culo. Io no, amici.
Avete facce di figli di papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete paurosi, incerti, disperati
(benissimo!) ma sapete anche come essere
prepotenti, ricattatori e sicuri:
prerogative piccolo-borghesi, amici.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti!
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da periferie, contadine o urbane che siano. [37]
Nella visione progressiva del reale propria di Hegel, la storia è realizzazione sotto specie sensibile del cammino dello Spirito, incessantemente e inesorabilmente teso a un perfetto ricongiungersi con se stesso attraverso il processo dialettico. Il positivismo, influenzato principalmente dalle teorie di Charles Darwin, ha fatto poi il resto: la storia è stata identificata con il processo stesso dell’evoluzione, vista come moto ascensionale e percorso cumulativo di avanzamento e civiltà. Se però il tempo (dal latino tempus, l’antica operazione di infiggere il temo, il chiodo, nel lato destro del tempio di Giove Massimo: accumulazione dei «chiodi», uno dopo l’altro, che dà conto della visione lineare, cumulativa e progressiva di tempo e temporalità storica nel mondo romano, ripresa in età moderna dall’idealismo romantico) è qualcosa che inesorabilmente fugge in avanti, accumulo progressivo di quantità temporali sempre maggiori e di momenti di «sintesi» dialetticamente sempre più compiute, l’oggi è di necessità più perfetto e più ricco dello ieri, e il domani lo sarà rispetto all’oggi. Per essere nel tempo, bisogna perciò seguirne incessantemente il flusso, non perdere il «treno» di una presunta Storia, che diventa però tutt’uno con la cronaca e la novità. In tale processo il passato è destinato a perdersi per sempre o a tornare solo sotto forma di vuota e ornamentale citazione, di decoro museale, perché ormai «superato» [38].
La sensibilità e l’onestà intellettuale di Sciascia e Pasolini li hanno indotti a focalizzare l’attenzione sulla insufficienza dell’azione politica, sulle contraddizioni economiche dell’Italia del tempo: su coloro che sono socialmente indifesi. Le «magnifiche sorti e progressive» lasciavano nell’abbandono e nello spregio ideologico il sottoproletariato politicamente inconsapevole delle borgate romane, la Sicilia in mano alla mafia, i deboli in mano a una giustizia ingiusta. Sciascia dirà:
Intorno al 1963 si è verificato in Italia un evento insospettabile e forse ancora, se non da pochi, sospettato. Nasceva e cominciava ad ascendere il cretino di sinistra: ma mimetizzato nel discorso intelligente, nel discorso problematico e capillare. Si credeva che i cretini nascessero soltanto a destra, e perciò l’evento non ha trovato registrazione. Tra non molto, forse, saremo costretti a celebrarne l’Epifania. [39]
Sciascia alludeva a un periodo cruciale: quello del primo governo di centrosinistra, con le sue aperture e i suoi programmi di riforme. Allora il cosiddetto miracolo economico, che pure aveva portato a una positiva redistribuzione del reddito, mostrava di non essere più tanto straordinario ed emergevano corruzione e affari illeciti. Cominciavano anzi a saldarsi in un nodo ancora più avviluppato interessi della classe imprenditoriale più retriva e razziatrice con la politica e altre forze nell’ombra [40].
Pasolini scriverà a Italo Calvino: «Risulta evidente […] che tu ti appoggi a certezze che valevano anche prima. […] Le certezze laiche, razionali, democratiche, progressiste. Così come sono esse non valgono più. Il divenire storico è divenuto, e quelle certezze son rimaste com’erano» [41]. Una filosofia della Storia animata da un principio razionalistico rivelava dunque la sua inadeguatezza, la sua falsità: contro di essa doveva risuonare alta e ferma la voce della letteratura e degli intellettuali. Contro. Pasolini contro «il centralismo della civiltà dei consumi», «l’omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza», contro la televisione, contro la classe politica, contro l’aborto.
Contro certo sperimentalismo neo-avanguardista [42]. E per parte sua Sciascia, alla domanda di una intervistatrice: «Qual è il posto e il compito di uno scrittore nella società moderna?», aveva risposto: «Per quello che mi riguarda, quello di guastare il giuoco. L’enorme giuoco a incastro in cui il potere, in ogni parte del mondo, si realizza» [43].
Ne scaturiva una posizione eroica e anche tragica in Pasolini, amaramente ironica in Sciascia: d’altronde è stato Friedrich Nietzsche a sottolineare come il comico sia il rovescio del tragico.
Tuttavia, proprio in un simile slancio di contrapposizione risiede una delle aporie del loro pensiero, che riguarda l’idea di Storia che entrambi seguivano: che non escludeva la nozione di progresso in sé o come tale, come dimostrano del resto tutte le loro battaglie civili, bensì denunciava l’assolutezza (falsa) del vincolo stabilito da certe interpretazioni ideologiche fra processo storico e progresso. Il presunto procedere lineare e cumulativo della Storia non veniva controbattuto in sé: se ne negava l’idea di una ragione positiva, frutto del progresso e generatrice di progresso, ma, precisamente, non la natura in sé, che restava appunto di accumulazione e di successione rettilinea. Su questa Sciascia e Pasolini, ma più Pasolini che Sciascia in verità (che della ragione illuminista faceva un faro), modellavano anche la visione della storia della letteratura, quindi il loro operato di scrittori. In breve, l’errore teoretico di Pasolini in specie era quello di restare appunto legato a una visione di tempo lineare e cumulativo, che era ancora quella della fisica classica e che lo induceva a identificare la Storia con la Tradizione e la Tradizione con il Canone. Simili categorie erano date per a priori, come risulta anche dalle pasoliniane Poesie mondane, nella fattispecie dai notissimi versi:
Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l’Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,
dall’orlo estremo di qualche età
sepolta. Mostruoso è chi è nato
dalle viscere di una donna morta.
E io, feto adulto, mi aggiro
più moderno di ogni moderno
a cercare fratelli che non sono più. [44]
Eppure la teoria della relatività di Einstein e la moderna fisica, la nuova biologia, la psicanalisi di Freud e Jung, l’antropologia, la linguistica, l’estetica di Dino Formaggio e Mikel Dufrenne avevano prepotentemente posto l’attenzione anche sulla durata temporale, sulla permanenza, sulla sincronia, sulla complessità del fare artistico. La percezione di una simile molteplicità che riguarda tutte le creazioni umane, Storia non esclusa, avrebbe contribuito a non far confondere Storia e Tradizione, bensì a intravedere nella Storia la plurivocità delle tradizioni culturali, visioni del mondo storicamente date, risultato di negoziazioni culturali da meditare, arricchire incessantemente, mutare, rivivificare se necessario. Così il passato non sarebbe diventato lacerazione, intima incertezza nel rimpianto – non si può non pensare al Carducci pasoliniano, «che produce sotto questa spinta […] i suoi capolavori»! [45] –, bensì un sistema di segni ricco di significati e un patrimonio di esperienze vissute, da salvaguardare e a cui attingere per condurre la proprie battaglie culturali [46]. La prediletta Parigi, ideale prima che reale, la «città-libro», il perseguire una ragione intellettualistica che oramai è comune definire neoilluministica, rappresentano per Sciascia un modo per reimpossessarsi di un certo passato. Niente infatti è «sorpassato», ma ogni esperienza è sostituibile: non vi è alcuna intima, noumenica necessità animatrice della storia letteraria. Essa procede per discussioni e soluzioni, per proposte più o meno felici che, in un dato momento storico, possono affermarsi in grazia di ragioni retoriche particolarmente apprezzate da certi ambienti culturali e sociali o in certi gruppi di potere.
In Pasolini una visione più statica del passato si traduceva nell’urgenza di considerare il dialetto e il popolo che lo parla come momento/portatore di innocenza e struggimento; qualcosa che reca in sé un valore primigenio, intatto, come il ricordo della giovinezza e delle speranze in Così giunsi ai giorni della Resistenza, in cui risuona come un ritornello la clausola insistita «pura luce»:
Fuggimmo con le masserizie su un carro
da Casarsa a un villaggio perduto
tra rogge e viti: ed era pura luce.
Mio fratello partì, in un mattino muto
di marzo, su un treno, clandestino,
la pistola in un libro: ed era pura luce.
Visse a lungo sui monti, che albeggiavano
quasi paradisiaci nel tetro azzurrino
del piano friulano: ed era pura luce.
Nella soffitta del casolare mia madre
guardava sempre perdutamente quei monti,
già conscia del destino: ed era pura luce.
Coi pochi contadini intorno
vivevo una gloriosa vita di perseguitato
dagli atroci editti: ed era pura luce.
Venne il giorno della morte
e della libertà, il mondo martoriato
si riconobbe nuovo nella luce...
Quella luce era speranza di giustizia:
non sapevo quale: la Giustizia.
La luce è sempre uguale ad altra luce. [47]
Se il processo lineare della Storia ha condotto alla catastrofe del presente, con il suo capitalismo selvaggio che lascia i poveri sempre più poveri e distrugge la civiltà contadina, il mondo artigianale e la cultura popolare, è possibile vagheggiare soltanto:
a) una presunta autenticità e spontaneità delle lingue popolari condannate all’estinzione, del dialetto – friulano, romanesco ecc. –, a cui delegare lo spazio di espressione degli oppressi o quello della nostalgia e del sogno, come ad esempio, tre le Poesie a Casarsa, in O me donzel: «In chel spieli Ciasarsa / – coma i pras di rosada – / di timp antic a trima» [48];
b) il passato lontano, premoderno e preindustriale: il Medioevo della Trilogia della vita;
c) il recupero della categoria dell’esotico o, meglio, del primitivo, con i viaggi in Africa e nei paesi arabi: era stato del resto Hegel, nelle Lezioni sulla Storia (1830-1831), a giudicare l’Africa proprio fuori della Storia stessa. Qui il pensiero di Pasolini mostra ancora i suoi chiari debiti con la cultura decadente e con certe esperienze artistiche del primo Novecento [49]:
«[...] un secolo ancor verde, / e bruciato dalla rabbia dell’azione / non trascinante ad altro che a disperdere // nel suo fuoco ogni luce di Passione» [50], si legge non a caso nel poemetto Picasso (IX, vv. 7-10), incluso ne Le ceneri di Gramsci. A Roma, nel maggio-luglio 1953, era stata allestita una imponente mostra di Picasso, e di grande risonanza, alla Galleria Nazionale di Arte Moderna. L’aveva voluta e sostenuta il PCI, dal momento che l’artista spagnolo era comunista. Subito si scatenarono le polemiche, mentre giornali e periodici di sinistra celebravano Picasso, le sue opere e la sua lotta politica. Pasolini, che amava disegnare e dipingere, andò a visitare la mostra, che non lo persuase o, almeno, non del tutto. Infatti, nelle opere del dopoguerra individuava un «errore» (VIII, v. 1), rispetto alla «calma furia di limpidità» della produzione precedente: «Assente // è da qui il popolo: il cui brusio tace / in queste tele» (VIII, vv. 15-17). Il Picasso a cui Pasolini si sentiva vicino era quello che, nelle linee più essenziali e dure, nelle «riverberanti figurazioni» (VII, v. 21), esprimeva «pura angoscia e pura gioia» (V, v. 18), in una istintività quasi arcaica, tanto la sua pittura gli appariva «irrichiesta, pura, cieca passione, // cieca manualità» (V, vv. 12-13). Per parte sua, ancora nel 1937, Picasso si era entusiasmato nell’ammirare le sculture esposte nella mostra dell’Arte Indigena al Trocadéro di Parigi: presumendola fuori della Storia, in essa coglieva una capacità spontanea di ergersi contro tutto, di creare forme nuove al di fuori dei canoni che condizionavano invece l’arte occidentale; non era interessato alle valenze etnografiche dell’arte primitiva e africana e ignorava che anche quest’ultima potesse seguire, eccome, dei canoni e delle estetiche ben precise, come ha poi dimostrato ampiamente Frank Willett [51].
Nella dannazione del presente, nel non poter costruire un futuro, il primitivo, con tutti i suoi equivoci, appare a Pasolini una sorta di via obbligata per cercare di recuperare un significato e un senso profondo del fare letteratura e arte: ma quello “primitivo” è un passato generico, ridotto a semplice insegna e apparenza, perché è trasfigurazione della propria vicenda esistenziale, è l’indefinito e presunto passato della specie umana, della sua “infanzia” innocente e semplice, non quello delle culture entro cui siamo radicati.
L’invenzione del primitivo significa così poter scendere momentaneamente da quel “treno” della Storia, a volte orrendo, che è in realtà la gabbia degli inveterati pregiudizi della nostra cultura; significa perdere i molteplici significati del fare e pensare l’arte e la vita, in cui presente, passato e futuro si intrecciano anche nelle semplici presenze delle generazioni, delle cose, delle tecniche, dei saperi e via discorrendo [52]. Dialetto e primitivo, innocenza e purezza dell’origine vengono a coincidere.
Aporie, appunto, e tragedia di Pasolini. Quando i dialetti o le lingue moriranno in Italia, quando moriranno in Africa, quando «il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione, allora la nostra storia sarà finita» (così nel film La rabbia, 1963).
Pensiamo ancora al monologo finale di Bestia da stile, una tragedia in versi pubblicata dopo la morte di Pasolini, che vi lavorò a partire dall’aprile 1966 e che lui citò e lesse
il 21 ottobre 1975, durante un incontro con gli studenti del Liceo Giuseppe Palmieri di Lecce sul tema Dialetto e scuola [53]. Pasolini precisò che il modello letterario sotteso era quello dei Cantos di Ezra Pound e che il riferimento storico e suo alter ego era la figura di Jan Palach, lo studente cecoslovacco che si era dato fuoco, nel gennaio 1969, per protestare contro l’invasione sovietica del suo paese, avvenuta nell’agosto 1968 con lo scopo di porre fine alla stagione delle riforme, o la Primavera di Praga.
Il volgar’eloquio: amalo.
Porgi orecchio, benevolo e fonologico,
alla lalìa («Che ur a in!»)
che sorge dal profondo dei meriggi,
[…]
Nel tuo fascismo privo di violenza, di ignoranza,
di volgarità, di bigotteria,
Destra sublime,
che è in tutti noi,
«rapporto di intimità col Potere»
Hic
desinit cantus.
Prenditi tu sulle spalle tutto questo.
Sulle mie è indegno, nessuno ne
capirebbe la purezza, e un anziano è
sensibile ai giudizi sociali, tanto più
quanto meno gliene importa [...]
Il dialetto, ciò che è locale, inteso come «volgare eloquio», è da amare e da identificare con la Destra, seppure «Destra sublime». Pasolini spiegava che il protagonista del dramma si rivolgeva a un giovane fascista, per suggerirgli quale dovesse essere una vera destra, capace di coinvolgere e inglobare «una serie di problematiche», ossia «valori, temi, problemi, amori, rimpianti, che in fondo valgono per tutti; se ne sono appropriati i fascisti per ragioni retoriche, per sfruttarne il senso», ma in realtà possono essere condivisi al di là di ogni barriera ideologica. Nelle sue immagini poetiche Pasolini identificava, lo ribadiamo, il dialetto con il passato, il passato con «i valori», «problemi, amori, rimpianti» e la destra. Tuttavia, in questa visione lineare della temporalità storica – in cui la Storia diventava la Tradizione tout court –, quello stesso Passato-Tradizione non poteva più essere veduto nella sua complessità: di diacronie e sincronie, di durata e di tradizioni, alcune feconde e vitali, altre meno. L’azione intellettuale non riusciva più a immettervi alternative, bensì soltanto o ad aderire al presente negativo o a respingerlo romanticamente. Così Pasolini, e con lui tanta sinistra successiva (meno avveduta e più nichilista), in un simile aut aut tra negazione e utopia – frutto di una riduzione emotiva, irrazionalistica, dalle serie implicazioni teoretiche –, condannavano nei fatti all’abbandono tutto un patrimonio culturale, che sarebbe diventato, anche sul piano politico, una terra di nessuno da colonizzare con forme, quelle sì, di regressione e anche dei peggiori cliché. E pensare che Antonio Gramsci, Piero Gobetti, Lussu, Carlo Levi, Chiaromonte e altri nel Novecento, non certo di destra, avevano invece fatto tesoro del Vincenzo Gioberti, amico di Leopardi e “antropologo” ante litteram, che aveva sottolineato la necessità di costruire l’Italia nuova nella saldatura delle culture culte e delle culture popolari, orali e dialettali, in quanto anch’esse portatrici – sia pure in forme diverse dalla cultura appunto culta – di contenuti culturali alti, molteplici.
È stato già notato come Sciascia – nell’arco di tempo compreso fra gli anni cinquanta e i primi anni settanta – venga riducendo la presenza del dialetto nelle sue opere; e questo mano a mano che la sua rappresentazione letteraria si fa più concettuale, immaginaria e universale [54]. Nelle conversazioni con Domenico Porzio, Sciascia spiegava il fatto asserendo che il dialetto riguarda i sentimenti più riposti e «consente di raggiungere la madre», ma che «il pensiero metodico, sistematico non può servirsi del dialetto»: «nessun’opera di pensiero può essere scritta in dialetto» [55]. L’idea che l’ambito dialettale riguardi una sfera più intima, soggettiva e dell’affettività, sebbene diffusa nella letteratura novecentesca – bastino i nomi di Pasolini, appunto, e di Andrea Zanzotto –, non giustifica però una simile riduzione del dialetto. Anche Sciascia sembrerebbe considerarlo qui come qualcosa di primigenio, nella tipica dicotomia romantica: metodo in opposizione a spontaneità, ragione in opposizione a sentimento. Al contrario di Pasolini, l’autore siciliano affermava che occorreva «accettare la avanzata incalzante della lingua e la ritirata dei dialetti, senza alcun rimpianto rispetto al nuovo monolinguismo italofono dei giovani», ma dichiarava anche: «io sono molto attaccato al dialetto, lo parlo quasi sempre: ma non farei nulla perché i giovani tornassero ad usarlo. […] Mi pare di notare come alla scomparsa del dialetto corrisponde la tendenza alla formazione di un lessico particolare, di un gergo esclusivo, fatto di parole senza etimo alcuno e per me senza senso» [56].
Se la questione è in tali termini, ci troviamo di fronte a una aporia. Qualsiasi lingua può esprimere ciò che un soggetto sente di potervi esprimere (Dante insegna), ma Sciascia, ritenendo il dialetto incapace di pensiero metodico, lo colloca in un ruolo subalterno: quello stesso in cui lo ha relegato il potere dello Stato unitario, liberale e spesso ostile ai ceti popolari. Varrebbe anche per lui il confronto ideale con Gioberti, la cui concezione della energia culturale dei dialetti e delle culture popolari in genere citavamo in precedenza per Pasolini.
Conta ribadire che una simile contrapposizione binaria lascia intravedere un ragionamento di tipo idealistico, che non riesce a liberarsi degli schemi dialettici. Ciò conduce Sciascia in una impasse. Lo si riscontra anche nella visione della Storia, in cui è il potere stesso a generare l’antipotere: come la Tesi genera l’Antitesi in vista della Sintesi nello sviluppo dialettico hegeliano. Per l’amato Manzoni, la Storia era la sede dell’incontro-scontro fra Male e Bene, che veniva tutto calato nella prospettiva imperscrutabile della Provvidenza divina. Sciascia è però un laico, che dubita persino di dubitare. E il diavolo/il Male oramai non è più una creatura pendolare fra terra e aldilà, perché gli uomini sanno operare meglio di lui, che è così per sempre fuori dal mondo e per sempre dentro, come accade nella bella sotie intitolata Il cavaliere e la morte.
La giustizia è l’utopia stessa, che deve essere ribadita: è la coscienza che tiene dritto il timone dell’etica. Per comprendere l’ossessione di Sciascia per la giustizia e la sua insistenza sulla responsabilità dell’individuo nella Storia, forse è più chiarificatore ricorrere ad altro elemento. Nel Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, la Storia si qualificava come lotta del proletariato contro la borghesia, come lotta degli oppressi contro gli oppressori e, come aveva notato Chiaromonte, infine e soprattutto, come lotta del giusto contro l’ingiusto. In questa serie di slittamenti fra piano della ideologia e della politica e piano etico, si poneva «il problema della giustizia come idea e principio per l’azione», stabilendo così una stretta relazione con un aspetto metafisico: la ricerca della verità [57].
Una volta che si erano constatati la corruzione onnipervasiva del potere attraverso i suoi sistemi (come accade in Il contesto o in Todo modo), l’impostura e la menzogna della Storia (si pensi ad esempio a Il Consiglio d’Egitto), il fallimento delle ideologie, quindi del senso stesso della Storia, la narrazione diventava ancor più facilmente apologo, «giallo metafisico», o rappresentazione metaforica del teatro dell’ingiustizia che vi ha sede. Ciò accade fino all’accanimento, perché, come recita la frase di Dürrenmatt, a epigrafe del romanzo Una storia semplice, «Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia».
Siccome il romanzo sembra sia arrivato in libreria il giorno stesso della morte dell’autore [58], queste parole si tingono di una sfumatura di ironia e di utopia comunque riaffermata.

Daniela Marcheschi
(n. 4, aprile 2022, anno XII)
* Il saggio è tratto dal volume Pasolini e Sciascia. Gli ultimi eretici, a cura di Filippo La Porta, Venezia, Marsilio, 2021.
NOTE
1. Cfr. D. Marcheschi, Il sogno della letteratura. Luoghi, maestri, tradizioni, Roma, Gaffi, 2012, cap. I
e passim.
2. P.P. Pasolini, Tutte le poesie, t. I, a cura e con uno scritto di W. Siti, saggio introduttivo di F. Bandini, cronologia a cura di N. Naldini, Milano, A. Mondadori, 2003 (“I Meridiani”), pp. 820-821.
3. Cosa «che dovrebbe bastare a riscattarlo dal sospetto di estetismo», sottolineò a ragione Romeo Giovannini, nella sua acuta recensione a Poesia in forma di rosa (1964): Confessioni in versi del nuovo
Pasolini, in «Il Giorno», 22 luglio 1964.
4. Cfr. ancora R. Giovannini, Confessioni in versi del nuovo Pasolini, cit., che ne mette in evidenza la «sete di martirio», tramite la discesa agli Inferi, «attraverso il peccato».
5. Se ne veda precisamente Autonomia ed eteronomia dell’arte, Firenze, Sansoni, 1936 (2ª ed., Firenze, Vallecchi, 1959).
6. Si veda ovviamente O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale, trad. di J. Evola, Milano, Longanesi, 1957. L’opera nell’originale versione tedesca, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, era stata pubblicata a Monaco, in due volumi usciti e riveduti negli anni 1918-1923. Spengler recuperava una intuizione poetica di Victor Hugo che, in Notre Dame (nel cap. Ceci tuera cela), parlava del Rinascimento come di un sole al tromonto scambiato per aurora dall’Europa. A questa metafora Pasolini non è indifferente, se di «tramonto» che «pareva un’infuocata // alba» parla anche nel poemetto Picasso (III, vv. 12-13), in Le ceneri di Gramsci, su cui torneremo anche più avanti.
7. L’opera, corredata della recensione di Pasolini (Dittatura in fiaba), è stata edita nuovamente nel 1981 dalla Sellerio: in trecento esemplari numerati e con un’acquaforte originale di Edo Janich; e poi, insieme alle poesie di Sciascia, il testo critico pasoliniano e con il titolo La Sicilia, il suo cuore. Favole della dittatura, dalla Adelphi (1997).
8. In merito cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra. Vita e opere di Leonardo Sciascia, Milano, La nave di Teseo, 20192, pp. 142-143.
9. Cfr. ivi, pp. 144-146.
10. Sul caso Moro e il singolare intreccio umano e intellettuale di Pasolini e Sciascia intorno a esso, cfr. A. Banda, Ossessione Moro, in «DoppioZero», 9 maggio 2018: <https://www.doppiozero.com/materiali/ossessione-aldo-moro> (21 agosto 2020).
11. Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 287.
12. L. Sciascia, Nero su nero (1979, Torino), in Id., Opere 1971-1983, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 2001, pp. 773-774. Per le citazioni e il racconto dell’amicizia di Sciascia con Pasolini cfr. anche M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., pp. 143-146.
13. P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. I, a cura di W. Siti, S. De Laude, con un saggio di C. Segre, cronologia a cura di N. Naldini, Milano, A. Mondadori, 1999 (“I Meridiani”), p. 1082.
14. Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. II, cit., pp. 2223-2224. Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., pp. 245-247.
15. Ivi, p. 14.
16. Si veda G. Mariuz, La meglio gioventù di Pasolini, Udine, Campanotto, 20152, pp. 90-91.
17. Si veda E. Biagi, Dicono di Lei, Pasolini [intervista], in «La Stampa», 4 gennaio 1973.
18. Sciascia dichiarerà in una intervista rilasciata a Nico Perrone: «Ho anche tradotto molto, dal francese e dallo spagnolo. La gran parte di queste traduzioni è rimasta nei cassetti. Raramente ho pubblicato traduzioni. Il tradurre è un buon esercizio per uno scrittore» (in «Il Manifesto», 5 dicembre 1978); ora si veda N. Perrone, La profezia di Sciascia. Una conversazione e quattro lettere, Milano,
Archinto, 2015, p. x.
19. Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 15.
20. Ivi, p. 79.
21. In merito a tutta questa parte biografica, per approfondimenti e confronti di posizioni anche opposte, specialmente in relazione all’assassinio di Pasolini, cfr. almeno O. Fallaci, È stato un massacro, in «L’Europeo», 21 novembre 1975, e, della stessa, anche Pasolini, un uomo scomodo, introduzione di A. Cannavò, Milano, Rizzoli, 2015; E. Siciliano, Vita di Pasolini, Milano, A. Mondadori, 2015; N. Naldini, Breve vita di Pasolini, Parma, Guanda, 2015; G. Zigaina, Pasolini e la morte. Un giallo puramente intellettuale, Venezia, Marsilio, 2005; R. Carnero, Morire per le idee. Vita letteraria di Pier Paolo Pasolini, Milano, Bompiani, 2010; R. Paris, Pasolini ragazzo a vita, Roma, Elliot, 2015. Quanto a Sciascia, non si può prescindere dall’informata biografia di M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit.
22. Cfr. E. Biagi, Dicono di Lei, Pasolini, cit.
23. Per tutte queste problematiche si rimanda a D. Marcheschi, Il sogno della letteratura, cit., pp. 149- 151, 155-156.
24. Cfr. R. Quadrelli, La tradizione tradita. Morale e politica nell’Italia contemporanea, Milano, Leonardo, 1995, pp. 178-182.
25. Ivi, 179.
26. Nello scritto La libertà stilistica (1957), incluso in Passione e ideologia, Pasolini accennava alla «polemica anti-petrarchesca che serpeggia in tutta l’elaborazione culturale di “Officina”» (P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. I, cit., p. 1235). E più tardi, scrivendone sul settimanale «Tempo», negli ultimi anni della sua vita, «Petrarca viene psicanalizzato con brutalità, ma poi ammirato in quanto “mostro” chiuso nel suo narcisismo»: cit. in M.A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Milano, B. Mondadori, 1998, p. 91. In merito agli effetti di un petrarchismo di maniera tuttora rilevabili nella poesia contemporanea, cfr. D. Marcheschi, Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia, Milano, Mursia, 2016 e A. Anelli, Alla rovescia del mondo. Introduzione alla poesia di Guido Oldani,
Faloppio, LietoColle, 2009, pp. 7-8 e passim.
27. Per un approfondimento si veda D. Marcheschi, Il sogno della letteratura, cit., pp. 43-45.
28. L. Sciascia, La Sicilia come metafora. Intervista di Marcelle Padovani, Milano, A. Mondadori, 1979, p. 78.
29. Ivi, pp. 81-82. Per questa e la precedente citazione cfr. anche M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 79.
30. Cfr. E. Vittorini, Le due tensioni. Appunti per una ideologia della letteratura, a cura di D. Isella, Milano, Il Saggiatore, 1967, p. 37 (ora, con un’appendice di materiali inediti, con prefazione di C. De Michelis, a cura e con postfazione di V. Brigatti, Matelica, Hacca, 2016).
31. E.. Biagi, Dicono di Lei, Pasolini, cit.
32. F. La Porta, Pasolini. Uno gnostico innamorato della realtà, Firenze, Le Lettere, 2002, p. 18 ha individuato in tutto ciò la presenza di «un motivo gnostico».
33. P.P. Pasolini, Che cos’è questo golpe?, in «Corriere della Sera», 14 novembre 1974, poi, con il titolo Il romanzo delle stragi, in Id., Scritti corsari (1975, Milano), ora in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti, S. De Laude, con un saggio di P. Bellocchio, cronologia a cura di N. Naldini, Milano, A. Mondadori, 1999 (“I Meridiani”), p. 364.
34. Quanto al «disorganico» Chiaromonte, si veda anche F. La Porta, Eretico controvoglia. Nicola Chiaromonte, una vita tra giustizia e libertà, Milano, Bompiani, 2019; Id., Disorganici. Maestri involontari del Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018. La Porta ha individuato altre convergenze di Pasolini con il pensiero di Chiaromonte, in particolare «una prossimità a certi temi della filosofia esistenzialista»: si veda Id., Pasolini, cit., pp. 19-20.
35. Ora in N. Chiaromonte, La rivolta conformista. Scritti sui giovani e il 68, a cura di C. Panizza, Forlì, Una città, 2009, pp. 69-78. Le citazioni che seguono sono tratte dalle pp. 61-62, 67, 71.
36. E. Masi, Di alcuni dei molti problemi non differibili, in «Quaderni Piacentini», a. IX, n. 42, novembre 1970, pp. 19 ss.
37. P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. I, cit., p. 1440.
38. Cfr. D. Marcheschi, Il sogno della letteratura, cit., pp. 27-29.
39. Cito da M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 274.
40. In merito si veda S. Colarizi, Un paese in movimento. L’Italia negli anni Sessanta e Settanta, Bari- Roma, Laterza, 2019, Introduzione e cap. I.
41. P.P. Pasolini, Lettera luterana a Italo Calvino, in «Il Mondo», 30 ottobre 1975, poi in Id., Lettere luterane (1976, Torino), ora in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 702.
42. Si veda Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. II, cit., p. 1913.
43. E. Granzotto, Siamo tutti siciliani, in «Panorama», 8 novembre 1973.
44. P.P. Pasolini, Tutte le poesie, t. I, cit., p. 1099.
45. Id., Noterella su Carducci (1958), in Id., Passione e ideologia (1960, Milano), ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. I, cit., pp. 1091-1092.
46. Cfr. D. Marcheschi, Il sogno della letteratura, cit., pp. 9-48.
47. P.P. Pasolini, Tutte le poesie, t. I, cit., p. 944.
48. Ivi, p. 13.
49. Alberto Moravia sosteneva che Pasolini fosse «uno scrittore decadente» (cfr. R. Paris, Moravia. Una vita controvoglia, Firenze, Giunti, 1996, p. 328), sebbene quest’ultimo ci tenesse a sottolineare, come in un’intervista rilasciata a Camon (F. Camon, Il mestiere di poeta, Milano, Lerici, 1965, pp. 189-200: p. 198), di sentirsi estraneo al vitalismo dannunziano: si veda anche P.P. Pasolini, Saggi sulla politica e la società, cit., p. 1588. Dello stesso parere di Moravia è C. Garboli, La stanza separata, Milano, Libri Scheiwiller, 20082, pp. 57-65. C. Galuzzi, Tra il petrolio e l’inchiostro, in «Rendiconti», a. XXXV, n. 40, marzo 1996 (n. monografico con il titolo Su Pier Paolo Pasolini, a cura di R. Roversi), pp. 127-138, accenna a «una sorta di decadentismo» (p. 129), mentre F. La Porta, Pasolini, cit., p. 20 parla piuttosto di esistenzialismo. A mio avviso, alcuni aspetti dell’esistenzialismo, che è un movimento vario nei suoi elementi concettuali, non sono separabili proprio dalla temperie decadente (come, a proposito di Sartre, si accorse pure L. Trilling, La letteratura e le idee, trad. e introduzione di L. Gallino, Torino, Einaudi, 1962). In Pasolini vi sono, è vero, l’angoscia e un sentimento di religio, ma manca la tensione costruttiva fra soggetto e oggetto tipica dell’esistenzialismo d’impronta più fenomenologica, che interessò Chiaromonte e anche Camus; mentre è presente il vitalismo. Con tutti i distinguo indispensabili, quest’ultimo e altri aspetti di Pasolini – su cui si è cercato o si sta cercando di attirare un’attenzione problematica – sono invece imputabili proprio a residui decadenti.
50. P.P. Pasolini, Tutte le poesie, t. I, cit., p. 794.
51. F. Willet, Arte africana, trad. di B. Bernardi, Torino, Einaudi, 1978 (ed. originale: African Art. An Introduction, London, Thames & Hudson, 1971). Sulla questione cfr. anche D. Marcheschi, Prismi e poliedri. Scritti di critica e antropologia delle arti, vol. I, Orizzonti e problemi, Livorno, Sillabe, 2001, cap. 3.
52. Si veda D. Marcheschi, L’invenzione del “primitivo” e l’idea di tempo nell’arte contemporanea, in Storia della lingua e filologia. Per Alfredo Stussi nel suo sessantacinquesimo compleanno, a cura di M. Zaccarello, L. Tomasin, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 321-335.
53. Desumo la notizia, e le citazioni che seguono, da B. D. Schwartz, Pasolini Requiem, Milano, La nave di Teseo, 20202, pp. x-x.
54. Cfr. E. Wren-Owens, Postmodern Ethics. The Re-appropriation of Committed Writing in the Works of Antonio Tabucchi and Leonardo Sciascia 1975-2005, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 62 ss.
55. L. Sciascia, Fuoco all’anima. Conversazioni con Domenico Porzio, Milano, A. Mondadori, 1992, pp. 4-5.
56. Le citazioni sciasciane sono ricavate da M.C. Castiglione, «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare». Il rapporto con la lingua del maestro Leonardo Sciascia, in «Il Giannone», a. XVI, n. 31, 2018, pp. 237-262: p. 261.
57. Cfr. N. Chiaromonte, Il tempo della malafede e altri scritti, a cura di V. Giacopini, Roma, Edizioni dell’Asino, 2013, p. 97.
58. Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., pp. 365-366.
|
|