









|
|
«Sonet - La Scuola Siciliana» di Florian Chelu Madeva
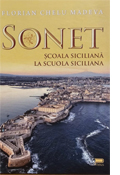 Sonet - La Scuola Siciliana di Florian Chelu Madeva è un'opera che celebra i primi sonettisti del mondo, mettendo in musica le loro composizioni. Il volume è stato pubblicato nel 2023 dalla casa editrice Primus di Oradea, ed è stato presentato al pubblico il 5 marzo 2024 presso l'Aula Magna del Seminario Teologico Greco-Cattolico di Oradea. Sonet - La Scuola Siciliana di Florian Chelu Madeva è un'opera che celebra i primi sonettisti del mondo, mettendo in musica le loro composizioni. Il volume è stato pubblicato nel 2023 dalla casa editrice Primus di Oradea, ed è stato presentato al pubblico il 5 marzo 2024 presso l'Aula Magna del Seminario Teologico Greco-Cattolico di Oradea.
Florian Chelu Madeva è un artista poliedrico noto per il suo contributo alla musica e alla letteratura, in particolare per la sua opera di trasposizione musicale dei sonetti. Tra le sue opere «italiane», oltre a Sonet - La Scuola Siciliana, ricordiamo anche Sonetto - Michelangelo Buonarroti, Ed. Primus, Oradea, 2013, Sonet - Antologie de limba italiană (vol. 1), Ed. Primus, Oradea 2015, un’antologia di sonetti musicali, che riflette l'interesse dell'autore per la poesia italiana, e Sonet - Antologie de limba italiană (vol. 2), Ed. Primus, Oradea. 2020.
Oltre a queste pubblicazioni, Florian Chelu Madeva ha composto musica per tutti i sonetti di William Shakespeare, un'impresa notevole che evidenzia la sua dedizione alla fusione tra musica e letteratura.
Florian Chelu Madeva ha prodotto 29 volumi e 13 CD. La sua discografia è disponibile su piattaforme come Discogs, dove è possibile esplorare ulteriormente le sue opere musicali.
Nel 2000, la Presidenza della Romania e il Ministero della Cultura della Romania, hanno assegnato a Florian Chelu Madeva la medaglia commemorativa «150 anni dalla nascita di Mihai Eminescu» per il suo contributo speciale alla promozione dell'opera di Eminescu.
Sonet - La Scuola Siciliana raccoglie 42 sonetti musicali, uno per ciascuno dei 14 poeti considerati fondatori di questa forma letteraria, includendo l'intera opera di Jacopo da Lentini, riconosciuto come l'inventore del sonetto.
Il sonetto musicale è un'idea (sinaletismo) concepita da Florian Chelu Madeva sulla base di soltanto due misure, la 169 e la 170 di Fuga dalla Sonata n. 3 per violino di Johann Sebastian Bach.
La Scuola Siciliana nasce all’inizio del XIII secolo, alla corte dell’imperatore Federico II di Svevia. La sua corte, anche se per lo più itinerante, si concentra soprattutto in Sicilia, che, di conseguenza, diventa il centro culturale e politico dell’impero. In questo ambiente fiorisce la poesia lirica, scritta in volgare e ispirata alla tradizione dei trovatori provenzali. In questo ambiente nasce la Scuola siciliana, che conosce il massimo splendore tra il 1230 e il 1250. Da allora in poi l’influenza della Scuola siciliana sarà fortissima, tanto che tutti i poeti vissuti dopo, verranno chiamati siciliani, pure gli stilnovisti, anche se la loro attività si svolgeva nel centro e nel nord d’Italia.
Federico II di Svevia è nominato imperatore nel 1220 e muore nel 1250. Fin da subito, Federico, che aveva un’intelligenza assai vivace e, naturalmente, una raffinatissima formazione, incoraggia la laicità, le scienze e la mescolanza tra varie culture. Mostra, inoltre, una particolare propensione per la poesia, che lo spinge a sostenere lo sviluppo di forme liriche in volgare, ispirate alla tradizione dei trovatori provenzali. Tutto questo succede anche perché lo stesso Federico era un poeta che scriveva in volgare.
Fino a Federico II, l’aria che si respirava era ancora pesante, improntata al feudalismo. L’arrivo dell’imperatore poeta e la nascita della Scuola siciliana aboliscono in parte la realtà feudale e la sostituiscono con qualcosa di nuovo, e questo si sentirà anche nelle tematiche affrontate dai poeti. L’amore rimane ancora il tema principale, ma non è più soltanto l’amore fra un vassallo e una donna, ma è anche un amore fuori dalla realtà, a volte astratto, pur essendo magari ancorato alla cronaca quotidiana. Nasce così una poesia che lascia spazio a riflessioni sulla natura dell’amore, e che si apre a nuovi orizzonti letterari. Se i trovatori provenzali coltivavano la figura del poeta cavaliere povero o della piccola nobiltà, la Scuola siciliana impone la figura del poeta borghese, magari funzionario amministrativo o giuridico alla corte, che scrive poesia solo per piacere.
La Scuola siciliana, oltre a un’aria diversa da quella feudale, porta con sé anche cambiamenti sostanziali per quanto riguarda le strutture metriche. Principalmente, la Scuola siciliana è caratterizzata da tre strutture metriche: la canzone, la canzonetta e il sonetto. La canzone rimane ancora la forma più elevata e illustre della poesia lirica ed è composta da endecasillabi, ma spesso questi sono alternati a settenari. La canzonetta ha una struttura più vicina alla narrativa e quindi si presta ad argomenti anche meno elevati e la sua metrica è più libera e aperta, e il più delle volte fa uso di versi brevi e vivaci, che la differenziano dalla canzone, ma soprattutto dal sonetto. Il sonetto è l’invenzione del Notaro, il più importante esponente della Scuola siciliana, Giacomo da Lentini, o almeno, per quel che si conosce, fu lui il primo a usarlo. Il sonetto è composto sempre da quattordici versi endecasillabi e tratta argomenti diversi, che non trovano spazio nella canzone, e tanto meno nella canzonetta. Nel sonetto possiamo trovare tematiche filosofiche e morali, ma anche l’ironia e, naturalmente, l’amore.
Giacomo da Lentini, noto anche come il Notaro, nome con il quale comparve pure nella Divina Commedia di Dante, oltre a essere la figura più importante della Scuola siciliana, è probabilmente l’inventore del sonetto. Quel che si sa di certo e che è stato funzionario imperiale alla corte di Federico II tra il 1233 e il 1241. La sua produzione letteraria risale a quel periodo ed è composta da 38 componimenti poetici, tra canzoni, canzonette e sonetti. Giacomo da Lentini si distingue dagli altri poeti del tempo per la sua capacità di fare analogie, soprattutto sul piano delle immagini, tra il mondo sociale e quello naturale e vegetale. Lui si inserisce benissimo nell’ambiente innovativo creato da Federico II e rispecchia perfettamente l’interesse dell’imperatore e della Scuola siciliana, che apre a una nuova realtà vista attraverso argomenti scientifici e naturalistici. Il suo tema preferito è sempre quello dell’amore, ma un amore molto più meditativo e intriso di un elevato contenuto spirituale e teorico, e non poche volte religioso.
Se è vero che Federico II e la Scuola siciliana sfuggono alle tare feudali del XIII secolo, la religiosità nella produzione letteraria è ancora ben presente, e la metafora religiosa è utilizzata anche nel sonetto nella modalità feudale. La devozione dovuta a Dio si rispecchia nella devozione del vassallo verso il suo signore. Quindi, il poeta vuole anela a raggiungere la beatitudine paradisiaca servendo Dio, ma allo stesso tempo serve il suo signore per raggiungere la beatitudine paradisiaca della corte, che è il paradiso più vicino.
Lo schema ritmico del sonetto siciliano è ABAB – ABAB – CDC – DCD. La ritmicità complessiva del sonetto è data anche dai versi strettamente endecasillabi. Dal punto di vista linguistico, il sonetto si distingue anche per la forte presenza di provenzalismi che il poeta usa per affermare il suo amore. Non meno importante è il volgare del quale il poeta si serve, che non è un volgare rude, ma elevato, illustre, sfuggito in qualche modo al dialetto, che fino a quel punto la faceva da padrone.
Nei sonetti dei poeti della Scuola siciliana, l’amore, e quindi implicitamente la donna, e una delle tematiche principali. Soprattutto per Giacomo da Lentini, la donna è il motivo essenziale della celebrazione e le sue più importanti opere sono costruite sulla tematica dell’amore timido. Il poeta ammira di nascosto la sua amata, sia perché non ha il coraggio di esprimere apertamente i suoi sentimenti, sia perché non vuole comprometterla davanti agli altri, ma forse ha anche paura di essere rifiutato. La donna non è mai descritta riccamente, ma la sua immagine viene appena tratteggiata da delicate parole, che non limitano però la passione del poeta, ma la alimentano in una forma che si avvicina alla venerazione. Se la descrizione della donna è abbastanza povera, l’introspezione psicologica dell’innamorato viene descritta ampiamente, e così, il senso compiuto del sonetto sarà proprio il messaggio d’amore che il poeta manda all’amata. Quindi, possiamo affermare che la produzione letteraria della Scuola siciliana gira attorno al tema dell’amore.
Sia le canzoni che le canzonette e i sonetti cantano l’amore tra l’uomo e la donna, a volte divinizzandolo, altre volte nobilitandolo. L’elevazione quasi metafisica della donna si ritrova in tutte le opere dei poeti della Scuola siciliana, e questo si rifletterà anche sulle produzioni letterarie seguenti fino all’incoronamento della Divina Commedia di Dante Alighieri.
In sintesi, Sonet - La Scuola Siciliana di Florian Chelu Madeva rappresenta un ponte tra la tradizione poetica medievale e la musica contemporanea, offrendo una prospettiva unica sulla nascita del sonetto e sulla sua evoluzione.
Viorel Boldis
(n. 2, febbraio 2025, anno XV)
| |

