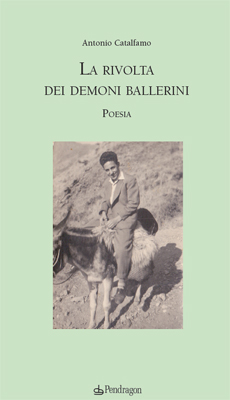|
|||
«La rivolta dei demoni ballerini». Poesie di Antonio Catalfamo
La poesia, in Catalfamo consapevole delle illusioni, si pone domande, non indugia a descrivere interessi e impotenza, non si vergogna di chiedere e di smascherare contraddizioni e ipocrisie vendute come oro colato; immagini forti, truci, tragiche, come quelle di corpi penzolanti «ancora dal cappio», con «i piedi sospesi nel vuoto», di «ville abusive [che] crescono» (Giustizia, 27), di miseria e disperazione; reminiscenze mitiche e mitologiche; padroni, potenti e prepotenti; vecchi compagni; «il dolore / di ferite che non vogliono guarire: / sotterranee, come un fiume carsico» (I tuoi occhi, 33); tradizioni antichissime e ancestrali nel cuore di un Sud magico e di straordinaria potenza visiva, analogo a quello che colora il mondo contadino di Carlo Levi. E, scorrendo le pagine della raccolta, vengono in mente precise parole leviane: «I contadini risalivano le strade con i loro animali e rifluivano alle loro case, come ogni sera, con la monotonia di un’eterna marea, in un loro oscuro, misterioso mondo senza speranza. Gli altri, i signori, li avevo ormai fin troppo conosciuti, e sentivo con ribrezzo il contatto attaccaticcio della assurda tela di ragno della loro vita quotidiana […]». [3] Come in Levi risorge poi in Catalfamo l’uomo di fronte alla massa, l’umanità davanti alla disumanizzazione perpetrata da un sistema che prevede e basa la sua labile spettacolarità nella creazione e mantenimento di dislivelli dicotomici: «sopra,» si legge in La mia poesia, «i padroni di terre, / con i magazzini pieni di vino, olio, / formaggio gonfio, panie di fichi secchi, / pomodori invernali e agli / intrecciati a ghirlanda. / Sotto, i contadini, che prendono / la decima nel riparto dei prodotti, / gli artigiani, pagati a merito / con una bottiglia di vino» (36). «[A]mbasciatore d’un altro mondo all’interno del nostro mondo» [4], alla pari ancora una volta dello scrittore torinese giunto ad Eboli, Catalfamo scatta, con i potenti versi di questa sua nuova raccolta, una serie di eloquenti fotogrammi in successione dell’esistere umano di cui si erge a testimone e custode. «E così nasce, […]» scrive in chiusura di uno dei componimenti facenti parte della silloge, «la poesia» (La borsa, 42): Catalfamo invita il lettore a seguirlo in un viaggio alla riscoperta dell’«esperienza», di una parola che non si piega al volere della «comunicazione standardizzata», di una poesia che si erge a «ideologia». Si costituisce in queste pagine una scrittura che svela, raccontandoli, riti e memorie che, nella poesia, cercano l’uomo e che tornano sulla pagina per testimoniare, insieme al loro esistere, la loro valenza mitica, non relegata all’archetipo, bensì presente e viva sempre e ovunque, oggi come domani. Concordanze, contaminazioni, compenetrazioni e una forte coralità: queste sono alcune delle caratteristiche precipue della poesia dello scrittore siciliano; una poesia fatta di protagonisti che, come il poeta (e attraverso la voce del poeta), mettono in dialogo la propria storia di persone, e in cui convergono nondimeno altre importanti voci, quelle dei «compagni poeti» (Nemici, 111), autori in cui Catalfamo si riconosce (Fenoglio, Neruda, ma anche Nâzim Hikmet, Ghiannis Ritsos, ecc.). Il risultato è una rappresentazione uditiva polifonica della storia; una storia che, sempre tradotta in una parola immediata, duttile, riflessa (alla pari di quella di Montale), e al contempo fortemente icastica, non si esaurisce nel passato, perché la «poesia», scrive Catalfamo, «mi serve / a raccontare» (La mia poesia, 36) e «[s]olo la poesia può lenire i dolori della vita» (Petrarchesca, 86). Che cos’è allora la poesia se non strumento conoscitivo privilegiato che rivela l’essenza dell’universo delle cose e se non mezzo «salvifico» di fronte a una realtà in cui l’uomo rischia di perdere il senso soprattutto di se stesso? Tra gli intertesti la critica non ha mancato giustamente di ricordare come nomi centrali quelli di Pavese e Vittorini, ma sono anche altri i modelli e i riferimenti contenuti nella lirica dello scrittore. Mito, storia e poesia (come recita anche il sottotitolo del lavoro critico dell’autore su Rocco Scotellaro, nome citato del resto anche esplicitamente in uno dei componimenti della raccolta (A mia madre, 65) si intrecciano in maniera organica, mentre alcuni passi paiono evocare, per la successione dei ritratti commoventi e crudi che presentano, le pagine della Spoon River Anthology (1915) di Edgar Lee Masters. [5] Nella raccolta, troviamo, in modo analogo alla silloge dello scrittore americano, un po’ tutti: il maestro, la Carabiniera, il calzolaio, la madre, il prete, il padre, il contadino, il compagno operaio, il primario, l’infermiera, il sindaco-poeta, ecc. Eppure, allo stesso tempo, è il collettivo a guadagnare un posto di primo piano: a fianco dell’individuo è infatti il gruppo come tale a dominare il palcoscenico della scrittura di Catalfamo; sono i braccianti, i notabili, il clero, i poveri, i padroni, i lavoratori e i disoccupati, i vecchi combattenti… Là una piccola cittadina della provincia americana e la presentazione di una galleria di 248 personaggi che descrivono le vicende di un microcosmo morale fornisce a chi lo legge un nuovo modo di guardare le cose e l’umano. Anche per Catalfamo, come per Masters, è importante recuperare la memoria per scoprire se le cose sono cambiate rispetto al passato. E non paiono esserlo. Nella raccolta dello scrittore nato a Barcellona Pozzo di Gotto, formata da 53 componimenti in totale, una parola è ripetuta in modo quasi costante: si tratta del termine «compagno/i», abbinato alla fede politica comunista dell’autore; un comunismo, quello del poeta, considerato non solo nella sua storicità e nei ricordi delle figure del padre e del nonno, ma anche come fenomeno non storicizzato, ovvero nel suo significato di necessario momento evolutivo, di umanesimo in senso gramsciano, di progetto per cambiare la realtà quotidiana delle cose. In La malora, lirica del 2014, il compagno, nel ventaglio di figurazioni della presentazione fatta, è uno e molteplice a un tempo. Fotografato nella sua attività è lui che «coltiva la pianta del comunismo / la difende dalle tempeste / e dalle erbe malsane / del tradimento» (31). Sono parole, quelle di Catalfamo, che non lasciano margini di incertezza interpretativa, anche quando lo sguardo si ferma su topografie, le cui coordinate geografiche arretrano per diventare documentazione e ricerca storico-antropologica, contenitore di pensieri e immagini. È il caso di Trieste, «città mito-poietica» (Trieste, 80), città di Saba, metropoli multietnica e cosmopolita, e allo stesso tempo «la città dei rastrellamenti / e della Risiera, / del fascismo», «dei partigiani» (ibid.), ecc.; ma la cosa si ripete anche per altri luoghi legati a richiami culturali di eccellenza, ad esempio per la Casarsa di Pasolini, «il giovane poeta» fuggito da un «Friuli bigotto […] verso altri mondi», eppure fedele «[al]la religione dei […] [suoi] avi contadini» (Educazione cattolica, 47). Il mosaico del tempo tracciato nelle pagine di Catalfamo ricopre, così come il passato, le ombre più profonde del presente attuale: disonestà e cupidigia economica vengono fissate in modo tenace nei versi in cui il poeta ritrae in modo vivido e senza eccessi l’Italia dell’era Covid, mettendo nero su bianco il noto, senza parole inutili (Coronavirus, 88-89).
Monica Biasiolo
1. Antonio Catalfamo, Il solco della vita, Cultura Duemila, Ragusa, 1989. | |||