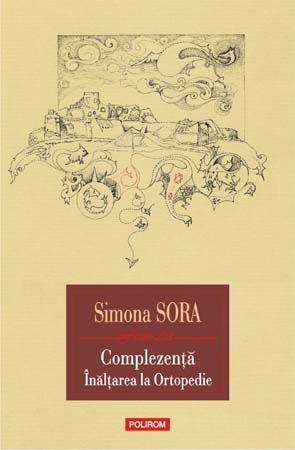|
|
Vite allo specchio: «Compiacenza» di Simona Sora
 Pubblicato da Polirom nel 2020 e tradotto in francese nel 2023, Complezență di Simona Sora torna a raccontarci di Maia, la protagonista di Hotel Universal (Polirom, 2012), pur narrandone le vicende precedenti. In Italia, Hotel Universal è uscito nel 2023 presso Bottega Errante edizioni, con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, nella traduzione di Sara Salone. Pubblicato da Polirom nel 2020 e tradotto in francese nel 2023, Complezență di Simona Sora torna a raccontarci di Maia, la protagonista di Hotel Universal (Polirom, 2012), pur narrandone le vicende precedenti. In Italia, Hotel Universal è uscito nel 2023 presso Bottega Errante edizioni, con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, nella traduzione di Sara Salone.
Il romanzo Complezență è composto da due storie, due vite possibili. Nella prima parte, Ascesa in Ortopedia, Maia lavora come infermiera strumentista a Deva, nella Romania degli anni Ottanta. Sogna di fuggire in Germania con l’amico Adi; e poi iscriversi a Medicina, imparare il tedesco. Invece, a causa di un provvedimento disciplinare, finirà al reparto di Ortopedia. Al termine di un turno in ospedale la giovane scopre, nelle docce delle donne, un corpicino inerte avvolto in un lenzuolo; di lì a poco si ritrova coinvolta in un’indagine: l’aborto, infatti, è illegale negli anni della dittatura ceaușista. Ma di chi è quella bimba, alla quale ha la tenerezza e la premura di dare nome Ada? Forse di Paşa, come sostengono le voci che corrono fra i reparti, e del dottor Negru, grande incantatore di infermiere, al cui fascino ha ceduto anche lei. Per la ragazza non ha importanza: di ‘aborti spontanei’ ne ha visti tanti, e anche in questo caso fa ciò che ha sempre fatto da quando si trova nel reparto di Ginecologia: si prende cura del corpicino, lo lava e lo avvolge in fasce, perché sa che «i bambini si lavano dopo la nascita, e i morti dopo la morte».
Anche nella seconda parte, intitolata Ospite a vita, Maia è un’infermiera: fuggita dai tumulti di Bucarest e dalle violenze di Piazza Università, vive insieme all’amico geologo Grigore in un monolocale a Friburgo e lavora in una residenza per anziani, le cui regole rigorose e impenetrabili la portano a un altro vicolo cieco e in cui la compiacenza è una vera e propria moneta di scambio. La Maia dell’Ovest, che in Romania sognava di vivere e lavorare in un paese libero, di trasferirsi in Francia, si rende conto che «la compiacenza è l’inferno». Anche qui Maia resta coinvolta in indagini per non aver rispettato il protocollo ospedaliero, ovvero per aver praticato di propria iniziativa – e invano – un intervento di rianimazione su un ospite in arresto cardiaco, laddove le regole della casa di cura impedivano alle infermiere di decidere in autonomia. Decisione che le costerà il posto.
Da entrambe le storie, alternative di vita, si evince che la protagonista sembra essere maggiormente in sintonia con i bambini non destinati a nascere e con gli anziani dimenticati, piuttosto che con tutti gli altri adulti ipocriti con i quali deve confrontarsi ogni giorno, dimostrando in entrambe le ipotesi narrative una grande superiorità morale.
In una modalità del tutto speculare, Compiacenza riflette due lati possibili della vita dello stesso personaggio, contrapponendo due mondi diversi, l’orientale e l’occidentale, ma anche la vita e la morte, la libertà e la dittatura.
È con un realismo crudo, ma anche grande acume intellettuale, che Simona Sora firma questo ritratto disilluso di due società in cui tutto sembra il contrario di tutto ma che, infine, si rivelano simili e nelle quali l’ipocrisia lascia poco spazio alla verità. Maia e il suo doppio si ritrovano a non dire ciò che pensano, a non pensare ciò che dicono, a vivere in ambienti di lavoro severamente gerarchici che richiedono ipocrisia, conformismo, asservimento. In una parola: compiacenza.
In anteprima in traduzione italiana, pubblichiamo qui di seguito l’incipit del romanzo.
Da «Compiacenza» di Simona Sora
L’aveva fatto, alla fine l’aveva fatto, solo questo aveva in mente, un pensiero simile a un nastro trasportatore orizzontale, a uno scroll anacronistico e impersonale che aveva incominciato solo in quel momento – quando si era risvegliata nel letto che odorava di iodio e medicine dell’uomo più vecchio di lei di una vita – a scorrere in modo automatico. L’aveva fatto, alla fine l’aveva fatto, si diceva, osservando la sua schiena liscia, le natiche così rotonde – l’aveva notato molto tempo prima, guardandolo allontanarsi nei corridoi dell’ospedale o in sala operatoria, quando si voltava all’improvviso, con una piroetta inaspettata, e infilava la siringa nel tappo di gomma della perfusione. L’aveva fatto, alla fine l’aveva fatto, e dopo sarebbe voluta scomparire come per magia dalla sala di guardia e dal letto di quel tizio che nemmeno la chiamava per nome e che, la sera prima, l’aveva convocata in sala di guardia con voce annoiata per dettarle il protocollo operatorio.
Erano obbligati – questo lo sapeva anche Maia, che lavorava in sala operatoria solo da pochi mesi – a elencare tutte le operazioni in un protocollo operatorio, a scrivere nero su bianco come avevano tagliato con la lama di acciaio del bisturi, com’erano penetrati nelle cavità gialle dell’adipe denso, tra capillari, vene e arteriole, vini leggeri nascosti sotto i muscoli, come avevano fermato il sangue in eccesso con le pinze emostatiche, come avevano raggiunto – liberando pelle e muscoli, adipe e vasi – il punto desiderato: erano obbligati a raccontare per filo e per segno cos’avevano fatto. Cosa fare quando ci si ritrova faccia a faccia con la malattia? Cosa fare con la carne, come nascondere la malattia, cosa scrivere nel protocollo? Maia non si era mai posta, prima d’allora, queste domande, ma aveva già notato una certa differenza di stile tra il dottor Negru e il resto dei chirurghi dell’ospedale. I più, tra essi, dettavano in maniera meccanica, monocorde, con parole prese dai manuali sgualciti delle loro facoltà di Medicina di Cluj, Timișoara o, più raramente, Bucarest. Il dottor Negru, invece, rifletteva, raccontava, esitava, ci ripensava, riformulava la frase, la pregava di rileggergli l’anamnesi. Rimaneva chinato, con lo sguardo fisso sullo stretto spazio tra i loro sgabelli, verso il cemento a mosaico, cercando le parole come se ne accarezzasse i contorni.
Quando gli aveva toccato il piede nudo, per sbaglio, si era voluta scusare: continuando a scrivere le frasi che lui le dettava, attenta alla loro corretta stesura– la pregava sempre di prestare attenzione all’accordo tra soggetto e predicato, alla punteggiatura, ai tempi del passato, alla logica delle proposizioni – si era avvicinata in modo troppo brusco. Era rimasta con l’enorme palmo di lui (era l’unico tra i chirurghi che necessitava di guanti taglia 8 e mezzo) sul ginocchio sinistro, poi lui l’aveva stretto nel pugno, sorridendo e meravigliandosi del fatto che una rotula umana del tutto sviluppata potesse essere tanto piccola e rotonda (come una pallina da pingpong, aveva detto), poi le aveva afferrato entrambe le ginocchia con la stessa mano, sempre più divertito, l’aveva fatta scivolare sotto di esse, mentre con l’altra l’aveva attirata a sé, sulla poltrona verde portata lì dal vecchio ospedale, dov’erano i reparti di chirurgia, le aveva slegato il grembiule e l’aveva fatta sedere, come per gioco, su di sé, sulla sua virilità bramosa da chissà quanto.
In seguito, non si erano scambiati una parola, lui le aveva dettato il protocollo operatorio successivo, scegliendo con cura le parole: solo dopo aver controllato ciascuna frase, mormorando ogni tanto perfetto e guardandola dolcemente con i suoi occhi azzurri, le aveva domandato se non le occorresse dell’acqua ossigenata, lei aveva spalancato gli occhi ed era scoppiata a ridere. Va bene anche il sapone, aveva detto, ma in realtà aveva pensato, non si può avere acqua ossigenata a portata di mano ogni volta che si viene sverginate, e poi quella schiuma che si sarebbe formata, come in una operazione di routine, non era esattamente la cosa più erotica del mondo. Il sarcasmo, tuttavia, era svanito al vedere il dottor Negru tanto confuso quant’era grande: un gigante smarrito che sceglieva le parole a fatica e provava orrore per gli anacoluti.
Non si ricordava come mai fosse rimasta tutta la notte nella sala di guardia. Sapeva, dalle storie delle ragazze della Terapia Intensiva, che la “notte dopo” non si rimaneva mai. Si faceva la doccia nella sala infermiere per mille motivi: poteva capitare un’urgenza, il medico di guardia poteva essere chiamato in un altro reparto o ricevere una telefonata dalla moglie oppure – dalla porta non chiusa a chiave – poteva entrare qualcuno. Come rimanere sul lettino pieghevole, nel ronzio dell’ospedale che non dormiva mai, tra le braccia del dottore annoiato che ti mandava a chiamare per dettarti i protocolli operatori della sera? Non aveva idea del perché fosse rimasta, a un certo punto si era perfino addormentata, e quando si era svegliata, sollevata per averlo fatto, per averlo fatto, finalmente, si era rivestita svelta, che fortuna che quella sera indossasse il grembiule corto, invece della divisa da sala con i pantaloni e la casacca, aveva cercato gli zoccoli, aveva trovato anche la cuffietta frigia – doveva esserci il suo nome cucito all’interno, con il filo rosso – ed era corsa in corridoio. Era stata lì lì per slogarsi una caviglia sul cemento appena lavato. Aveva ritrovato l’equilibrio all’ultimo momento, aveva svoltato un’ultima volta – il blocco operativo era uno spazio rettangolare all’interno di un altro più ampio, quadrato, con le porte delle sale operatorie su ogni lato – ed era entrata nella doccia. Aveva sentito, quando già era sotto il getto bollente, dei colpi alla porta, una voce maschile, silenzio, e l’acqua leggera carezzarle la testa.
Aveva ancora i capelli umidi nell’asciugamano, non li aveva asciugati sulla stufa rovente, come avrebbe fatto se le cose fossero andate diversamente. In condizioni normali, la sterilizzazione degli strumenti andava sorvegliata. Se si fermava la corrente? Se si guastava lo sterilizzatore? Di solito sistemava uno sgabello di fronte alla stufa, prendeva un libro e leggeva. Di quando in quando sollevava gli occhi dal libro e fissava la minuscola lampadina rossa che le assicurava che la sterilizzazione stava procedendo. La osservava fino a non vedere più niente, fino a sentire il corpo perdersi lentamente in decine di luci notturne, inglobare la stufa ronzante e gli strumenti di acciaio che aveva lavato a lungo e sistemato su uno strato di garza – eccolo, il kit dei ferri, le pinze da presa per i campi operatori, 11 pinze Péan sistemate in fila in testa a una grande pinza da sutura, 11 pinze emostatiche Kocher, forbici Metzenbaum e il divaricatore Farabeuf, le pinze per legature Mathieu e quelle per ossa Liston, i bisturi ben affilati; kit per ginocchia, kit per protesi e anca, trapani di tutte le misure, martelli e scalpelli, e quello scalpello scheggiato, come diavolo era rimasto nel kit? La sua temperatura si era alzata all’improvviso di parecchi gradi, non aveva nemmeno bisogno del phon per asciugarsi i capelli, le si asciugavano comunque troppo velocemente e doveva nasconderli alla svelta sotto la cuffietta di doppia garza, ingiallita per le tante sterilizzazioni e che si legava due volte attorno al collo. Poi andava a caccia, con la lente di ingrandimento e la lampada a raggi ultravioletti, qualsiasi capello caduto sull'arenaria blu della sua sala operatoria. Tutto era diventato azzurro nei pochi mesi da quando lavorava là – le pareti, i piani dei tavoli, perfino le finestre erano state verniciate di modo che la luce del sole non modificasse in alcun modo le precise traiettorie della lampada scialitica. Un azzurro tenue, ma uniforme. Nello spazio tra il lavabo e la sala – dove due grandi serbatoi d’acqua ribollivano giorno e notte – era installata una porta scorrevole con un piccolo oblò oltre il quale tutto doveva essere sterilizzato, asettico, sfavillante, come diceva Pasquale, il capo di quella sala azzurra e di Maia, che ancora non capiva bene cosa le fosse capitato e come mai, invece di essere una studentessa di Medicina, fosse diventata infermiera in una piccola città di provincia.
Solo qui, chiusa nello spazio sterile, la città in cui era nata, cresciuta e rimasta per errore, era diventata soffocante. La città, ovvero tutto ciò che, negli ultimi quattro anni, si era sedimentato, coagulato attorno a quella futura partenza per Cluj, Bucarest, forse Monaco poiché, se fosse riuscita a lasciare una buona volta il paese, di certo sarebbe potuta rimanere là, le cose potevano cambiare, solo che quella partenza, la prima, per la quale il conto alla rovescia era già iniziato, era decisiva. Obbligatoria. Indiscutibile. Irrefutabile, si sarebbe detta più tardi, quando avrebbe imparato la parola. Tuttavia, non era partita, e per la vita che aveva cominciato – o continuato, ma lei non poteva accettare la cosa – non aveva alcun piano, alcuna aspettativa, alcuna considerazione. Come se avesse viaggiato in aereo, comodamente seduta su una poltrona destinata a portarla in un determinato luogo, e in un istante si fosse risvegliata al di fuori della fusoliera snella e argentata che separava lo spazio riparato dal rumore.
[…]
I capelli avvolti nell’asciugamano erano rimasti umidi a lungo o forse le si erano inumiditi per il sudore freddo che aveva avvertito all’improvviso accendendo la luce nella sala da bagno. Era una stanzetta angusta nella quale di rado venivano depositati campi operatori, seguita da una sala di passaggio in cui c’era un unico lavabo con lo specchio e dalla quale si accedeva direttamente alla doccia, in una stanza nella quale, per motivi poco chiari, c’era anche una finestra. Forse all’inizio non avevano pensato di sistemare la doccia lì. La finestra, attraverso la quale si poteva ben distinguere la silhouette all’interno, era un vero e proprio schermo erotico per la stanza di guardia dei medici, le cui finestre si trovavano esattamente sul lato opposto. Come se non bastasse, sui due lati del cortile interno c’erano anche due lunghi corridoi di passaggio: su quello di destra si aprivano le sale operatorie principali; nella parte di sinistra c’era invece la grande sala di rianimazione, dove si avventuravano spesso anche i parenti dei malati, i proprietari, come venivano chiamati, coloro ai quali appartenevano i malati-oggetti che, dal canto loro, appartenevano all’ospedale solo per una breve alleanza firmata con il sangue e conclusa con le dimissioni o il decesso. Più di una volta si era potuto vedere in quella stanza, sulla sinistra, un qualche osservatore casuale, un proprietario confuso dall’insperato spettacolo erotico della doccia delle infermiere, strofinarsi lentamente contro il calorifero freddo.
Quando uscì dalla doccia e accese la luce nella sala, cercando l’asciugamano che aveva lasciato sul bordo del lavabo, Maia scorse sul pavimento un lenzuolo insanguinato, un campo operatorio imbevuto di sangue che era finito là chissà come. Un rifiuto gettato a terra, probabilmente dalla sala di Urologia di fronte; voleva spingerlo con il piede, ma avvertì una certa resistenza, e quando si chinò per vedere cosa fosse – forse uno strumento smarrito e gettato nell’immondizia, per errore, insieme ai campi operatori – restò di sale. Completamente nuda, con i suoi nuovi zoccoli bianchi e traforati ai piedi, con i capelli bagnati pettinati all’indietro, Maia si chinò e vide, da una altezza minima, quasi pari alla distanza, una bambola coperta di sangue, gli occhi spalancati, le labbra strette e le braccine ben allineate lungo il corpo. Aveva pochi capelli, non come le bambole che aveva a casa, vecchi giocattoli che ancora conservava. Quella sul pavimento bagnato non aveva lo stesso colore biancastro, ma una sfumatura ocra, con macchie rosse sul mento e il corpicino, piuttosto informe, sarebbe stato più grazioso con un vestitino di quelli corti, come avevano tutte e anche loro, un tempo – lei e sua sorella, Rozina – così erano vestite quando andavano a scuola o all’asilo. Non aveva mai capito perché occorresse che il vestito (e poi il sarafano, l’uniforme e infine il grembiule) arrivasse fino in fondo, perché le bambine non potessero coprirsi quanto volevano, come se il pudore fosse una questione di età. Quando un amico di famiglia dalla testa rasata e che guidava una Volvo nera la prendeva sulle sue ginocchia dure come sassi, aveva molta premura di non sciuparle il grembiulino. La sollevava in aria, e con la mano le proteggeva l’uniforme azzurra, rifinita sul collo da un pompon rosso, e la faceva sedere direttamente sulla stoffa dei pantaloni kaki che le pizzicava le cosce. Si mise seduta. Quella bambola insanguinata non aveva avuto modo di indossare alcuna uniforme, alcun sarafano, alcun vestitino con i pizzi e la mantellina. Si era vestita da subito con pezze insanguinate e lenzuoli marrone, era stata lasciata sul pavimento ancora bagnato del bagno delle infermiere senza essere lavata e pettinata e confortata dalla violenza che l’aveva strappata dal suo mondo, e portata nel nostro.
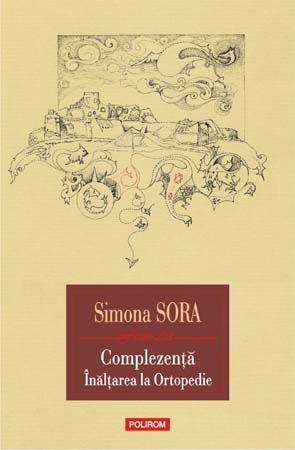
A cura di Sara Salone
(n. 1, gennaio 2024, anno XIV)
|
|