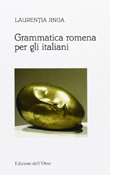|
|
Laurenția Dascălu-Jinga. Un ricordo
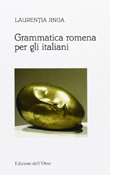 Laurenția Dascălu-Jinga è morta a Bucarest nel mese di settembre 2023, dopo lunga malattia. Era stata a lungo e fino al pensionamento ricercatrice all’Istituto di Linguistica «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» dell’Accademia di Romania a Bucarest. In Italia era stata lettrice di romeno a Padova dal 1992 al 1996, collaborando con me e con il prof. Roberto Scagno. Laurenția Dascălu-Jinga è morta a Bucarest nel mese di settembre 2023, dopo lunga malattia. Era stata a lungo e fino al pensionamento ricercatrice all’Istituto di Linguistica «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» dell’Accademia di Romania a Bucarest. In Italia era stata lettrice di romeno a Padova dal 1992 al 1996, collaborando con me e con il prof. Roberto Scagno.
Era nata a Fruzaru, in Oltenia, era vissuta a Braşov e a Bucarest. Il suo dominio di studio era stata la prosodia del romeno nei suoi aspetti costitutivi: l’intonazione, l’accento, la pausa, studiati teoricamente e anche sperimentalmente. È questa la parte più difficile da indagare di una lingua, e di fatto spesso la meno studiata, come prima di lei accadeva anche per il romeno. I frutti del suo lavoro in questo dominio sono apparsi lungo tutta la sua carriera di ricercatrice. Da alcune opere che ho sottomano ricavo una bibliografia imponente del suo lavoro più che trentennale, espresso in una grande quantità di articoli apparsi in riviste scientifiche [1].
Dalla fine degli anni Ottanta appaiono le sue opere in volume. Il primo, Melodia vorbirii în limba română, Bucarest, Univers enciclopedic, 2001, è una sintesi della materia a cui aveva dedicato tanta energia nelle sue lunghe ricerche. Il secondo è il prezioso Corpus de română vorbită (CORV). Eșantioane, Bucarest, Oscar Print, 2002. L’ultimo, Corectare și autocorectare ȋn conversație spontană, Bucarest, Editura Academiei Române, 2002, tratta dei mezzi che usa il parlante per correggersi mentre parla, un tema originale, che credo che in molte lingue nessuno abbia provato a trattare [2].
Prima di citare i due libri che ha dedicato a un dominio più vasto e diverso, l’insegnamento del romeno agli italiani, voglio ricordare brevemente almeno qualcosa del suo soggiorno a Padova, che è strettamente legato a questa sua esperienza.
Nell’anno accademico 1992-93 con Laurenția Dascălu-Jinga riprendeva dopo otto anni di silenzio il lettorato di lingua romena a Padova, previsto dall’accordo culturale tra i due paesi allora in atto. Era stato sospeso unilateralmente dalla Romania durante l’era Ceaușescu, nel 1984 con il ritiro improvviso del prof. Ion Neață. L’insegnamento della materia era stato affidato per supplenza a me, e quello della lingua a un «collaboratore ed esperto linguistico», ruolo che era stato istituito proprio allora. In quegli otto anni i collaboratori furono due, e noto qui i loro nomi, perché degni di grande stima ed elogio: Andreia Roman e Anca Bratu, quest’ultima purtroppo scomparsa prematuramente. Erano esuli tutte e due dalla Romania in Francia, ma furono felici di insegnare la loro lingua materna in un paese terzo, l’Italia, nonostante il sacrificio che i continui viaggi costavano loro.
Dopo il crollo del Comunismo in Romania nel dicembre del 1989 erano maturi i tempi per una ripresa dei rapporti italo-romeni a livello dei due stati. Il nome di Laurenția fu proposto dal ministero romeno a quello italiano, e per i rami, alla Facoltà di Lettere padovana, e accettato. Lo stipendio previsto per il collaboratore linguistico era parco, per usare un eufemismo, e gli inizi del soggiorno padovano di Laurenția Jinga non dovettero essere facili. Inoltre il comunismo aveva indotto nei romeni un timore panico di tutto e di tutti, di cui i romeni all’estero, come avevo potuto constatare, si liberavano difficilmente. Così la sua ambientazione a Padova non fu facile. Avemmo ancora un inverno freddissimo, come ce n’erano allora, e chi veniva dalla Romania si ricordava ancora della scarsezza di riscaldamento e dei tagli all’elettricità che aveva anche fatto numerose vittime nel paese. Si rinfrancò progressivamente. Intanto il suo insegnamento del romeno all’Università andava bene, molto bene. Gli studenti non solo seguivano con interesse i suoi corsi, ma si affezionavano a lei, e lei a loro. Come ricercatrice, non aveva mai insegnato prima, se non occasionalmente, ma scoprì di avere un talento speciale per insegnare, e che insegnare le piaceva. Un piccolo indizio di questo fatto si ha nella Prefazione della sua Grammatica romena per italiani dove ricorda e ringrazia, assieme ad alcuni docenti, anche dodici suoi studenti, dando di ognuno il nome (non il cognome), e aggiungendo alla fine: «e gli altri».
Frutto del suo insegnamento sono: la Grammatica romena per italiani, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, appena citata, e, in collaborazione con Angela Tarantino, allora ai suoi primi passi come assistente di Luisa Valmarin, ora ordinaria alla Sapienza di Roma, La lingua rumena. Morfologia e esercizi, Bucarest, Fundația Culturală Română, 1996. Ricordo anche un articolo dedicato questa volta all’italiano nella sua dimensione pragmatica, scritto con Laura Vanelli, Mi raccomando, eh! A pragmatic and phonetic analysis of the Italian intertjection, «Lingua e stile», XXI, 3, 1996, pp. 393-431. Questo articolo, e forse altri, mostrano l’allargarsi dei suoi interessi ad altri livelli della lingua parlata, come in questo caso le «particelle» (o più scientificamente «segnali discorsivi»), diventato in quegli anni un fruttuoso campo di ricerca in diverse lingue.
Si può dire che Laurenția Dascălu-Jinga abbia rappresentato così al meglio in Italia l’eccellente livello e la solidità che la linguistica romena aveva raggiunto negli ultimi decenni del Novecento, pur nel difficile contesto storico in cui si era sviluppata.
Lorenzo Renzi
(n. 2, febbraio 2025, anno XV)
NOTE
1. Nella sua sintesi in francese Intonation et prosodie (del romeno) nel Lexicon der romanistichen Linguistik (LRL) edito da Günter Holtus, Michael Metzeltin e Christan Schmitt, vol. III, 1989, pp. 7-13 appaiono in bibliografia diciassette suoi lavori dedicati a questo tema, otto in romeno e otto in inglese, più uno in francese in collaborazione con Sanda Golopenţia-Eretescu, apparsi tra il 1969 e il 1985. Altri sei titoli di articoli, di cui uno in collaborazione, dal 1975 al 2001, sono citati nell’articolo di Antonio Romano, Contributo allo studio della variazione intonativa di frasi dichiarative e interrogative, «Quaderni di Studi Italiani e Romeni», 2006, 2, pp. 121-133.
2. Per l’italiano ne aveva trattato, in un senso, a dire la verità, un po’ speciale, Leo Spitzer nella Lingua italiana del dialogo, ed. a cura di Claudia Caffi e Cesare Segre, traduzione di Livia Tonelli, Milano, Il Saggiatore, 2007, vedi nell’indice analitico le voci Autocorrezione e Correzione, pp. 372-73; ed. orig. tedesca Italienische Umgamgssprache, 1914.
|
|