









|
|
La peggior bestia è l’uomo: «I racconti di Kolyma»
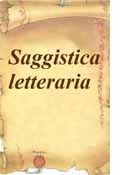 Ho già parlato, su questa rivista, della profonda impressione che riportai dalla lettura di Arcipelago GULag, la scioccante trilogia di Alexandr Solženicyn che rivelò al mondo la mostruosa realtà dei lager staliniani. Ho già parlato, su questa rivista, della profonda impressione che riportai dalla lettura di Arcipelago GULag, la scioccante trilogia di Alexandr Solženicyn che rivelò al mondo la mostruosa realtà dei lager staliniani.
La successiva pubblicazione dei Racconti di Kolyma (o Racconti della Kolyma) di Varlam Šalamov ci avrebbe confermato che l’inferno in terra è esistito, che Gulag e feccia della Storia sono sinonimi.
Ho letto molti libri sulle atrocità di cui è capace l’essere umano; se nessuno può eguagliare I racconti di Kolyma è per due ragioni: la varietà e l’efferatezza del male che emerge dalle sue pagine, e l’assoluta adesione dell’autore alla realtà dei fatti. A tale proposito, Irina P. Sirotinskaja, curatrice dell’edizione integrale dei Racconti, scrive: «Questo libro è indirizzato all’anima di ogni uomo. Šalamov, intenzionalmente, rifugge ogni meditata letterarietà che possa allontanare lo scrittore dal lettore, una letterarietà “sacrilega in un testo come questo”. Egli esige che il lettore prenda parte alla creazione, al dolore, alle emozioni, all’ira. È illimitatamente sincero, illimitatamente veridico. Spietatamente veridico».
Per comprendere il tragico fondamento dei Racconti di Kolyma non esiste miglior giudizio di quello espresso dallo stesso Solženicyn nel capitolo La vita quotidiana degli indigeni del secondo volume di Arcipelago GULag: «L’esperienza dei lager di Šalamov è stata più amara e lunga della mia, e io ammetto rispettosamente che proprio a lui, non a me, è toccato sfiorare quel fondo di abbrutimento e di disperazione verso il quale ci trascinava tutta la vita del lager».
Ma è possibile descrivere il gelo del corpo e dell’anima - quello stesso che trasformava in ghiaccio uno sputo in volo - la fame, le percosse, la crudeltà, conservando il fascino della scrittura? È possibile versare il sangue nelle proprie parole e rilasciare una grande opera narrativa? La risposta è in questo capolavoro storico e letterario dove l’intento dell’autore è chiarissimo: «Non ho diritto di parlare per nessun altro eccetto forse per quelli morti nella Kolyma. Voglio esprimere la mia opinione sul comportamento umano in determinate circostanze, e non per dare lezioni a qualcuno. Ma penso che chiunque legga le mie storie si renda conto di quanto siano futili le vecchie idee e gli schemi della letteratura tradizionale».
Varlam Tichonovič Šalamov, nato il 18 giugno 1907 a Vologda, nella Russia nordoccidentale, viene arrestato nel 1929 per aver diffuso la «Lettera al Congresso» di Lenin, e condannato a tre anni di internamento in un lager degli Urali settentrionali. Arrestato nuovamente nel gennaio 1937 con l’accusa di attività controrivoluzionaria trockista, trascorrerà altri 14 anni nei gulag sovietici.
«La prosa vissuta come documento»: questo il programma di Šalamov; e i documenti sono gli eventi stessi, la dimostrazione che nessun uomo è più tale quando deve muoversi nel vuoto di ogni valore morale. Non c’è pagina dei Racconti di Kolyma che sottragga il lettore alla pena, all’incredulità, al dolore, alla riprovazione per l’orrore di un universo concentrazionario nel quale, attraverso una serie continua di violenze e umiliazioni, l’individuo veniva spogliato per intero delle sue componenti umane. Un quadro disperante, diabolico, dove poteva accadere che i misfatti commessi dagli autori di gravi delitti venissero eguagliati in crudeltà da quelli dei loro carcerieri, e via via dei capisquadra, dei dirigenti dei campi, dei loro superiori.
Nel capitolo Come incominciò: «Era sufficiente dire a voce alta che il lavoro era faticoso per essere fucilato. La più innocente affermazione nei confronti di Stalin: fucilazione. Anche tacere quando tutti gli altri gridavano “hurra!” all’indirizzo di Stalin, poteva comportare la fucilazione. (…) Per quali altri motivi si poteva finire fucilati? “Per offesa alla scorta del lager”. In cosa consisteva? Poteva trattarsi di un’offesa verbale, di una risposta non sufficientemente rispettosa, di qualche “conversazione” in replica a colpi, botte, spintoni. Un qualsiasi gesto troppo disinvolto del detenuto in una discussione con un soldato di scorta veniva considerato alla stregua di una “aggressione”».
Nella sezione intitolata Scene di vita criminale, Šalamov delinea con tratti nitidi la perversa struttura del mondo kolymiano. Nei gulag sono presenti i «nemici del popolo» (i prigionieri politici condannati per «attività controrivoluzionaria» in base al famoso art. 58), i delinquenti comuni e i malavitosi. Sono questi ultimi a dirigere il mondo sotterraneo dei lager, i «padroni della vita e della morte». Cresciuti fin dalla più tenera infanzia nelle tradizioni della malavita, nell’odio accanito che questa nutre per il mondo intero, gli urkagany sono gli «uomini veri», il «mondo criminale», quelli che vivono con proprie leggi, un proprio codice e un proprio gergo; tutti gli altri internati sono i fraera, i «fessi», quelli che non possono evitare in alcun modo di essere sfruttati, derubati, seviziati, uccisi.
Nel 1938 tra le autorità e la malavita si costituisce un «concordato» quasi ufficiale tramite il quale servirsi dei malavitosi come arma nella lotta contro i «trockisti» e i «nemici del popolo».
«“Questa gente è stata mandata qui per essere sterminata e il vostro compito è di aiutarci”, furono le testuali parole pronunciate all’inizio del ’38, durante una lezione ai corsi, da Sarov, ispettore della Kvč del giacimento Partizan». È facile immaginare la pena, il tormento, l’assoluta impotenza di persone comuni e innocenti a contatto con delinquenti privi di qualsiasi scrupolo morale.
Nel capitolo intitolato Sangue di furfante, così scrive Šalamov: «“La peggior bestia è l’uomo”, il diffuso proverbio malavitoso, è anche qui da intendere nel senso più letterale e concreto». E ne fornisce l’immediata dimostrazione: «Le azioni teppistiche sono troppo pure e innocenti per un malavitoso. Loro si divertono in altro modo. Ammazzare uno, sventrarlo, tirarne fuori gli intestini e con quelli strangolare un’altra vittima, ecco, questo è nel loro stile, e cose del genere si sono viste. Nel lager capitava spesso che ammazzassero qualche caporale, ma segare il collo a un uomo da vivo con una sega a due manici – un’idea tanto macabra poteva concepirla solo il cervello di un malavitoso, non quello di un essere umano».
Il nostro cuore si ghiaccia quando leggiamo il brano del capitolo Sentenza dove si affaccia la parola «amore», ma coniugata in questo modo: «L’amore non mi tornò. Ah, com’è distante l’amore dall’invidia, dalla paura, dalla rabbia! Quanto poco bisogno ne hanno gli uomini! L’amore sopraggiunge soltanto quando tutti gli altri sentimenti sono tornati. Arriva per ultimo, ritorna per ultimo, ma ritorna poi davvero? E tuttavia l’indifferenza, l’invidia e la paura non erano i soli testimoni del mio ritorno alla vita. Prima che per gli uomini, mi era tornata la compassione per gli animali».
Un sentimento non comune, in verità, nel Gulag. Nessun animale godeva della minima pietà da parte dei malavitosi. È noto che leggendo Una giornata di Ivan Denisovič, Šalamov scrisse a Solženicyn: «E come mai lì da voi va in giro un gatto nell’ospedale? Come mai non l’hanno ancora ammazzato e mangiato?»
In Giorno di riposo, racconto dove Šalamov afferma il ruolo salvatrice della poesia in un luogo dove tutto veniva dimenticato, assistiamo a una scena insostenibile. Due malavitosi facevano il solletico e giocavano con un cucciolone di cane pastore, che uggiolava e si dimenava sotto le carezze. Uno dei malavitosi gli palpava il fianco vicino al cuore, tenendolo per il collare. «Il cucciolo», scrive Šalamov, «guaì fiducioso e leccò la mano dell’uomo. “Ah, pure la leccata… Ma mi sa che non leccherai più. Senja!” Sempre trattenendo con la mano sinistra il cucciolo per il collare, Semën tirò fuori da dietro la schiena un’accetta e con un colpo breve e rapido la calò sulla testa del cane. Il cucciolo dette uno strattone, il sangue schizzò sul suolo gelato dell’attrezzeria. (…) La sera il profumo del brodo di carne impediva all’intera baracca di prendere sonno, e si aspettava solo che i malavitosi finissero di cenare».
In Occhi coraggiosi, la violenza su una bestiola inerme sigilla vergognosamente il rapporto che l’essere razionale e cosciente intrattiene con le creature innocenti che sono da sempre nostre compagne di viaggio sulla Terra. Il pavido geologo Machmutov, colpendo il tronco cavo di un larice crollato sul sentiero, ne vede uscire una donnola che sta per partorire. Prima che i suoi compagni di lavoro possano fermarlo, l’uomo spara a bruciapelo sulla bestiolina, che inizia a strisciare verso di lui: «Una zampa posteriore della donnola gravida era stata strappata via dallo sparo ed essa si trascinava dietro la poltiglia sanguinolenta dei suoi piccoli non ancora nati, che avrebbero potuto nascere da lì a un’ora, quando io e Machmutov ci fossimo lasciati alle spalle il larice abbattuto, destinati, nascendo, a entrare nel mondo difficile e severo degli animali della tajga. Vidi la donnola trascinarsi verso Machmutov, vidi l’ardimento, la collera, la vendetta, la disperazione nei suoi occhi. Vidi che in essi non c’era traccia di paura. (…) Sopraggiunse Pikulev, si chinò sulla bestiola morta e disse: “Aveva degli occhi coraggiosi”».
Il dolore del cuore che «uccide coi suoi tormenti prima di qualsivoglia punizione», lo avevo già trovato, oltre che in Arcipelago GULag e nella letteratura sui campi di sterminio nazisti, nelle Memorie da una casa di morti di Dostoevskij, opera in cui il grande scrittore riporta l’esperienza dei quattro anni di lavori forzati nella colonia penale di Omsk, a seguito di una condanna per «partecipazione cospiratoria a una società segreta».
Il male metafisico e quello che si esprime nelle forme più brutali, la viltà e il coraggio, i pusillanimi e gli uomini capaci di un completo dominio di se stessi, gli assassini allegri e alieni da qualsiasi rimorso e le anime intrise di una bontà inscalfibile, la disperazione e le speranze folli e insopprimibili: tutti questi caratteri ricorrono nell’opera di Šalamov come in quella di Solženicyn. Diverso è il discorso per le Memorie da una casa di morti, dove troviamo una prosa più distesa, e, nella sostanza, una certa dimensione umana e un barlume di speranza che sono assenti dai Racconti di Kolyma. Una caratteristica che non sfuggì a Šalamov, che nel capitolo A proposito di un errore della letteratura, accusa Dostoevskij di aver dato dei malavitosi un’immagine non realistica, così come Victor Hugo, Gor’kij, Babel’, Leonov, Pogodin e altri. Šalamov non ha timore di parlare di un certo compiacimento di questi scrittori nella descrizione dei malavitosi, di «romanticismo criminale» e «poeticizzazione della delinquenza». Altra è la realtà, afferma, perché il criminale di professione è un uomo che ha smesso di essere uomo, e va raffigurato per quello che è, biasimato come tutto ciò che è moralmente inammissibile.
In una lettera diretta a Boris Pasternak, dopo aver riferito alcuni degli allucinanti episodi di vita dei lager, Šalamov scriveva: «L’essenziale non è qui, ma nella corruzione della mente e del cuore, quando giorno dopo giorno l’immensa maggioranza delle persone capisce sempre più chiaramente che in fin dei conti si può vivere senza carne, senza zucchero, senza abiti, senza scarpe, ma anche senza onore, senza coscienza, senza amore né senso del dovere. Tutto viene a nudo e l’ultimo denudamento è tremendo. La mente sconvolta, già attaccata dalla follia, si aggrappa all’idea di “salvare la vita” grazie al geniale sistema di ricompense e sanzioni che le viene proposto. Questo sistema è stato concepito in modo empirico, giacché è impossibile credere all’esistenza di un genio capace di inventarlo da solo e d’un sol colpo…».
«Quando leggiamo I racconti della Kolyma di Šalamov», ha scritto Pietro Citati, «ci rendiamo conto che nessuna forma di immaginazione supera, nell’uomo, quella del male: come se il proibito, l’intentato, il vietato suscitino in noi una fantasia sinistra, che non può mai placarsi e trovare un limite».
Credo anch’io che non sia esistito luogo al mondo dove si sia manifestato in modo peggiore lo spirito, sempre presente, di Caino. Ma nella Bibbia assistiamo anche all’azione salvifica di Dio. Non qui, dove agisce solo l’uomo; e se proprio volessimo accostarci ai Libri Sacri, nella Kolyma rintracceremmo un’eco del Qohélet, quel senso dell’inutilità del tutto, del tormento che accompagna la razza umana, del cadere di ogni cosa, prima o poi, sotto il dominio della morte. Ma nella tirannide quotidiana dei gulag sovietici, la morte non aveva bisogno di aspettare: era presente nella vita di quei disperati ogni ora, ogni istante.
Il libro di Šalamov mi ha confermato nel pensiero maturato tanti anni fa: non è perché siamo fatti a immagine di Dio che occupiamo la cima nella gerarchia degli esseri viventi; la ragione è che dal nucleo rettiloide di una delle specie nostre antenate si è sviluppata la coscienza, la cognizione del bene e del male. Ma il primo lo facciamo quasi sempre con riserva, o con un recondito interesse; il male lo facciamo con convinzione, con purezza di intenti, insomma con lo spirito giusto.
Armando Santarelli
(n. 3, marzo 2025, anno XV)
|
|

