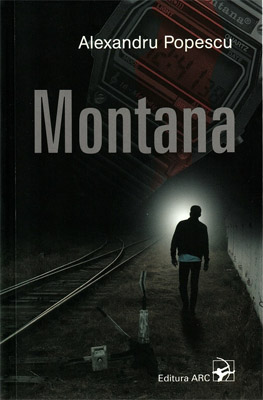|
|
«Montana», il romanzo di debutto di Alexandru Popescu
 Il romanzo Montana, opera di debutto di Alexandru Popescu, racconta la vita di Ivan Josan, tra lo spazio della Transnistria negli anni ’90 e il Regno Unito dei nostri giorni, tra infanzia e maturità, procedendo su un doppio piano temporale e geografico che, muovendosi tra flashback e flashforward, rende la narrazione molto dinamica. Il romanzo Montana, opera di debutto di Alexandru Popescu, racconta la vita di Ivan Josan, tra lo spazio della Transnistria negli anni ’90 e il Regno Unito dei nostri giorni, tra infanzia e maturità, procedendo su un doppio piano temporale e geografico che, muovendosi tra flashback e flashforward, rende la narrazione molto dinamica.
Da una parte, la traumatica infanzia passata a Bender, la base, la guerra russo-moldava del ’92 e la realtà transnistriana bloccata in un immobile tempo sovietico e, dall’altro, la maturità di Ivan, giornalista televisivo che vive in Inghilterra, convive con la sua compagna Claire e cerca di gestire traumi e problemi psicologici (depressione, attacchi di panico, terribili incubi ecc.) legati al suo passato. In particolare, binari e treni in movimento generano in lui incontrollabili crisi di panico.
Il ritorno forzato e clandestino di Ivan a Bender, a causa di un infarto che coglie sua madre, è il pretesto per un nuovo confronto con il mondo dell’infanzia e con i fantasmi che lo popolano, un confronto risolutivo con il proprio passato ma anche con la storia recente e ancora aperta della Transnistria, della guerra, e con la figura di suo padre, vittima collaterale del conflitto. Proprio in questo contesto in cui il passato diventa presente in una Bender immobile ed eternamente post-sovietica, quell’orologio “Montana”, tanto desiderato dal piccolo Ivan e mai ricevuto, diventerà quasi uno strumento di riconciliazione tra l’adulto e il bambino, nonché il motore di un’azione finale avventurosa e folle in cui Ivan rischierà la vita.
Quanto allo stile, la scrittura di Popescu è asciutta e limpida, precisa ma senza eccessi descrittivi, e capace di sostenere pienamente il filo della doppia narrazione. Pur nella durezza delle immagini che descrive, la voce narrante non indugia mai in facili sentimentalismi o patetismi, non commenta e non impone un singolo punto di vista, lasciando piuttosto al lettore la possibilità di tirare le somme di fronte alla galleria di situazioni e personaggi che appaiono tra le pagine.
Con Montana, Alexandru Popescu ci restituisce una delle narrazioni più serie e veritiere sullo spazio della Transnistria di oggi.
Nota biobibliografica
Alexandru Popescu (Bender, 1987) ha portato a termine la Facoltà di Scienze della comunicazione presso la Libera Università Internazionale della Moldavia e ha lavorato come reporter per diversi canali TV di Chişinău. Dal 2014 è corrispondente di radio «Europa Libera». Attualmente, vive in Inghilterra e Montana (Ed. Arc, 2022) è il suo brillante debutto letterario. Nel 2023 ha inoltre pubblico il suo secondo romanzo Adâncuri incolore (Abissi incolori) sempre per l’editrice Arc.
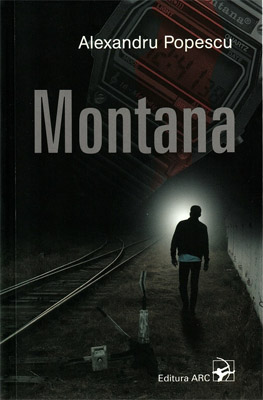
2
PMS n. 131, città di Bender, Repubblica Sovietica Socialista Moldava. Ho appena menzionato un indirizzo di domicilio, un indirizzo strano, lo riconosco. Tutti dicevano sembrasse il numero di un container marittimo o il modello segreto di un carrarmato russo, più che un indirizzo. La seconda impressione in un certo modo si avvicina alla realtà. Non ci ha vissuto solo la mia famiglia. Eravamo decine di famiglie, poco più di cento persone. Molti fissavano contrariati i nostri passaporti e cercavano un qualche numero civico. Non lo trovavano, perché non c’era. “Dove diamine è?” era una domanda rivolta spesso da vari impiegati pubblici e anche dai cittadini che stavano dall’altra parte del muro. Mio padre spesso corrugava la fronte e rispondeva agitato: “Le ferrovie!”. Quella risposta nelle sue intenzioni era l’ultima e la più esplicita. Ed era esplicita, perché tutti sapevano chi fossero i ferrovieri: persone con voci e risate d’acciaio. E con loro era meglio non impicciarti. PMS è un’abbreviazione dal russo che sta per Stazione di Macchine da Trasporto [1]. Era una specie d’impresa mobile, legata alle ferrovie sovietiche. Le PMS erano sparpagliate a centinaia per tutta l’Unione Sovietica, ma non hanno più potuto dimostrare la loro efficienza dopo la caduta dell’impero rosso. Oggi non puoi nemmeno definirle realmente perché hanno perso il loro scopo. Quasi tutte le PMS sono state smantellate poco dopo il collasso, e rottamate insieme alle speranze degli operai in un futuro più luminoso.
Noi, quelli della PMS n. 131 chiamavamo quel territorio in un modo, diciamo così, accogliente: la base. Oltre all’uso consueto di questa parola, base significava appartenere a una comunità quasi chiusa, sebbene si trovasse, in pratica, nel cuore della città di Bender. Perciò, la base per noi era casa, famiglia e un set di regole di comportamento, se non proprio un modo di pensare particolare. Il tempo l’ha dimostrato.
Lo scopo tecnico della base era costruire o riparare binari sul territorio della RSS Moldava e in alcuni distretti dell’Ucraina Sovietica. Se da qualche parte le traversine marcie mettevano in pericolo l’operatività dei treni, allora i ragazzi acciaio della base, così come si autodefinivano, si mettevano subito al lavoro. Alla base, gli operai assemblavano pannelli di binari lunghi almeno venti metri, che erano trasportati su un convoglio di manovra, carico di ragazzi d’acciaio, in non so più quale posto sperduto. Sapevo solo che mio padre spariva giorni e settimane intere. Succedeva spesso di avere inverni terribili che seppellivano i binari sotto montagne bianche di neve insieme a locomotive incagliate qua e là. Chi pensate si occupasse di liberarli da sotto la neve? È evidente. Gli operai della base erano una specie di servizio di soccorso per l’infrastruttura ferroviaria. […] Direi che quegli uomini fossero nomadi tormentati dell’Unione Sovietica. Eppure la PMS n. 131 non si muoveva mai. Ai bambini non si davano troppe spiegazioni sulle attrezzature sofisticate presenti sul territorio. Dovevamo imparare strada facendo e scoprire la base, quasi sempre senza nessuno adulto a sorvegliarci. Perciò, mi assumo la responsabilità di raccontare tutto dalla prospettiva di un ragazzino nato e cresciuto lì, compresi i ricordi dei disastri che si sono succeduti e che hanno cambiato le nostre vite per sempre.
Mi meravigliava molto sentire che dall’altra parte del muro la gente abitasse in strade che portavano il nome di qualcuno. Neppure l’espressione casa di famiglia aveva troppo senso nel nostro caso. Puoi chiamare casa di famiglia qualcosa che sta su ruote d’acciaio, pronta a muoversi in qualsiasi momento, trainata da una qualche vecchia locomotiva?
La nostra base era lunga circa settecento metri e larga almeno 150. Perciò, non credo di mentire se dico che il mio universo di allora si riassumeva a una superficie di circa due chilometri quadrati. Potrebbe sembrare uno spazio ristretto agli occhi di un adulto, ma per me la base era una sorta di città nella città, dove rischiavo di perdermi e dove scoprivo un’infinità di nascondigli. […]
Per quanto bruciante fosse la nostra sete di avventure, nessun bambino aveva mai avuto il coraggio di violare la regola più importante: era assolutamente vietato scavalcare il muro. Neppure gli adulti potevano farlo. Il muro rappresentava la frontiera, il limite dell’ammissibile, il confine dell’Universo. Gli davamo un’importanza quasi metafisica. Tutti gli estranei che entravano nella base erano etichettati con un’espressione accettata all’unanimità: “Quelli che stanno dall’altra parte del muro”. Ci lanciavamo risposte del tipo “Questi arrivano dall’altra parte del muro?”, oppure “Guarda che bicicletta si è comprato dall’altra parte del muro!” o anche “Ho sentito che dall’altra parte del muro è una catastrofe!” e via dicendo. Non scavalcare il muro perciò era l’ordine numero uno nel giardino dell’Eden di cemento e pezzi di ferro ritorti in cui vivevamo. Ma, in ogni gruppo, esiste sempre una carogna che calpesta impassibile la pace e il fragile equilibrio umano. Il suo nome era Pașa. Era un po’ più alto degli altri bambini del gruppo e aveva un’insopportabile faccia da rospo. In quella giornata degna di nota, gli adulti lavoravano sudati sotto il sole ardente e sembravano troppo occupati per stare dietro a noi bambini. Pașa, senza dire niente a nessuno, aveva scelto un punto appartato per studiare il muro. Ma visto che alla base i segreti si dissolvevano come benzina all’aria, dopo qualche secondo, Pașa si ritrovò ad avere sette spettatori alti un metro e venti, ansiosi di godersi lo spettacolo. Mi ricordo che lo osservavamo in silenzio mentre ammassava delle casse di legno sotto il muro, con uno strano sorriso in volto e gli occhi strabuzzanti. La sua costruzione suggeriva degli enormi gradini.
“Non fare stupidaggini Paaaș!”, gridò uno dei ragazzi. Era l’ultimo appello alla ragione di fronte alla follia collettiva che stava per scatenarsi. Pașa mormorò qualcosa tra i denti e salì il primo gradino. Non lo perdevano di vista. È impossibile descrivere cosa abbiamo provato quando, pochi istanti dopo, l’abbiamo visto in cima al muro a muoversi come in groppa a un cavallo. Guardavamo sconvolti quanto si sforzasse di alzarsi in piedi. Cosa che poi è successa. “Sono in cima al mondo!”, gridò Pașa con voce stridula. Che altro dire. Il ragazzo era in trionfo. Noi lo seguivamo come paralizzati, con le bocche spalancate. Alcune voci hanno domandato contemporaneamente: “Che cosa vedi Pașa? Cosa c’è dall’altra parte?” Il farabutto in cima al muro rispose, guardandoci dall’alto, di vedere pietre preziose e giocattoli, una distesa interminabile. Gli abbiamo creduto. Uno stormo di passerotti volò di traverso tagliando la giornata azzurra, quasi a cercare di fermarci. L’istante successivo ci siamo precipitati verso le fragili casse di legno. “Per la Patria! Per Mamma!”, urlava qualcuno con voce rotta. Credo fosse Denis, il ragazzino con la faccia da vecchio. Aspettavo in fila che arrivasse il mio turno. Per un attimo mi sono bloccato, pensando che il gioco fosse diventato troppo serio, ma non si poteva più tornare indietro. Dovevo seguire i miei amici, altrimenti, mi avrebbero preso in giro e chiamato stupido nanerottolo.
Osservavo dal basso le sagome di quegli otto ragazzini che urlavano qualcosa d’incomprensibile. Ero un po’ più basso degli altri, però mi ero già arrampicato sulle casse di legno. La parte difficile doveva ancora arrivare. Il bordo superiore del muro si dimostrò un po’ più lontano del previsto e non riuscì ad aggrapparmici al primo salto. Qualcuno, dall’alto, mi tese una mano sudata. L’ho stretta forte e ho scalciato nell’aria. Un’altra mano mi afferrò dal braccio sinistro. “Dai, Vania! Che sei una femminuccia?”, risuonò la voce Pașa. Seguirono scoppi di risa alquanto teatrali. Pașa era due anni più grande di me e mi considerava una specie di apprendista. In quel momento non avevo la minima idea di cosa significasse la parola femminuccia. La presi addirittura come un complimento. Altri due ragazzi mi hanno teso mani tremanti. Le afferrai entrambe. Ero quasi in cima quando ho sentito la stretta dei miei compagni indebolirsi. Quasi tutti avevano le mani unte e sudate. Tutto quello che riuscii a fare fu lanciare un urlo animalesco e gustare quel secondo paralizzante di caduta libera.
Non ho sentito granché quando ho urtato il suolo con le spalle. Probabilmente ero troppo emozionato per sentire dolore. Ho alzato appena la testa e mi sono guardato intorno. Ho realizzato di essere atterrato sull’erba bruciata dal sole, che avevo rotto con i piedi una cassa di legno e che purtroppo la costruzione di Pașa era crollata. “Ivaaaaan”, urlò dall’alto uno dei ragazzi. Sono rimasto steso, immobile, qualche istante. Da qualche parte, oltre i vagoni, si distingueva il rombo costante di una locomotiva. “Subito! Riparo subito tutto!”, udii la mia voce un po’ rotta. Ho cercato di alzarmi ma ho sentito che la gamba destra, nascosta tra le erbacce, mi si era intorpidita e rifiutava i miei comandi. Qualcuno dall’alto ha urlato di nuovo il mio nome e guardava sconvolto la mia gamba inerte. Sul volto di tutti si leggeva già l’orrore. Pașa si coprì la bocca con una mano. Gli altri cominciarono ad agitarsi istericamente, cercando di scendere dal muro.
Mi sono messo a sedere, confuso. Poi ho sentito le mie pupille dilatarsi di terrore. Il taglio sulla gamba destra si apriva intorno alla caviglia e proiettava un sottile getto di sangue sull’erba incolore. Mi ha assalito una crisi di soffocamento e la sensazione di avere un nodo in gola. Sono rimasto semplicemente pietrificato. Gli altri continuavano a guardarmi impotenti dalla cima del muro. Non ci pensavano nemmeno a saltare. Il muro era troppo alto. Le loro voci deluse lanciavano urla simultanee, simili a un’artiglieria verbale che, ad ogni modo, sortì un effetto. Dopo un attimo mi sono visto circondato da almeno cinque adulti con le facce sbigottite e le mani sporche di morchia. Ricordo che qualcuno iniziò a urlare bestemmie. Uno di loro mi prese in braccio. Un altro cercò di fermare l’emorragia con un fazzoletto sporco. Solo allora ho sentito il dolore lancinante. Lanciai un urlo disperato. L’uomo che mi teneva in braccio cominciò a correre. In quel momento, per una frazione di secondo, sono riuscito a vedere oltre il suo omero sudato. Tra i fili d’erba, schizzati di un rosso acceso, s’intravedeva luccicare qualcosa. Quell’immagine persiste ancora oggi nei miei incubi. Era un enorme coccio di vetro, rosso come un rubino, da cui pendeva un’etichetta con una scritta argentata su fondo nero: “Советское шампанское” [2]. Negli istanti seguenti, tutti i colori del giorno che vedevo, svanirono in un’oscurità letargica.
A cura e traduzione di Clara Mitola
(n. 9, settembre 2023, anno XIII)
NOTE
1. ПМС (Путевая Машинная Станция).
2. Champagne sovietico.
|
|