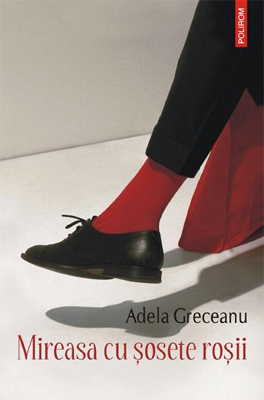|
|
Esclusivo. Brani in italiano da «La sposa dalle calze rosse», di Adela Greceanu
 Nel nostro Focus dedicato al tema della scrittura negli autori romeni figura Adela Greceanu. Poetessa per vocazione, si cimenta per la prima volta con la prosa in questo romanzo delicato dal suggestivo titolo La sposa dalle calze rosse (Iaşi, Polirom 2008), che ci conduce e ci invita a circumnavigare due mondi distinti, ma intersecanti: quello sospeso in una dimensione onirica e quello, per contrasto, calato nella realtà più banale. Nel nostro Focus dedicato al tema della scrittura negli autori romeni figura Adela Greceanu. Poetessa per vocazione, si cimenta per la prima volta con la prosa in questo romanzo delicato dal suggestivo titolo La sposa dalle calze rosse (Iaşi, Polirom 2008), che ci conduce e ci invita a circumnavigare due mondi distinti, ma intersecanti: quello sospeso in una dimensione onirica e quello, per contrasto, calato nella realtà più banale.
Il libro è diviso in due parti: nella prima s’intrecciano le voci di quattro donne un po’ in là cogli anni, petulanti e un po’ bizzose, ciascuna con una propria personalità ben marcata (comare Lena, la cugina Pulheria, zia Zizi – una sorta di voce dell’al di là perché in realtà già defunta – e zia Sofica, l’intellettuale, per così dire, della combriccola), sorprese mentre sono intente ad acconciare riccamente i capelli di una giovane sposa, la loro interlocutrice; questa giovane sposa indossa, per l’occasione, delle calze rosse, secondo un’usanza – nel libro non si fa però alcun riferimento a tradizioni popolari –, in vista delle sue nozze, che si dovranno celebrare, senza tuttavia che esse si concretizzino, il mattino seguente (detto per inciso, anche la Lucia manzoniana porta delle calze rosse (vermiglie) il giorno del suo fallito sposalizio…). Tutta l’azione di questa prima parte ha luogo perciò nelle ore prima del sorgere del sole, tra la notte e l’alba. Ad animarla sono quindi i dialoghi delle quattro donne, inframmezzati dagli interventi della sposa, che entra ed esce dal flusso narrativo, stuzzicata, pungolata dalle sue gaudenti e attempate ancelle. Il narrare dei personaggi femminili è rapsodico, come in una conversazione tra amiche in cui gli spunti di discussione entrano ed escono senza un ordine prestabilito, senza quasi un filo logico. È appunto questo fitto parlottare quasi ininterrotto che rende così peculiare questi dialoghi, che, pur nella loro apparente incoerenza, danno la cifra espressiva e deliziosamente immaginativa di questa parte del libro.
Nella seconda parte, invece, si cambia completamente di registro: dal brioso, caotico pettegolo, svagato, onirico dialogare delle cinque donne si passa a un racconto solitario, quasi un dialogo interiore, una sorta di diario intimo, in cui la voce narrante si sperde nell’alienante solitudine urbana, con minute descrizioni di banali azioni quotidiane, ripetute come un automa, secondo un comportamento che sfiora l’autismo. Sullo sfondo di questo vuoto esistenziale appaiono cinque figure maschili (Paul, Șerban, Adam – un polacco –, Mihai e Alexandru), corrispondenti alle cinque storie sentimentali vissute dalla voce narrante, figure ora solo rievocate, ora dialoganti nel testo, passate in rassegna dall’autrice come storie indipendenti ma che si intersecano, che riaffiorano, che entrano ed escono dalla vita affettiva della voce protagonista. Sono cinque figure maschili che hanno un loro collegamento con le altre figure maschili, senza un nome ma designati con appellativi come «giovanotto suicida», «un albero bello» ecc. incontrate nella prima parte, da cui la sposa dalle calze rosse doveva prendere congedo prima di sposarsi; in tal modo il filo narrativo ritorna ciclicamente come in un anello di Moebius, in una spirale degli affetti che si perpetua e si sdoppia in distinte realtà. In tal senso, la prima parte è quindi dominata dal cicaleccio serrato delle quattro signore dialoganti con la sposa, la quale squarcia però qua e là quel loro denso e vivace conversare con le sue uscite fantasiose e oniriche, mentre la seconda, in cui i dialoghi sono ridotti al minimo, è tutta giocata su una narrazione interiore, con descrizione di azioni ripetitive, monotone, che esprimono però in modo magistrale la lucida volontà da parte della protagonista di isolarsi dal mondo circostante, nonostante i continui e tenaci «attacchi» dall’esterno.
L’autrice fa uso di un linguaggio semplice, essenziale, misurato quando descrive il rarefatto isolazionismo della voce narrante della seconda parte; e in linea di massima è così anche nella prima parte del romanzo, anche se, nei momenti in cui intervengono le loquaci signore, si carica di colore e di espressività verbale, connotata stilisticamente da un intercalare di impronta popolare, tipico del parlato quotidiano (fa eccezione Sofica, l’intellettuale, come si diceva sopra, che usa sempre un vocabolario alto e ricercato), atto a cogliere il crepitio del fuoco di fila del loro dialogare ininterrotto. Le immagini e l’atmosfera che la scrittrice sa creare attraverso questa sua particolare scrittura ci introducono in un mondo a volte sorprendente, dove accadono cose al limite del paradossale, dove fanno capolino ora Platone, ora Fidel Castro… perché la sposa è un’allegoria, non sembra una persona in carne e ossa, ma un’idea, la voce metafisica della narratrice che ingarbuglia la realtà per rimbalzarla al lettore come un gomitolo aggrovigliato, offrendogliene un bandolo perché tenti di sbrogliarla lui, se lo vuole.
È un romanzo nel quale si viene condotti dentro una storia sospesa tra realtà e sogno, tra quotidianità e bisogno di fuga da essa, una storia delicata, tributaria senza dubbio della sensibilità poetica dell’autrice, che spalanca al lettore un universo dove poter errare con l’immaginazione, smarrendosi nel labirintico ondeggiare della narrazione.
Nei due estratti dal romanzo qui proposti, il lettore avrà modo di saggiare proprio questi due mondi opposti ma comunicanti tra loro, all’interno del romanzo – per tale ragione è imprescindibile leggere il romanzo nella sua interezza per comprenderne l’intima struttura –, in sotterranei intrecci nonostante la loro sorprendente e profonda diversità stilistica e umorale. Come ha detto Antonio Tabucchi, lo scrittore recentemente scomparso, la letteratura è una verità altra, simbolica. Ecco, nel suo romanzo Adela Greceanu ci offre la sua verità simbolica di due mondi contrapposti e insondabili come a volte contrapposte e insondabili possono essere le facce della realtà che ci circonda.
Mauro Barindi
La sposa dalle calze rosse
(Mireasa cu șosete roșii)
II
Quanto ho cercato oggi la scatola delle monetine che trovo per strada… Cambiando casa così spesso, tante cose sembrano essere sparite nel nulla. Per tutto il mattino ho frugato dappertutto e non riuscivo a togliermi dalla testa la voce di quella donna che durante tutta la notte tra il 2006 e il 2007 non ha fatto altro che chiacchierare. Diabete da gravidanza, quattro vaccini finora, il cane ha solo quattro mesi, Joe Cocker a Woodstock, capelli ricci, pettinatura gonfia, un po’ simile alla mia, al settimo mese sembravo un mostriciattolo, vi devo mostrare le foto, com’è buono questo riso ai frutti di mare, l’indivia con cosa l’hai combinata, sporcaccione!, perché l’hai fatta in casa?, vorrei che mia figlia studiasse il francese…
Cosa avrò io con la gente? La gente ha i capelli ricci, gli occhi verdi, parla continuamente e non si stanca mai. Mi comprerò una gonna bordò, in realtà è metà-gonna-metà-pantaloni. E uno scialle di velluto, con una grossa spilla turchese, e non nevicherà neppure oggi. C’è il sole. Stavo per mettermi a urlare quando in cucina ho visto l’immortale grigio. Avrei giurato che fosse un topo. Non ci ho fatto neanche caso quanto fosse identico a uno vero quando l’ho comprato a Natale per Păpuşescu al negozio di cibo per gatti. Sono immortali certi topi giocattolo che Păpuşescu uccide sempre e loro comunque non muoiono. Keith Jarret in concerto a Colonia. Quando finisce, ricomincia di nuovo. Il suo pianoforte ci entra non so quante volte nella mia scatola musicale. Solo la scatola con le monetine non si trova più da nessuna parte.
Non so più da quanto tempo dura questo mattino. È fatto di tanti giorni uniti insieme – là dove ci dovrebbe essere stata la notte –, così come un fumatore incallito si accende la sigaretta con un’altra sigaretta. Solo poche cose insignificanti, come andare a fare la spesa o al lavoro, hanno interrotto questo giorno che non terminava mai. Così come il mio amore per Paul è stato interrotto da alcuni innamoramenti. L’ultimo però sembra che gli sia capitato a fagiolo. Paul, con la sua andatura da attore americano, ora non mi dice più niente. Ciononostante, poco fa, mentre stringevo fra le mani la tazza con il caffè caldo e guardavo Păpuşescu mentre dormiva a pancia in su e con le zampe posteriori infilate tra le sbarre del termosifone, non so perché mi sia venuto da chiedermi che cosa Paul volesse da me. E perché mi abbia cercata in tutti questi anni, una volta ogni due, tre mesi o ancor più di rado. Io so che cosa volevo da lui. Non che mi amasse, così come mi sarei affrettata a rispondere sei anni fa, quando ci siamo conosciuti. Bensì che non poteva fare a meno di me e che me lo dimostrasse costantemente. Da quando gli ho detto che mi sposerò, non mi ha più chiamata. Ma non è escluso che mi cercherà a un certo punto come se fosse stato solo ieri che abbiamo parlato per telefono. Şerban, con quella sua faccia da principe decaduto (magari si ricorda ancora di me), Adam, un polacco distinto di sessantacinque anni, con il quale ho trascorso due giorni e per il quale ho smaniato come una scema tutto un anno dato che non mi ha risposto all’unica lettera che gli ho spedito, e, infine, Mihai: questi sono stati coloro che hanno interrotto in questi anni il mio amore per Paul. Ci sarebbe ancora qualcuno: Alexandru. Ma mi è stato spiegato che lui non l’ho amato, ma che, dato il mio smisurato orgoglio, avrei voluto, dicesi, conquistarlo come si conquista una fortezza mai inespugnata prima da nessuno. Probabilmente era proprio questo quello che volevo. Al liceo avevo una professoressa di chimica che ho soprannominato: Dicesi: «Il sodio più il cloro formano, dicesi, il cloruro di sodio». Con Alexandru non ci sono riuscita. Anche se, per il suo modo di essere, è mezzo fuori da questo mondo. Più o meno come me. Ora che tra di noi non c’è più niente, posso dirgli che mi manca. Ed è vero. Glielo avessi detto prima, sarebbe stato come togliere il coperchio da una pentola a pressione, col rischio di non riuscire più a rimetterlo al suo posto. Ora è rimasta solo quella verità del Mi manchi. Semplicemente e terribilmente confortante.
Ma perché sto sempre a contare i miei innamorati? Come se fossero le pecore che uno conta per addormentarsi… È come se ogni volta non mi quadrassero mai i conti. Da alcuni mesi mi addormento sempre più tardi. Ora, per esempio, sono le due. (…)
Ascolto della musica con le cuffie. Non per un’attenzione nei confronti dei vicini, bensì per ascoltarla dentro, solo io. Perché non si perda niente nella stanza. Vado a caccia di suoni collaterali. Quelli che appaiono nell’impatto fra le dita e le corde o i tasti prima della nota musicale. Sto così da due ore, con le cuffie sugli orecchi, sulla sedia a dondolo. Quando mi dondolo in avanti, vedo un pezzo del cavo bianco che esce da sotto il tappeto. Quando mi dondolo indietro, il portatile riesce a coprirlo. Fermo la musica, mi tolgo le cuffie, mi alzo dalla sedia a dondolo e prendo un libro con l‘intenzione di coprire con esso quel cordone bianco. Ne rimane comunque scoperto un pezzo. Apro il libro e lo sistemo così, tutto aperto, sopra il budello bianco. Finito. Suona il telefono. Mi fanno gli auguri perché è il primo marzo, il primo giorno di primavera. Rimango per altre due ore con le cuffie sugli orecchi. Avrei dovuto passare l’aspirapolvere. Fermo la musica, mi tolgo le cuffie, vado in bagno, prendo uno straccio e strofino via la polvere dallo schermo del televisore. Ne rimane comunque ancora un po’. Negli angoli. Chiudo gli occhi e soffio. Sembra che la polvere sia come appiccicata. Suona il telefono. Mi chiedono perché non rispondo né al fisso, né al cellulare. Mi rimetto le cuffie e, quando mi viene la nausea, è già buio. Fermo la musica, mi tolgo le cuffie e vado in cucina. Lecco con la punta della lingua da una bustina di carta dello zucchero impregnato di calcio omeopatico. Suona il telefono. Mi si dice che è inammissibile che alla mia età non mi interessi a niente, che dovrei accendere la tv, andare almeno a teatro o ai concerti, perché altri approfitterebbero al massimo di questa città. O che dovrei ascoltare almeno della musica.
Ieri sera i vicini del piano di sopra hanno messo della musica. Anch’io ho fatto partire della musica nel portatile. Non è servito a niente alzare il volume al massimo. Sono andata in cucina, ho preso un tagliere di legno e l’ho scagliato due volte contro il soffitto del salotto. Alle 20.15 ha suonato il telefono. Alle 20.30 è cominciato L’amore come nei film. Alle 21.30 è finito il programma. Alle 22.15 è finita la telefonata. Mi vergognavo ad ammettere che stavo seguendo una telenovela, proponendo quindi di parlare più tardi. Sono andata a letto solo alle 3.30 della notte, perché alle 2.30 è stata replicata la puntata di ieri sera. A ogni modo non riesco a prendere sonno. E ho scoperto che, a quell’ora, le serie televisive non vengono interrotte dalla pubblicità. (…)
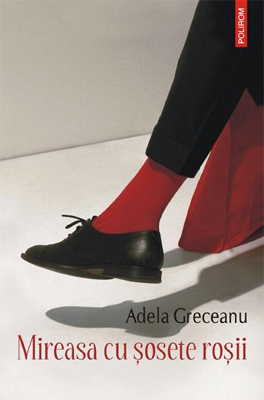
A cura e traduzione di Mauro Barindi
(n. 7-8, luglio-agosto 2022, anno XII)
|
|