









|
|
Stefano Jossa: «Eliade è nella mia formazione di critico letterario e storico della cultura»
 Continua la nostra inchiesta, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, nel campo della critica letteraria, con diversi argomenti di attualità e un'ampia indagine sulla ricezione della letteratura romena in Italia, un tema di particolare interesse per noi. Continua la nostra inchiesta, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, nel campo della critica letteraria, con diversi argomenti di attualità e un'ampia indagine sulla ricezione della letteratura romena in Italia, un tema di particolare interesse per noi.
Nell’ambito dei nostri Incontri critici, ospitiamo qui il critico Stefano Jossa, Reader in Italian presso la Royal Holloway (University of London). Ha tenuto corsi su Dante, Petrarca, Boccaccio, il Rinascimento italiano, Ariosto, il Risorgimento, la costruzione dell'identità nazionale in Italia, il teatro italiano contemporaneo. Ha partecipato a numerose opere collettive, sia tra le più tradizionali, come il Dizionario biografico degli italiani, sia tra le più innovative, come il Dizionario dei temi letterari (Utet 2007) e l’Atlante della letteratura italiana (Einaudi 2010). È stato membro della giuria di qualità del Premio Mondello e della giuria estesa del Premio Strega. Dal 2007 collabora come critico d'arte alle pagine di «Alias», supplemento culturale de «Il manifesto».
La contemporaneità non contempla esclusivamente le opposizioni oralità/scrittura e poesia/prosa, ma anche la possibilità di scelta tra e-book/online e cartaceo, tra letteratura cartacea e digitale. Quanto lo sguardo della critica è condizionato dal profumo della carta stampata o, viceversa, dalla comodità del digitale?
Non credo che esistano già studi psicologici e neurologici sulla diversa relazione che la mente istituisce col libro e con l’ebook. Certamente si legge differentemente: sull’ebook, per esempio, non si possono tenere aperte due pagine simultaneamente, mentre sul libro stampato non si può fare una ricerca per parola o frase. Secondo me, nulla cambia dal punto di vista critico, perché il giudizio dipende dalla poetica e dal gusto anziché dal formato e dal supporto. Io sono contrario tanto alla paura della tecnologia quanto alla resa alla tecnologia, perché penso che la parola abbia un suo valore autonomo che prescinde dalla forma con cui viene proposta. Eppure, come insegna Marshall McLuhan, «the medium is the massage» (anziché «the message»), con un bel gioco di parole che rivela quanto lo strumento comunicativo abbia una funzione non solo di trasmissione del contenuto, ma anche di seduzione del destinatario perché questo contenuto arrivi. Possiamo auspicare, allora, libri ibridi, che usino ancora la carta per alcune funzioni (a scelta dell’autore e dell’editore) e rimandino al digitale per altre (sempre a scelta di autore ed editore). Il mio prossimo libro sarà proprio così, metà cartaceo (testo e note) e metà digitale (illustrazioni e apparati), perché lo si legga con un cellulare in mano, passando continuamente dall’uno all’altro: stay tuned!
Idea ormai radicata è che la Letteratura nello specifico debba uscire dai cenacoli accademici per essere vissuti nella pratica quotidiana, così da produrre un’eredità concreta e tradursi in un’azione culturale efficace. Quanto la sua opera editoriale integra la tradizione con ricerche espressive innovative?
Credo che la risposta precedente includa anche la risposta a questa domanda, ma posso aggiungere che i cenacoli accademici sono luoghi di analisi, critica ed elaborazione del sapere che dovrebbero per definizione essere aperti e pubblici, visto che l’accademia è rivolta alla formazione oltre che (e insieme) alla ricerca. La manualistica scolastica già prevede, per obbligo di legge, la presenza di sezioni online, che integrano il manuale o l’antologia. L’incontro tra diverse forme espressive, tra arti figurative, esperienze poetiche, spettacoli, musica, documenti e fotografie, dovrebbe essere ormai un’ovvietà quando si fa storia della cultura e del sapere (a partire dalla lezione indimenticabile del Materiale e l’immaginario, il grande libro di scuola che innovò allo stesso tempo contenuti e didattica negli anni Settanta del Novecento, diretto da Remo Ceserani e Lidia De Federicis). Il legame tra passato e presente è altrettanto necessario, alla condizione di evitare il procedimento attualizzate, sulla base del pregiudizio universalistico di matrice romantica: guardando all’indietro, non si tratta di scoprire il nostro tempo nel loro, ma di capire cosa del loro tempo è rimasto nel nostro, e come, e perché.
Ana Blandiana, Herta Müller, Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, sono autori che, trascendendo il tempo e lo spazio, hanno narrato la burrascosa storia della Romania. Ebbene, le sono noti e ci sono scrittori romeni che hanno attirato la sua attenzione?
Eliade è nella mia formazione di classicista, storico, antropologo, critico letterario e storico della cultura (senza con ciò intendere che io sia tutte queste cose, ma solo che mi piace esplorare e sperimentare): l’ambizione a rintracciare i precedenti, fino all’archetipo junghiano, ritrovando da dove siamo partiti, archeologicamente, e come siamo arrivati, genealogicamente, la riconduco alla sua lezione (ibridata e contaminata con Nietzsche, Foucault e Agamben, ma certo tanti altri ancora di cui neppure sono consapevole, fino a tradirlo, eppur sempre in dialogo). Cioran mi ha dato strumenti di analisi del presente e dei testi da cui non posso più prescindere: la vita come dolorosa imposizione, eppur necessaria per provare quello stesso dolore sentito come imposizione, costringe a guardare tutto di sbieco, pensando che al centro c’è solo ciò che è più visibile perché conta meno. Mi sorprende l’assenza, in questo canone romeno, di Tzara e Ionesco: rivolgersi a loro per immaginare nuove forme di libro, sfidare il linguaggio e riflettere sul potere è secondo me ancora indispensabile.
La letteratura romena è costantemente tradotta in lingua italiana e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2022. In che misura pensa sia conosciuta in Italia?
Credo che l’orizzonte nazionale vada superato a favore di una prospettiva globale, come si fa ora con la World Literature,che a differenza della letteratura comparata non ricorre a temi da confrontare, storicizzandoli ma assolutizzandoli, bensì punta a capire la circolazione, valorizzando la dialettica tra originale e traduzione. Resta tuttavia fondamentale la coscienza della lingua, che porta con sé un’appartenenza culturale (oltre che percorsi di vita e formazione) che dalla nazione non possono prescindere. Proprio Eliade e Cioran, tra gli altri, hanno mostrato quanto sia produttivo lo scontro tra il confine e lo slancio, senza il quale si perderebbe lo stimolo della tensione come strumento esistenziale e artistico. Probabilmente l’Europa potrà essere un’occasione perché le culture si confrontino e mescolino di più e con più consapevolezza. Per ora, purtroppo, della letteratura rumena io incontro solo quello che emerge nel mainstream italiano, che è selezionato per lo più a fini commerciali ed è comunque sempre troppo poco. Se romeno dovesse diventare europeo, e poi mondiale, ed essere quanto più possibile in dialogo con polacco, ungherese, italiano, francese, tedesco, ecc., ma anche, se possibile, indiano, arabo, cinese, brasiliano, ecc., la letteratura avrebbe fatto un grande passo.
Nel suo libro La più bella del mondo. Perché amare la lingua italiana (Einaudi, 2018), lei ci narra sei storie relative a una lingua inventata, a una rima, a un’arte che racconta incessantemente pure qualcos’altro rispetto a ciò che sta proferendo, a un simposio con Dante, a un poeta a Sanremo, a un indovinello irresolubile. Qual è il fine?
Il fine primario è rivendicare l’idea che non si può studiare la lingua senza la letteratura, né la letteratura senza la lingua. Mi colpisce il fatto che da vari anni nel discorso pubblico (sui giornali, in libreria, in edicola, nei media) i testi di linguistica abbiano preso il posto della critica letteraria, come se la leadership intellettuale avesse visto un cambio di mano nella staffetta della storia italiana. A me sembra che una tale impostazione porti a un impoverimento del discorso pubblico, troppo spesso fondato sulle istruzioni per l’uso e le curiosità divertenti. Rivendicare la bellezza della lingua significa invece capire che la bellezza si trova proprio dove la lingua si veste o si trucca, come facciamo noi umani quando dobbiamo incontrare una persona speciale o affrontare una sfida particolare: dove, cioè, la lingua “trova forma”, che è il massimo del suo splendore. Nella poesia, quindi, ma in generale nella letteratura tutta e dovunque il discorso richieda un livello alto di attenzione e di controllo. Senza diventare gergo, però, linguaggio chiuso per pochi iniziati, perché la lingua è prima di tutto comunicazione.
Lei scrive: «La lingua è, nella sua dimensione affettiva, sempre al superlativo». Ritiene che la lingua tanga il luogo più recondito della nostra anima; che essa colloqui con il nostro inconscio?
Sì. Siamo esseri linguistici, come hanno dimostrato tanto la filosofia quanto le neuroscienze. Nel senso che la forma più completa e complessa che abbiamo a disposizione per esprimere il nostro universo interiore, emozioni e sensazioni, è la lingua: possiamo certamente usare espressioni facciali, gesti e movimenti per esprimerci, ma senza la parola non raggiungiamo quel livello di finezza che esigiamo da noi stessi. Quando vogliamo raccontare un sogno, lo traduciamo in parole o disegno? Se vogliamo esprimere rabbia o amore, ci affidiamo alla parola o al gesto? Magari ci sono cose che la lingua non riesce a esprimere, ma la comunicazione umana a livello intellettuale avviene tutta per via di linguaggio. Perciò amiamo la nostra lingua, perché è nostra, cioè è quella in cui traduciamo tutto ciò che sentiamo e pensiamo. Lei ha detto (scritto) tanga, per esempio: si è sentita ‘speciale’ (sorprendendomi), perché usava il rarissimo congiuntivo presente del verbo tangere, o ‘spiritosa’ (prendendomi in giro), perché ha introdotto un riferimento al tanga, che è una mutandina, in un discorso apparentemente molto serio? La risposta la sa solo lei, forse neppure lei, ma certo è che mi ha spiazzato, esprimendo la sua interiorità e provocando una reazione in me. La lingua è sempre materia da lettino, come sa la psicanalisi, che ha fondato tutta la sua prassi sull’analisi del linguaggio. «La lingua è la spia dello spirito», diceva Pier Paolo Pasolini. Il sogno ha, sarebbe meglio dire è, una lingua, secondo lo psichiatra Emil Kraepelin, che parlava di Traumsprache (la lingua del sogno), espressione ripresa da Freud.
Antonio Gramsci scriveva che «ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale...» Reputa che tale questione sia a tutt’oggi aperta?
Quando i nostri politici esibiscono la loro lingua sciatta o semplificata, l’operazione è chiara: dire a chi ha pochi strumenti linguistici che i politici gli sono vicini, ingannandolo e manipolandolo per ottenere il consenso. Si sta affermando una nuova lingua mediatica che si fonda sull’omologazione verso il basso, mentre in passato uno dei grandi obiettivi dell’educazione linguistica era la possibilità di esprimere la differenza. La lingua definisce, dunque, i modelli del potere, la sua ideologia, i rapporti fra le classi e i gruppi: la questione della lingua è sempre aperta e sempre lo sarà, perché la lingua è intimamente connessa al potere. Quando Calvino chiedeva che nei rapporti di polizia si scrivesse«Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa»anziché«Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico», non stava forse chiedendo una lingua più comunista (cioè più popolare in quanto accessibile a tutti) e meno democristiana (cioè criptica e distante in quanto ingannevole esercizio di potere)? Quando Pasolini, in Gennariello, sottotitolato Trattatello pedagogico, si scandalizzava perché invece di andarsene i politici continuavano a parlare, non insisteva sul fatto che «La loro lingua è la lingua della menzogna»? La politica è ancora e sempre una questione linguistica.
Tullio De Mauro scriveva che «La lingua è una cassetta degli attrezzi». Può commentare siffatta osservazione?
De Mauro si riferiva agli strumenti che la lingua offre per affrontare le varie situazioni, essendo l’«attrezzo», proprio secondo il Dizionario dell’italiano dello stesso De Mauro, un «utensile necessario per una determinata attività o mestiere». È noto a tutti gli studenti italiani il caso del povero Renzo che non capisce la lingua dell’Azzeccagarbugli e non ottiene il diritto alla difesa. Più ampio è il nostro spettro linguistico, più è probabile che non veniamo tagliati fuori dalle situazioni che richiedono linguaggi specifici. Il caso più clamoroso è quando ci troviamo a cena con persone che parlano un’altra lingua: entrare nella conversazione è difficilissimo se non conosciamo non solo la lingua, ma il relativo contenuto, di esperienze conoscitive, storiche ed emotive, che la lingua porta con sé. La lingua è strumento di conoscenza del mondo e di presenza nel mondo.
Lei asserisce che la lingua italiana sia «la più bella del mondo». Quali sono le argomentazioni chiarificatrici e gli elementi storici e letterari a sostegno di siffatta tesi?
Nessuno. La lingua più bella del mondo, come dico a più riprese nel libro, semplicemente non esiste. Oggettivamente non esiste. Nessuna legge scientifica o grammaticale può dimostrare la superiorità di una lingua o un’altra sul piano estetico. Eppure, soggettivamente, ognuno ha la sua preferenza, che di solito va alla lingua che parla o per lo meno che vorrebbe parlare. Si tratta cioè di una scelta, che è in fondo sempre associata all’idea di bellezza, perché, non se ne abbiano a male le top models, il concetto di bellezza assoluta non esiste, la bellezza è storicamente definita e determinata, ciò che bello è ciò che piace. Senza dover ricorrere a tutto il repertorio di proverbi sul fatto che de gustibus non est disputandum, a me sembrava importante uscire dallo stereotipo del proclama, un po’ patriottardo e molto provinciale, che l’italiano è la lingua più bella del mondo, per cominciare a sentire individualmente, ciascuno per sé, questa bellezza, che vuol dire, infine, come ci poniamo al mondo, le parole che scegliamo per rappresentarci, la nostra manifestazione al di fuori, verso l’esterno, nel contatto con l’altro. Se si pensa che la frase più citata sulla bellezza della lingua italiana, che l’italiano sarebbe «la lingua degli angeli», viene pronunciata da un impostore, Felix Krull (nel romanzo di Thomas Mann a lui intitolato, Le confessioni di Felix Krull), si capisce che con la lingua si può anche giocare, perché lì risiedono verità e menzogna, passione e divertimento, serietà e fantasia. Ecco, il bello della lingua è la sua varietà e molteplicità. Per ciascuno nella lingua che sceglie. Per altri saranno l’inglese, l’hindu o il mandarino. Per chi sceglie l’italiano sarà, inequivocabilmente, l’italiano. Per me, quindi, è l’italiano, proprio e soprattutto perché è la lingua che parlo io.
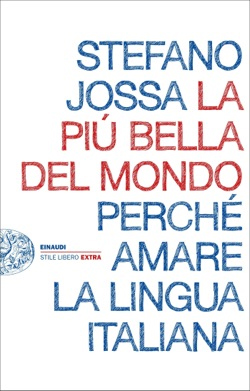
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 4, aprile 2022, anno XII)
|
|

