









|
|
Con Selena Pastorino sulla «Filosofia della maternità»
 Che cos’è una madre? Che cosa significa essere madri? Che cos’è un corpo di mamma? Nel grande dibattito del femminismo filosofico, da un po’ di tempo, la questione della maternità sta ritornando come questione centrale da pensare in tutta la sua complessità, nella consapevolezza che il pensiero filosofico ha sempre tenuto a distanza, e guardato con sospetto, il corpo della madre. Non a caso la filosofia ha privilegiato il pensiero della morte rispetto a quello della vita e della sua origine: il ventre materno, l’utero della donna. Che cos’è una madre? Che cosa significa essere madri? Che cos’è un corpo di mamma? Nel grande dibattito del femminismo filosofico, da un po’ di tempo, la questione della maternità sta ritornando come questione centrale da pensare in tutta la sua complessità, nella consapevolezza che il pensiero filosofico ha sempre tenuto a distanza, e guardato con sospetto, il corpo della madre. Non a caso la filosofia ha privilegiato il pensiero della morte rispetto a quello della vita e della sua origine: il ventre materno, l’utero della donna.
Nel suo saggio Filosofia della maternità (Il Nuovo Melangolo, 2021), Selena Pastorino, filosofa e mamma, muove dall’esperienza corporea della gravidanza e della maternità così come vissuta dall’autrice nel duplice senso di generazione e crescita di una figlia, per provare a rispondere all’enigma della maternità.
Selena Pastorino è Dottoressa di ricerca in Filosofia. Si occupa del pensiero nietzschiano, con particolare riferimento alla questione dell’interpretazione e del prospettivismo, cui ha dedicato una monografia edita da ETS (Prospettive dell’interpretazione. Nietzsche, l’ermeneutica e la scrittura in «Al di là del bene e del male»). Per i tipi del Melangolo ha curato Per la dottrina dello stile e Da quali stelle siamo caduti? e per Mimesis ha pubblicato Black Mirror. Narrazioni filosofiche, con Fausto Lammoglia. Dal 2015 è docente liceale di Filosofia e Storia.
La maternità è un’esperienza corporea: ritiene che ciò le conferisca lo statuto di una condizione che si esaurisce nella costituzione corporea?
Sicuramente il corpo è stato per me l’ambito in cui ho potuto esperire la maternità con più forza, la dimensione in cui credo che si concretizzi meglio il senso di questa relazione. Penso che sarebbe tuttavia rischioso accettare, senza resto, una sorta di riduzione di questa esperienza alla sola sfera corporea. In primo luogo perché renderebbe meno evidente l’inclusione di forme di maternità non tradizionali, ma non per questo meno degne di questo nome: come ho provato a chiarire, madre si dice e si è sempre detto in molti modi, nessuno dei quali ha una priorità sugli altri. In secondo luogo, come ogni pratica umana anche l’essere madre non si riduce alla mera fisicità, bensì include un confronto costante con quello che si potrebbe chiamare il concetto culturale di maternità, vale a dire l’ideale materno che si considera ‘normale’ in un preciso contesto storico-sociale e che determina aspettative spesso molto intrusive nel rapporto di ogni madre al figlio. Nonostante queste due derive, cancellare la realtà incarnata della maternità, la viscerale iscrizione di questa relazione nel corpo di ogni madre, anche se non è stata gestante, è altrettanto pericoloso, perché ne dimentica la concretezza e l’irreversibilità.
Il pensiero filosofico ha costantemente tentato di porre distanti l’attività di pensiero e la corporeità dell’esperienza. In questo saggio pare cogliersi una posizione di segno differente. Perché, a suo avviso, l’approccio della Filosofia continua a essere meramente teorico?
La filosofia occidentale muove dallo stesso paradigma culturale che contribuisce ad alimentare, quello per cui da una parte si trova la realtà materiale, ivi compresa quella corporea, con il suo divenire complesso e, in quanto tale, incomprensibile, e dall’altra l’immaterialità di istanze meta-fisiche, tra cui, nell’umano, il pensiero. Immaginare e praticare l’uscita da questa contrapposizione di sapore manicheo implica il coraggio di osare una radicale decostruzione, per usare non a caso un termine della filosofia «derridiana», e di tentare una non meno intrepida sperimentazione. Gli esempi di chi ha raccolto questa sfida, nel passato e nella contemporaneità, sono più numerosi di quanto potrebbe sembrare, ma è innegabile che una certa matrice continui a restare dominante, con tutte le implicazioni che comporta anche sul piano della convivenza sociale, dominata da una paradossale smaterializzazione venerante della corporeità. C’è da auspicarsi con Nietzsche che un nuovo modo di filosofare sia davvero all’orizzonte.
Questo saggio muove dalla personale esperienza corporea della maternità nel duplice senso di generazione e crescita di una figlia. Esiste un medium tra mente e corpo?
Con una boutade potrei dire che siamo noi a esistere come medium tra mente e corpo. Questi due termini mi sembra, infatti, si configurino come poli di una tensione senza soluzione di continuità che ci realizza, che ci rende cioè reali e vivi. In questo senso, la prospettiva autobiografica è il punto di partenza della riflessione filosofica nel mio lavoro, affinché si possa fornire un quadro alternativo a quella contrapposizione culturale di cui si è detto: l’esperienza incarnata sostituisce quella dicotomia impossibile con la concretezza del vissuto, da cui il pensiero origina ma a cui anche deve sempre essere ricondotto, per non perdere di vista quel reale con cui dovrebbe confrontarsi.
Superando Cartesio, si potrebbe affermare che il corpo pensi. Qual è stato l’apporto delle neuroscienze ai suoi studi?
Il pensiero del corpo è esattamente la chiave di lettura di quel genitivo che compare nel titolo: «Filosofia della maternità» non significa una trattazione astratta e generalizzata sull’essere madre, ma lo sviluppo di quella riflessione che da questa esperienza, che si è detta innegabilmente corporea, nasce. Per questo motivo ho integrato il mio vissuto a una ricerca approfondita che si è avvalsa del confronto di molte discipline, dalla psicanalisi alla medicina, dalla bioetica alle neuroscienze, dalla narrativa alla storia, come un tema così complesso quale la maternità non poteva che implicare. In particolare, sul versante scientifico ho trovato molto utile il contributo di lavori che hanno sondato lo sviluppo congiunto di corpo e mente, nei molteplici sensi di questo termine, nelle diverse epoche gestazionali (per esempio lo splendido testo di Ammaniti e Ferrari, Il corpo non dimentica, edito da Raffaello Cortina nel 2020), nonché gli effetti dell’esperienza materna sul corpo della madre, sia come gestante sia come genitore.
Il tema della «maternità surrogata» è fortemente divisivo. Reputa che possa essere considerata quale un paradigma decisivo per declinare una nuova grammatica filosofica?
Per trattare una questione così delicata penso che sia anzitutto importante scegliere le parole con cui si vuole definirla: ciò che è comunemente noto come «maternità surrogata» sarebbe più corretto chiamarlo «gestazione per altri», espressione che predilige una certa neutralità terminologica per lasciare spazio a un confronto meno determinato. Si tratta sicuramente di un’esperienza che fa resistenza alla riflessione perché prevede un’esplicita messa in gioco di tutti gli assunti culturali da cui sempre muoviamo, ma che troppo spesso tendiamo a cristallizzare in un’ideologia irriflessa e immutabile. La realtà, come si diceva, è ben più complessa e prenderne atto sarebbe importante proprio per una disciplina come la filosofia che ha il compito di riflettere sul reale per fornire una forma di orientamento. Personalmente, per non eludere una possibile domanda in sottotesto, ho maturato nei confronti della «gestazione per altri» come di altre modalità non tradizionali di genitorialità la profonda consapevolezza della mia ignoranza. La posizione di privilegio di cui ha goduto la mia esperienza di maternità e di cui in generale per la maggior parte dei suoi aspetti gode la mia esistenza esige anzitutto un confronto con chi ha un diverso vissuto, con chi può esprimersi su questi temi a partire dalla concretezza incarnata della pratica. La teoria, necessaria per la riflessione, può essere accolta solo dopo un confronto con la realtà. Anche in questo rovesciamento di prospettiva penso che i temi ‘divisivi’ siano un’ottima occasione per la filosofia di rinnovarsi e proporre così ancora il proprio lavoro come un prezioso contributo all’esistenza.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?
Com’è stato messo in luce dalla riflessione femminista sin dal Novecento, credo che vi sia una potenza nella narrazione di esperienze che ha importanti effetti sul vissuto femminile, permettendo di riappropriarsene e così di decostruire la normatività di genere imperante tuttora nella nostra società. Anche in questo ambito, tuttavia, non basta una firma femminile per far agire questa battaglia emancipatoria: occorre che questa sia stata preliminarmente abbracciata anche dalle scriventi. Aggiungo, per la sua stessa natura di lotta, anche laddove la lotta stessa non è oggetto esplicito della scrittura, non è solo la voce di donne a poter risignificare l’esperienza delle lettrici, ma, come proprio del femminismo intersezionale, di ogni vissuto di autodeterminazione a partire da una marginalizzazione sistemica. Non è mai identico il percorso, ma è condiviso lo sforzo per emanciparsi insieme.
Le scrittrici sono e sono state sensibili a diverse ideologie, visioni del mondo, sensibilità politiche e filosofiche; personalità diverse tra loro e spesso assolutamente inconciliabili. Riesce a scorgere un fil rouge che annoda le plurime e molteplici anime della letteratura declinata al femminile?
Fatico a orientarmi con competenza in un ambito, quale quello della letteratura, che frequento da lettrice ma che non conosco da esperta. Presumo che si possano impiegare le lenti femministe per scorgere all’interno delle diverse narrazioni la capacità di posizionarsi in modo più o meno consapevole e più o meno esplicito in questo spettro di lotta. Laddove la condivisione del vissuto è autentica, ancorché finzionale, credo si possa scorgere una messa in opera di quel meccanismo che provavo a delineare sopra e che consiste, sul lato della scrittura, nella restituzione di una voce a chi è stato tacitato e a cosa della sua esperienza non ha potuto trovare spazio di espressione.
Quale significato assume, oggi, il termine «femminismo»?
Esistono molteplici anime e approcci del femminismo, ma mi pare che la sua maggiore potenza si ritrovi nell’adesione a una prospettiva intersezionale, che accompagna cioè la battaglia per l’autodeterminazione femminile a quella per l’autodeterminazione di ogni soggetto, non sovrascrivendosi a esigenze specifiche, ma supportando con la forza della propria lotta quella di ciascuna persona contro le strutture alienanti, oppressive, marginalizzante, discriminatorie e violente che ne impediscono l’esistenza, dal senso più basilare a quello più pieno del termine.
Si può diventare l’eroina della propria storia oppure il miglior sidekick del mondo per un’eroina di proprio gusto. Si può diventare colei che fa cambiare l’organigramma di una redazione oppure colei che diffonde la notizia che l’organigramma è mutato. Si può diventare colei che contribuisce a redigere le leggi che ci conducono a una società più equa e libera dalla paura del diverso oppure colei che quelle leggi le vota. Come si fa la rivoluzione femminista?
Imparando a fare la rivoluzione dentro sé stesse, come primo passo. L’autocritica e la consapevolezza sono strumenti imprescindibili per cominciare a depotenziare il sistema di oppressione a partire dalla dimensione interiorizzata che abita, inevitabilmente, ciascuna di noi. È un lavoro inesauribile, che si nutre del confronto plurale con altre persone e altre prospettive, e che deve però poi anche concretizzarsi in buone pratiche di tutela dell’emancipazione di chi ci circonda. Non esiste, come ben dice, un unico modo di fare la rivoluzione, ma ogni contributo è necessario per continuare, incessantemente, a realizzarla. A farne cioè una migliore realtà da abitare, per tutte.
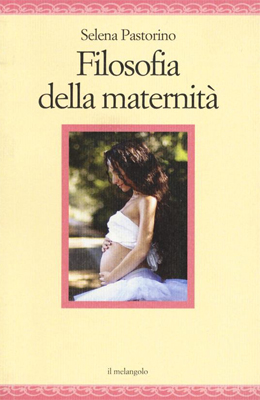
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 6, giugno 2022, anno XII)
|
|

