









|
|
Con Luigi Capitano su Leopardi, Cioran e i significati del nichilismo
 Nell'ampio spazio che la nostra sezione Italianistica Orizzonti dedica questo mese a Leopardi, pubblichiamo una corposa intervista a Luigi Capitano, insegnante, pensatore, saggista, leopardista. Si è occupato spesso dei rapporti tra filosofia e letteratura, scrivendo su Dante, Leopardi, Kafka, Pirandello, Dostoevskij, Camus. Ha collaborato a diverse opere collettive, fra cui Filosofie nel tempo. Percorsi monografici (Spazio Tre, 2007). Attualmente insegna filosofia e storia in provincia di Agrigento. Nell'ampio spazio che la nostra sezione Italianistica Orizzonti dedica questo mese a Leopardi, pubblichiamo una corposa intervista a Luigi Capitano, insegnante, pensatore, saggista, leopardista. Si è occupato spesso dei rapporti tra filosofia e letteratura, scrivendo su Dante, Leopardi, Kafka, Pirandello, Dostoevskij, Camus. Ha collaborato a diverse opere collettive, fra cui Filosofie nel tempo. Percorsi monografici (Spazio Tre, 2007). Attualmente insegna filosofia e storia in provincia di Agrigento.
Luigi Capitano è autore della monografia Leopardi. L’alba del nichilismo (Orthotes, 2016, prefazione di A. Folin, pagg. 982), che inaugura una trilogia sul palinsesto del pensiero occidentale comprendente la sapienza greca e Platone. È di prossima pubblicazione in «Appunti leopardiani» il suo lavoro intitolato Le consolazioni del genio. Su Leopardi e Severino.
«Da dove proviene il più inquietante dei nostri ospiti?», domandava Nietzsche. Quali sono le risposte suggerite da Giacomo Leopardi?
«Il più inquietante dei nostri ospiti» cui faceva allusione Nietzsche era il «nichilismo europeo», ovvero la crisi dei valori della metafisica, a partire dal concetto stesso di verità. Se infatti la religione, la metafisica e la scienza pretendevano, una dopo l’altra, di essere l’unica versione vera del mondo, quale verità assoluta ed esclusiva si sarebbe più potuta affermare? Come scriveva Nietzsche in un frammento postumo del 1886, «l’inapplicabilità di un’interpretazione del mondo a cui è stata dedicata un’enorme quantità di energia risveglia il sospetto che tutte le interpretazioni del mondo siano false». Difficile sfuggire alla conclusione nichilistica: «una interpretazione è tramontata; ma poiché vigeva come l’interpretazione, sembra che l’esistenza non abbia più nessun senso». Nel Novecento, Weber tradurrà tale discorso ricorrendo alle nozioni di «politeismo dei valori» e di «disincanto del mondo».
Il nichilismo proviene dunque da lontano e Nietzsche ne indica le origini e le tracce genealogiche, specie durante la progettata Volontà di potenza. In breve, si può dire che a partire dall’età moderna (simbolicamente da Copernico in poi), è tutto un continuo scivolare sul piano inclinato della perdita di centralità umana nel cosmo. Non dimentichiamo che il Copernico di Leopardi precede le annotazioni nietzschiane sulle «conseguenze nichilistiche delle scienze naturali». Fin dal periodo di Basilea, Nietzsche aveva dapprima orecchiato le prose leopardiane possedute da un suo compagno di stanza e in seguito (nel 1878) aveva ricevuto in omaggio l’intera opera in una prestigiosa versione tedesca. Nel frattempo (nella Seconda considerazione inattuale), aveva definito la posizione di Leopardi come astorica (l’esempio dell’animale invidiato dal ‘pastore errante’ perché non ha nozione di tempo e non si annoia) o anche sovrastorica (al pari di uno Schopenhauer), per il suo disprezzo delle vicende umane che si ripetono sempre uguali a sé stesse.
Nel mio libro spiego anche il rapporto ambivalente che Nietzsche ebbe col poeta-pensatore italiano. In verità, è stato proprio Leopardi, ben prima di Nietzsche, ad aver colto e analizzato con estrema lucidità tutte le tracce e gli indizi del fenomeno del nichilismo nel suo sviluppo, dall’evo antico fino al suo tempo. Una parabola mitizzante di tale fenomeno si trova illustrata nella Storia del genere umano, in cui i più alti ma ormai dileguanti ideali umani (Giustizia, Virtù, ecc.) cedono il passo all’apparire della Verità e del disincanto. Naturalmente, le quasi mille pagine del mio volume dovrebbero servire a rispondere in modo ben più compiuto ed esaustivo alla sua domanda…
Leopardi si rivela non solo il più decisivo antesignano del nostro tempo, ma anche il primo inatteso genealogista del «nichilismo europeo». Ebbene, dove è possibile reperire i preludi di tale composito fenomeno, che rinviano altresì alla sapienza ‘negativa’ degli antichi?
Un inatteso antesignano, Leopardi, perché appunto la versione ufficiale suppone invece che la genealogia del nichilismo non abbia quasi precedenti rispetto a Nietzsche. Eppure Leopardi anticipa il discorso di Nietzsche di circa mezzo secolo, con tratti peculiari. Ad esempio, la «filosofia dolorosa, ma vera» di Salomone e Omero, alla quale Leopardi aderisce rappresenta il protonichilismo ebraico e quello greco che si esprimono, rispettivamente, nella vanitas vanitatum dell’Ecclesiaste e nella formula del vecchio Sileno: «meglio non vivere!». A queste forme antiche di nichilismo (ante litteram) Leopardi ne contrappone altre, più moderne e ben più perniciose, basate sul predominio della ragione, della scienza e della tecnica. Qui il pensatore italiano si rivela non meno critico di Nietzsche, ad esempio verso quel nichilismo platonico-cristiano che rinnega il valore della vita trasferendo interamente il suo significato in un altro mondo.
Dalla ricostruzione della modernità spinta sino alle soglie della contemporaneità affiora l’immagine di un Leopardi smarrito e indocile. Cede forse il passo alla disperazione?
La disperazione di Leopardi, così come il suo pessimismo, sono considerati ormai dei luoghi comuni dalla gran parte dei leopardisti. In Leopardi ci sono indubbiamente anche la disperazione e il pessimismo, ma come aspetti o momenti di un atteggiamento ondivago che include anche la speranza: si potrebbe parlare più sensatamente – con una formula tratta dallo Zibaldone – di «disperata speranza», nonché di pessimismo come sintomo di un nichilismo combattivo, ribelle, indomito. Perfino nella pagina più nera dello Zibaldone in cui si legge che «tutto è male», precisando che non intende scadere nel «pessimismo» simmetricamente opposto all’ottimismo leibniziano, Leopardi aggiunge che non esiste altro bene che «le cose che non son cose», ovvero le chimere, se si intende bene questo passo in connessione con altri…
Lo smarrimento di Leopardi nella civiltà del suo tempo si trova ben illustrato nel primo Ottocento da Sainte-Beuve che definiva il Recanatese l’ultimo degli antichi, spaesato fra i moderni. In effetti, Leopardi, autore che si sentiva senza «età né suolo» e «mai nel [suo] centro», era doppiamente ‘inattuale’: venuto troppo tardi per gli antichi e troppo presto per gli uomini del Novecento, a cui del resto non mancava di lanciare profezie e moniti (vedi la progettata «lettera a un giovane del 20° secolo», ma vedi la stessa Ginestra).
Lei si misura con le massime esegesi del nichilismo leopardiano, da Nietzsche a Severino. Si può scorgere un sentire comune?
Quello di Emanuele Severino è un approccio ‘inaudito’, unico nel suo genere, molto distante sia da quello di Nietzsche che da quello di Heidegger, ma fra tutt’e tre questi pensatori – che rimangono i maggiori interpreti del nichilismo – ci sono pure dei punti in comune, che vale la pena rilevare. Se per Nietzsche «nichilismo» vuol dire la «morte di Dio», ossia lo svanimento dei valori supremi della metafisica, per Heidegger esso equivale all’oblìo del senso dell’essere, per Severino alla folle «fede nel divenire» che finisce con il confondere (in maniera contraddittoria) l’essere con il nulla. Il nichilismo si manifesta, in definitiva, quando dell’essere non è più niente: e ciò vale tanto per Nietzsche quanto per Heidegger, come pure per Severino. «Tutto è nulla» è l’analoga formula leopardiana. Quanto a me, assumo la nozione di nichilismo soprattutto nell’accezione nietzschiana, ma appunto ne ravviso i precedenti soprattutto in Leopardi, senza escludere il ruolo di Jean Paul, Jacobi e di tante altre figure di transizione (Heine, Herzen, Stirner, ecc.), in quel fervido crocevia della filosofia europea rappresentato dall’età pre- e postromantica.
«Per i malati di “dolore universale” la vita e il mondo sono privi di senso perché sono miserandi. Per noi contemporanei la vita e il mondo sono miserandi perché sono privi di senso». Può commentare questa riflessione?
Vorrei richiamare direttamente il passo in cui ne parlo nel mio libro: «Se è vero che l’interrogazione sul senso dell’esistenza nasce sulle spoglie della domanda intorno al significato del dolore, è altrettanto certo che non possiamo confondere la posizione antiquata di Schopenhauer con quella del tutto inedita di Leopardi con la quale viene inaugurato il paradigma contemporaneo del nichilismo: “per i malati di ‘dolore universale’ la vita e il mondo sono privi di senso perché sono miserandi. Per noi contemporanei la vita e il mondo sono miserandi perché sono privi di senso” [così Günther Anders ne L’uomo è antiquato, II]. Nell’orizzonte contemporaneo il nonsenso del mondo non deriva dal dolore e dal pessimismo, ma viceversa. Lo aveva in fondo già intuito Nietzsche nel famoso Frammento di Lenzerheide del 1887: “Il nichilismo appare ora non perché il disgusto per l’esistenza sia maggiore di prima, ma perché si è diventati riluttanti a vedere un ‘senso’ nel male e nell’esistenza stessa”».
In breve, il «nichilismo estremo» contemporaneo riposa sul nonsenso universale, rispetto al quale il pessimismo e il dolore del mondo sono solo dei sintomi, degli epifenomeni. Potremmo anche dire, con il filosofo leopardiano Giuseppe Rensi, che è il pessimismo a poggiare sull’assurdo, e non già viceversa. Un secolo prima di Rensi e di Heidegger, Leopardi aveva previsto il parallelo tracollo della metafisica e del platonismo attraverso lo schema inverso del «contro-argomento ontologico»: le cose sono quel che sono semplicemente perché sono tali e non già perché derivano da una qualche essenza eterna. Ciò equivale a dire che le cose sono senza fondamento, che si fondano nel nulla.
Oggetto di indagine comune di Dostoevskij e Camus pare essere l’uomo al cospetto di interrogativi etici circa il Bene ed il Male. Quali sono, a tal proposito, le assonanze e le divergenze che ha ravvisato?
La maggiore assonanza fra i due autori credo sia ravvisabile nel tema della coscienza, come lei dice bene, nell’interrogazione sul bene e sul male, domanda torturante e abissale. Dostoevskij affronta la questione da cristiano slavo che ha temprato la sua fede «nel crogiolo del dubbio», Camus con la coscienza scettica di quello che possiamo considerare un nostro contemporaneo mediterraneo, che ha ormai attraversato il deserto dell’assurdo e della «rivolta metafisica». Se Camus ricerca una «misura» nella tensione tra virtù e cinismo, Dostoevskij gioca i suoi personaggi e suoi drammi sulla dismisura tra i due abissi che s’intrecciano in ogni animo umano. È comunque interessante notare come entrambi gli scrittori individuino nell’«isolamento» e nella «separazione» la fenomenologia della «peste» che affligge l’umanità. Dostoevskij ha indagato tale fenomeno sotto il profilo della causa, mentre Camus sotto quello degli effetti, almeno nel romanzo La peste. In ogni caso, non si tratta di assonanze casuali, perché sappiamo che Camus ha amato e studiato a fondo Dostoevskij, fino a realizzare quella riduzione teatrale dei Demòni che lo ha tenuto impegnato per ben dieci anni, con la consapevolezza di trascrivere non soltanto una profezia sul nichilismo, ma anche «un’opera contemporanea». Camus ha intuito tutta la potenza drammaturgica dei personaggi dostoevskiani, offrendo loro un nuovo respiro e riabilitando le figure dell’impegno etico soprattutto nei personaggi atei o scettici come il dottor Rieux e Tarrou nella Peste: questo rappresenta, in qualche modo, il suo passo in avanti rispetto a Dostoevskij. Il racconto La caduta (dove un ex avvocato trasferitosi da Parigi ad Amsterdam, si confessa ai casuali avventori di una taverna di porto) tradisce invece il riaffiorare di un nuovo tipo di eroe negativo dal «sottosuolo» postumo dostoevskiano. L’altro grande tema che lega i due autori è quello dell’amore luminoso, declinato in senso cristiano da Dostoevskij, in senso più terrestre e solare, ma non per questo meno attivo e solidaristico, da Camus. In breve, l’attualità di Camus consiste proprio nell’aver riabilitato la possibilità di un’etica atea ma umana nel tempo dell’assurdo, superando così i vari eroi negativi dell’Ottocento (Kirìllov, Ivàn…), cresciuti all’ombra della «rivolta metafisica» contro Dio. Roger Grenier ha scritto lapidariamente: «Camus était Ivàn Karamazov». A me pare che si possa essere d’accordo con tale giudizio solo a metà, ovvero per quel che riguarda la pietà verso gli innocenti che si trasforma in compassione per le vittime in generale. Ma non dimentichiamo che la massima di Ivàn rimane quel «tutto è permesso» che certamente Camus non avrebbe potuto sottoscrivere, per non parlare del Grande Inquisitore, la caliginosa leggenda partorita dalla mente delirante di Ivàn. Viceversa, Camus prende molto sul serio il tema filosofico del «suicidio logico» di Kirìllov, nonché la trama dei Demòni, che si riflette peraltro nel dramma e nel dilemma dei Giusti.
Camus, Dostoevskij e Leopardi sono soltanto apparentemente differenti per scelte narrative e contenutistiche. La lettura delle loro pagine, però, rivela un comune trasporto metafisico per le plurime e molteplici patine dell'animo umano. Quale idea emerge dell’Uomo rispetto alla Libertà?
Parliamo intanto di autori che sono insieme più e meno che filosofi, e che quindi guadagnano in sottigliezza laddove sembrano perdere in rigore concettuale. La libertà rimane alla base della vita etica come della vita tout court: ciò vale per tutti e tre. In modi diversi, i tre autori da lei citati declinano l’idea della libertà nelle più svariate accezioni: espansione delle virtù naturali e civili, possibilità del bene e del male, ricerca della felicità. Ma la libertà si presenta spesso come un frutto avvelenato, che nei nostri tre autori si riveste in effetti di patine diverse, anche perché la morale e la civiltà stessa si fondano sulla possibilità della trasgressione. La società è figlia di Caino, osservava Leopardi. E tuttavia, seppure con sfumature diverse, nessuno dei tre crede affatto che tutto sia permesso, tanto per riprendere il famigerato detto di Ivàn Karamazov. Il Caligola di Camus reclama anche l’impossibile: vuole la Luna! La sua libertà eslege, tirannica e sadica calpesta ogni legge della morale, ispirata com’è a nessun’altra logica che non sia il delirio d’onnipotenza: «Sono io che faccio le veci della peste!». Per Camus, il segreto della libertà non è «uccidere e morire per produrre quello che non siamo» (allusione allo spirito rivoluzionario, oltre che a quello tirannico), bensì «vivere e far vivere per creare quello che siamo» (reale ideale libertario), come leggiamo in una eloquente pagina del Mito di Sisifo. Libertà, al limite, sarebbe anche la possibilità della morte volontaria, come sanno bene certi personaggi di Leopardi e di Dostoevskij: basti ricordare Porfirio e Kirìllov. Tuttavia, come diceva Luporini, la libertà rimane soprattutto «una possibilità esistenziale da mettere in comune», una lotta solidale per la vita e un’alleanza contro il nemico comune che ci rende insieme resistenti e corresponsabili. Ma ciò che ai nostri occhi accomuna i tre autori, è soprattutto la figura della peste come metafora privilegiata dell’egoismo umano, del male etico e metafisico, come ho cercato di mostrare in due recenti saggi, rispettivamente, su Leopardi e Camus (già apparso su «Azioni Parallele») e su Leopardi e Dostoevskij (che dovrebbe uscire su «Il Pensare»). I parallelismi in tal caso si fanno ancora più stringenti e non per nulla Camus era anche un segreto ammiratore di Leopardi, come rivela un’intervista dei primi anni Cinquanta a Giovanni Battista Angioletti per «L’Approdo». Tutti e tre, in modi diversi l’uno dall’altro, combattevano contro la peste dell’egoismo, dell’indifferentismo e del nichilismo etico. Per Leopardi, come per Dostoevskij, la peste moderna è anche la vita ammorbata dai fumi delle metropoli, inquinata dal pensiero ‘geometrico’ e calcolante che domina la logica capitalistica, l’utilitarismo positivista e ormai la stessa psicologia delle masse. Invece, per Camus anche una piccola città mediterranea come Orano può rappresentare la metafora di un male appestante e sempre incombente sull’umanità intera.
Professore, Leopardi e Camus paiono aver costruito un’etica etiam si deus non daretur. Camus può rappresentare il tramonto del nichilismo?
Per me, non c’è dubbio che ci si tratta di due moralisti atei che fronteggiano le fasi, rispettivamente, ascendente e declinante del nichilismo. Camus sviluppa appunto la possibilità di un’etica scettica sulla stessa linea d’onda dell’etica magnanima di Leopardi. Un’etica è possibile, di più necessaria, dacché il cielo è rimasto vuoto. Leopardi e Camus rappresentano due diversi modi di dipingere il cielo deserto del nichilismo, rispettivamente, alla sua alba e al suo tramonto. Camus era quanto mai consapevole dell’esigenza di oltrepassare l’epoca del nichilismo. Tale tramonto segnava per lui al tempo stesso un nuovo preludio, quasi il presagio di una nuova stagione dello spirito meridiano, di quell’«invincibile estate» che egli sentiva pulsare dentro di sé anche a livello lirico. Laddove il malpensante «Galantuomo» di Leopardi si dichiarava «penitente della virtù» solo per paradosso, nel Clamence di Camus la figura del «juge-pénitent» sprofonda letteralmente nella falsa e cattiva coscienza messa a nudo nella Caduta.
Emil Cioran avvertì Giacomo Leopardi quale «fratello d’elezione». Quali analogie o differenze ravvede nella concezione del tempo?
Con il pensatore e aforista franco-romeno giungiamo al «culmine della disperazione». Al pari di Leopardi, Cioran è uno spirito scettico e chiaroveggente, un insonne interprete del nulla, del dolore e della noia che circondano la nostra esistenza. Se Leopardi si aggrappa al «fiore del deserto», simbolo del suo stesso genio poetico-filosofico, Cioran coglie il fiore nero del nichilismo per offrirlo al più sconsolato e desolante estetismo del male di vivere, all’inesausto splendore dell’inferno. Oltre a considerare Leopardi «un compagno e un benefattore», Cioran poteva confidare all’amico Mario Andrea Rigoni: «rien de ce qui touche à Leopardi ne m’est étranger». Ma Cioran non conosce alcun «paese delle chimere» in cui poter rovesciare il proprio giardino dei supplizi, nessuna redenzione se non nel nulla, rivelandosi, a tratti, più vicino a Schopenhauer, oltre che a Buddha. Circa la questione del tempo, a Leopardi si stringeva il cuore pensando a come tutto al mondo passa; pensando al rapido svanire di una fanciulla in fiore, alla rovina del tempo e delle antiche civiltà… Invece, Cioran contempla la costante perversione del nulla nell’essere e il continuo precipitare nella diminuzione e nella decadenza dell’essere. Mi sia consentito citare un suo aforisma che rende bene l’idea: «Dopo aver sciupato l’eternità vera, l’uomo è caduto nel tempo, dove è riuscito, se non a prosperare, per lo meno a vivere: la cosa certa è che vi si è adattato. Il processo di questa caduta e di questo adattamento si chiama Storia». Si tratta dunque di una «caduta nel tempo», come appunto recita uno dei titoli più suggestivi dell’ammaliante collana di perle nere dell’opera di Cioran. Una collana che stringe la gola di ogni lettore, proprio mentre lo alletta col gusto del veleno, con la «voluttà dell’insolubile», con l’arte dello stile, con la paradossale, ironica e solitaria arte di vivere ai bordi del pensiero estremo. Se per Leopardi l’uomo è un animale insocievole, per Cioran è un «animale astioso», e questo suo carattere lo trascina, fra rancore e abitudine, nel tempo senza meta della storia, illuminato solo da fosche utopie apocalittiche. Infine, mentre la gnosi leopardiana è stata vanamente inseguita dal compianto Cesare Galimberti, la figura gnostica del «cattivo demiurgo» sicuramente si attaglia di più a descrivere il mondo come appare agli occhi di Cioran, tanto da suggerire appunto il titolo al Funesto demiurgo, che si conclude ripetendo mestamente l’antica litania – insieme silenica e buddhistica – della vanità del tutto: «Bisognerebbe dirsi e ripetersi (…) che tutto è perfettamente derisorio e vano». Penso che si possa credere a Cioran quando confessava di non aver scritto quasi nulla su Leopardi per un «eccesso di complicità», tanto che una volta gli sarebbe sfuggita l’impagabile boutade: «Leopardi mi ha plagiato!».
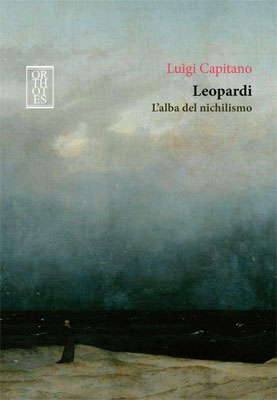
A cura di Giusy Capone e Afrodita Cionchin
(n. 2, febbraio 2022, anno XII)
Nota bibliografica
Fra i più recenti contributi leopardiani di Luigi Capitano si annoverano: La mitologia dopo Natale Conti. Il «mondo fanciullo fra Vico e Leopardi, in Il corpo dell’idea, a cura di F. Cacciapuoti (Donzelli, 2019); Naufragio nel Nulla: Leopardi e Schopenhauer, «Il Pensare», 9 (2019); Leopardi apocalittico. Moniti per la nuova era, «Costellazioni», 10 (2019); «What then is happiness, my friend?» Giacomo Leopardi to André Jacopssen, in Dear Friend, You Must Change Your Life. The Letters of Great Thinkers, Ada Bronowski (ed.), Bloomsbury 2020; La felicità delle chimere. Leopardi e Rousseau, in M. Herold - B. Kuhn (Hrgs.), Lebenskunst nach Leopardi. Anti-pessimistische Strategien im Werk Giacomo Leopardis, Narr, 2020; in M.V. Dominioni-L. Chiurchiù (a cura di), Leopardi e la cultura del Novecento. Modi e forme di una presenza. Atti del XIV Convegno internazionale di studi leopardiani, Olschki, 2020; Le ali della mezzanotte. Leopardi ‘gotico’, il gallo cabbalistico e la «morte di bacio», «Letteratura e pensiero», 8 (2021); Leopardi e Camus. Per un’etica scettica della solidarietà, «Azioni Parallele», maggio 2021; Leopardi e lo «spazio immaginario» dell’Infinito, in Declinazioni dello spazio nell’opera di Leopardi, a cura di A. Del Gatto e P. Landi, LED, 2021; Leopardi e d’Holbach. La “macchina sconcertata” e le rovine del cielo, «RISL», Mimesis, 13 (2021); Aristotle, Leopardi, Severino: the endless game of nothingness, «Eternity and contradiction», 5 (2021);
|
|

