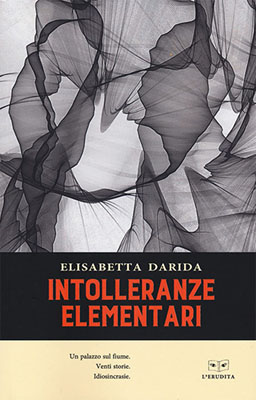|
|
Elisabetta Darida: «L’ironia è senza dubbio la mia cifra stilistica»
 Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori candidati al Premio e quelli segnalati all’edizione n. 76, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori candidati al Premio e quelli segnalati all’edizione n. 76, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.
Elisabetta Darida è stata segnalata per il romanzo Intolleranze elementari (L'Erudita, 2021). Antonella Sabrina Florio lo presenta così: «Intolleranze Elementari è un indice puntato contro la diversità che disturba. Un affresco graffiante tracciato con una scrittura fluida e incisiva che non fa sconti, perché dietro all’ironia sottile che lo permea, si cela tutta la pesantezza dell’intolleranza, sia essa subita o inflitta. Un velo nero, come lo definisce l’autrice, che per essere trasparente e impalpabile non è certo meno cupo. Venti esistenze che si raccontano senza remore in altrettanti monologhi, ciascuno con la propria voce, il proprio stile, il proprio carattere, dando libero sfogo alla rabbia, alle passioni, alle aspirazioni e alle frustrazioni che guidano i loro pensieri e il loro agire».
In Intolleranze elementari venti storie per ridere a fior di labbra, piagnucolare, adirarsi, atterrirsi e sempre meditare. Donne maltrattate, amori discriminati, vite straniere che con sforzo agognano a reinventarsi, famiglie sul punto di deflagrare, tra silenzi e imbrogli, ricusazione dell’altro, impegno nel cogliere il proprio posto nel mondo. Ha inteso illuminare il banale quotidiano?
Mi interessava porre in luce le intolleranze quotidiane, le piccole (ma a volte neanche troppo) insofferenze e i soprusi che subiamo e che facciamo subire agli altri, che ho definito elementari proprio perché a prima vista non paiono gravi. Sono gli atteggiamenti carichi di negatività cui non diamo importanza – e di cui talvolta neppure siamo consapevoli – che scaturiscono da cliché, luoghi comuni, frasi fatte. E il termine «banale» alla sua domanda è perfettamente calzante, perché queste intolleranze hanno un peso apparente molto leggero, non sembrano portare conseguenze preoccupanti. Le vedo come un lieve velo nero – e, infatti, è questa l’immagine che ho scelto per la copertina del libro – perché del velo hanno l’impalpabilità, e ciò porta a sottovalutarle. Ma è solo un’apparenza perché le parole hanno sempre un grande peso e una potenza che può essere devastatrice: infiammano, suscitano emozioni, provocano entusiasmi ma anche ferite e lacerazioni. I miei personaggi, ciascuno con il proprio linguaggio, la propria cultura e la propria personalità e sensibilità, narra – a volte anche sorridendo – le intolleranze di cui è vittima o carnefice. Sono piccoli accadimenti di tutti i giorni, ma quotidianità non vuol dire insignificanza. Perché dietro l’apparente banalità dei piccoli gesti e delle frasi buttate là si nasconde un sentimento che va sedimentando fino a quando una scintilla – un momento di difficoltà personale, sociale, economica, politica – è sufficiente perché questo sentimento blando si trasformi in odio e dia vita a una tragedia. E il racconto di queste intolleranze sotto forma di monologhi rende ancor più l’idea della chiusura: nessuno interloquisce con l’altro, non c’è confronto, ciascuno parla in solitudine. Nel libro, alcuni personaggi sono vittime, altri aguzzini, ma al dunque, le intolleranze – siano pure elementari – appesantiscono la vita di entrambi: nessuno si salva dai loro effetti nefasti.
Le esistenze dei venti protagonisti, struggenti, aspri, drammatici, burleschi, si incrociano in modo più o meno intenzionale in una trama tessuta intorno a un palazzo romano affacciato sul Tevere. Quale idea ha desiderato veicolare dei rapporti umani?
Mi affascina la connessione tra le persone, che va oltre la consapevolezza e la percezione. Ciascuno di noi ha una propria storia, un dipanarsi dell’esistenza tra piccoli e grandi accadimenti, tra gioie e drammi personali, ma siamo tutti parte di una realtà più vasta, indissolubilmente legati e dipendenti dagli altri. La vita è un grande affresco, una ragnatela di relazioni più o meno fragili, dagli equilibri più o meno precari e di durata e intensità variabili, dove il destino individuale è anche collettivo. Ogni azione, ogni pensiero, positivo o negativo, si riverbera sulle esistenze altrui in un gigantesco effetto domino, anche se non sempre è immediatamente percepibile. La struttura stessa del libro riflette questa caratteristica: i venti monologhi possono essere letti in qualsiasi ordine e hanno tutti un inizio e una conclusione che li rendono autonomi e ‘finiti’. Ogni personaggio, però, cita uno o più nomi. E se da un lato queste menzioni non richiedono un approfondimento per la comprensione di quel racconto, dall’altro – proseguendo nella lettura – ritroviamo questi nomi, perché si tratta dei protagonisti di altri monologhi. Appaiono allora le interconnessioni e il quadro va allargandosi. Mi diverte immaginare che sia quasi una trasposizione su scala minima della teoria dei sei gradi di separazione di Stanley Milgram.
Il tema di fondo, però, è quello del rifiuto, della difficoltà di accettare l’altro, il diverso che disturba, il mondo che cambia. Sono tutti pervasi dallo stesso malessere, i personaggi, e mentre alcuni questo sforzo lo fanno, altri non ci riescono o neppure ci provano. Anche perché l’arroccarsi nelle proprie posizioni può essere rassicurante: muoversi nei confini del mondo conosciuto è la certezza della solidità dell’ordine costituito delle cose. Mettersi in discussione è un esercizio faticoso e anche doloroso, è una porta che – una volta aperta – non si può richiudere e far finta di nulla.
Quanto ha attinto allo sterminato patrimonio della commedia cinematografica in una scoppiettante contaminatio fabulae?
Non è stato intenzionale. Ho semplicemente ritratto una porzione di varie esistenze così come le ho viste o le ho immaginate. Del resto, la contaminazione è inevitabile: il lavoro di scrittura, quale che sia il mezzo con cui verrà veicolato – un libro, un film, una pièce di teatro – è una rilettura e una rielaborazione costante della realtà o dell’immaginazione, così come lo sguardo soggettivo la percepisce. Insisto sulla rielaborazione: Omero ha già detto tutto! I secoli passano, ma i temi narrativi restano gli stessi, perché sono quelli della vita umana: l’amore, il dolore, la morte, la ricerca della felicità, il desiderio di dominio… Parafrasando Lavoisier, possiamo affermare che nulla si crea e tutto si trasforma: cambia l’occhio che scruta la realtà, cambia lo scenario, cambiano la prevalenza delle tematiche e il linguaggio a seconda del periodo storico, ma le fond de la chose non varia, è un grande movimento ciclico, perché tutto poi ritorna.
Questo è un libro che gratta il fondo della sfera affettiva; vaglia meticolosamente i sentimenti, emozione, ossessione, attrazione, passione, per poi scaraventarli, di nuovo, sul fondo, senza sterili edulcorazioni. Qual è la sua personale cifra stilistica?
Direi l’ironia, senza alcun dubbio. È un’arma potente, l’ironia, perché la sua levità espressiva consente di trattare in modo leggero – e qui mi richiamo a come la intendeva Italo Calvino quando ammoniva che leggerezza non significava superficialità – temi delicati e dolorosi come l’omofobia, la xenofobia, il maltrattamento delle donne e degli anziani. O argomenti apparentemente meno drammatici come le coercizioni dei genitori verso i figli che rifiutano un futuro già scelto da altri o dei figli che vogliono negare una vita sentimentale ai genitori anziani in virtù di interessi economici che poco hanno a che vedere con l’amore filiale. L’ironia porta con sé la riflessione e forse meglio di un tono cattedratico può mettere in luce l’assurdità di certe opinioni, di certi gesti.
La contemporaneità non contempla esclusivamente le opposizioni oralità/scrittura e poesia/prosa, ma anche la possibilità di scelta tra e-book/online e cartaceo, tra letteratura cartacea e digitale. Quanto lo sguardo di un autore è condizionato dal profumo della carta stampata o, viceversa, dalla comodità del digitale?
Qui mi piace rispondere come lettrice. Anni fa ho ricevuto in regalo uno dei primi reader elettronici. La mia prima reazione è stata di sospetto, esprimendo così a priori la mia intolleranza elementare, istintiva e non ragionata! Poi l’ho provato. Con soddisfazione perché – specie in viaggio – consentiva di risparmiare alcuni chili di carta in valigia e qualche mal di schiena. Ma la soddisfazione è stata di breve durata: rimango affezionata al libro cartaceo, al piacere del tatto, al dispiacere di vedere l’assottigliarsi dello spessore delle pagine che conduce alla fine della lettura, e anche al gusto della piccola caccia al tesoro per rileggere un passaggio, che sulla carta possiamo collocare in un punto fisico del libro – verso metà, su una pagina di sinistra, in basso – un piacere negato dalla versione elettronica. E da quando ho scoperto che paperless non vuol per forza dire minor impatto ambientale – anzi – sono ancora più felice del mio gusto ‘tradizionale’.
Francesco De Sanctis scrisse che la letteratura di una nazione costituisce una «sintesi organica dell'anima e del pensiero d'un popolo». Posto che la letteratura siauno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?
Non vedo cambiamenti rispetto al passato, intendendo per passato il XIX secolo con lo sviluppo del romanzo moderno che oltre ai classici temi di amore e gesta d’arme ha indagato temi sociali o psicologici di maggior complessità.
Purtroppo – e i gravi fatti internazionali ne sono l’esempio lampante – i meccanismi che governano l’Uomo non mutano molto. Nel bene e anche nel male. E sono forse un po’ ingenui – per non dire ipocriti – il nostro sgomento e la nostra sorpresa dinnanzi a fatti sanguinosi che ci fanno esclamare «pensavo che una cosa del genere non si sarebbe mai più ripetuta!». Dai tempi del primo narratore i misfatti dell’Uomo non sono cambiati, quel che è cambiato è la nostra sensibilità su certi temi. E la scrittura continua oggi a esercitare la sua funzione fondamentale non solo di intrattenimento, ma anche di denuncia. Basti pensare al contributo che tanti scrittori hanno portato e portano alla causa della libertà con la loro lotta senza spargimento di sangue per una società democratica e più giusta. Alcuni anche pagando con la prigione o con la vita.
Da questo punto di vista, la diffusione delle tecnologie, la maggior facilità di comunicazione con il mondo e la reperibilità anche online di libri facilita il compito della scrittura, che è e resta un’arma potente per indagare l’animo umano e additarne le storture.
Hegel sviluppa una definizione del romanzo: esso è la moderna epopea borghese. Lukács afferma che questo genere, essendo il prodotto della borghesia, è destinato a decadere con la morte della borghesia stessa. Bachtin asserisce che il romanzo sia un «genere aperto», destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme «ibride». Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?
Mi trovo a mio agio con l’affermazione di Bachtin: il romanzo continua a trasformarsi, seguendo l’evoluzione della società, mentre non riesco a immaginare la morte della borghesia, secondo Lukács. Oggi sicuramente c’è una maggior fluidità, siamo meno vincolati a canoni formali della scrittura e le contaminazioni tra generi sono frequenti, basti pensare – in tempi più recenti – all’ampiezza che sta prendendo il graphic novel (la cui apparizione risale comunque agli anni settanta, parliamo di cinquant’anni fa). Ma, se vogliamo, una prima rivoluzione l’avevano già compiuta Proust e poi Joyce introducendo la voce interiore dell’io narrante, creando una frattura con gli schemi precedenti.
Lo scrittore è un osservatore della realtà e la sua urgenza di raccontare e raccontarsi non è avulsa dal contesto sociale e da come questo evolve. Il romanzo continuerà, quindi, ad abbracciare la realtà nelle sue sfaccettature, adattandosi proprio perché non è un esercizio accademico di composizione.
La vera questione della scrittura, a mio avviso, è più culturale in senso ampio e riguarda maggiormente il lato del lettore che non quello dello scrittore: si legge poco, almeno in Italia. A fronte del numero impressionante di pubblicazioni, non vi è un corrispettivo di lettori: da una recente indagine Istat, è risultato che il 60% circa degli italiani dichiara di aver letto un libro o anche meno in un anno! E i lettori cosiddetti forti, quelli che in un anno leggono dai dodici libri in su – quindi un libro al mese o di più – sono solo il 12%. L’interrogativo sull’evoluzione della scrittura deve accompagnarsi all’interrogativo su come avvicinare o riavvicinare alla lettura. Da questo punto di vista, se da un lato le tecnologie aiutano nella diffusione strumentale dell’oggetto libro, dall’altro rappresentano anche uno strumento di distrazione: è più facile passare del tempo con un videogioco o a ‘surfare’ internet che ci propone immagini e opinioni precotti – incentivando l’assorbimento passivo di informazioni – piuttosto che raccogliersi nell’esercizio impegnativo che rappresenta la lettura di un libro.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?
Le donne sono sempre portatrici di una sensibilità particolare nell’indagare l’animo e non voglio cadere nella banalità nel ripeterlo. Di certo questo è un momento di forte dinamismo, anche se non mi piace usare l’espressione di letteratura femminile o al femminile, perché trovo sia una categorizzazione, e come tale è riduttiva e ghettizzante. Una scrittrice è una persona che scrive e basta. E la sua letteratura è letteratura e basta. Diciamo che la scena letteraria è particolarmente ricca di autrici che con una scrittura nitida e incisiva sanno anche maneggiare la penna con durezza, scarnificando il dolore e la sofferenza senza sconti – penso a Teresa Ciabatti o Chiara Marchelli, o ancora Nadia Terranova e Giulia Caminito – o trattare temi con uno stile che a volte – e in modo stereotipato – è stato definito maschile come è il caso di Claudia Durastanti. Ma potrei citarne ancora moltissime e non solo italiane! In ogni caso, le mie scelte di lettura non sono mai determinate dal genere dell’autore. Il compito della letteratura è suscitare l’interesse e le emozioni del lettore, alimentarne la fantasia e deve portare con sé una riflessione. Indipendentemente dal sesso di chi scrive e di chi legge.
La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2021. Quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?
Non ho una visione sulla diffusione della letteratura romena in Italia, posso solo citare la mia esperienza personale. In particolare, ricordo mio padre che leggeva Mircea Eliade e Cioran. Ho ereditato i suoi libri e se non ho ancora letto Eliade – in casa c’è Initiation, rites, sociétés secrètes il cui argomento mi attira e che prima o poi affronterò, mi piace ogni tanto leggere qualche riga di De l’inconvénient d’être né di Cioran, anche se non ne condivido il pessimismo!
Tornando alle donne nella letteratura, ho letto alcune delle poesie di Ana Blandiana, purtroppo in traduzione italiana, e recentemente – dietro consiglio di un amico – ho acquistato Solenoide di Mircea Cărtărescu.
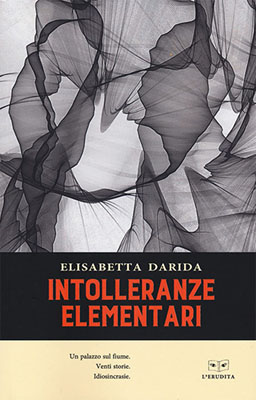
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 5, maggio 2022, anno XII)
|
|

 Nella sezione
Nella sezione