









|
|
Anna Maria Panzera: «Il femminile, un valore condiviso, plurale, vivente, particolare, metamorfico»
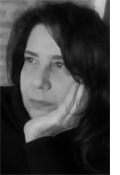 A giugno, la nostra inchiesta esclusiva sulla donna artista si arricchisce di una nuova serie di interviste che approfondiscono e allargano ulteriormente la prospettiva sull’argomento. A inaugurare questa rinnovata rassegna di dialoghi è Anna Maria Panzera, insegnate e storica dell’arte, ideatrice e curatrice del progetto e del libro Femm[E]. Arte [eventualmente] femminile (2019, Bordeaux Edizioni), insieme all'artista Veronica Montanino. A giugno, la nostra inchiesta esclusiva sulla donna artista si arricchisce di una nuova serie di interviste che approfondiscono e allargano ulteriormente la prospettiva sull’argomento. A inaugurare questa rinnovata rassegna di dialoghi è Anna Maria Panzera, insegnate e storica dell’arte, ideatrice e curatrice del progetto e del libro Femm[E]. Arte [eventualmente] femminile (2019, Bordeaux Edizioni), insieme all'artista Veronica Montanino.
In questa intervista, Anna Maria Panzera ci offre interessanti spunti di riflessione che vanno dalla presenza delle donne nell’arte, alla condizione dell’artista-donna in Italia, alle «plurime e molteplici anime dell’arte declinata al femminile» fino all’impatto della pandemia Covid nel settore artistico.
Il progetto, a cura di Giusy Capone e Afrodita Cionchin, andrà avanti nei prossimi numeri, continuando ad arricchire la nostra rete per il dialogo interculturale. Tutti i contributi sono riuniti nel nostro spazio appositamente dedicato a questo progetto, Inchiesta esclusiva donna artista.
Le donne sono state costantemente presenti da quando esiste l’arte stessa; tuttavia, sino al XVI secolo, il loro tributo documentato rimane scarsamente visibile. Quali sono, a suo avviso, le ragioni per le quali è stato così arduo sottrarsi all’invisibilità e come vede oggi la condizione dell’artista-donna in Italia?
Le donne sono presenti nell’arte da sempre: è così e lo sarà fino alla fine dei tempi, perché l’arte e la creatività sono specificità umane, che prescindono e trascendono il genere, esattamente come nascere e morire. Altra cosa è la prova documentale delle epoche remote (dove la ricerca non può andare oltre l’ipotesi), la riflessione sul mercato, sulla storiografia, sull’organizzazione sociale e soprattutto sulla storia del pensiero. Allora, la prospettiva cambia e il problema da lei posto è forse peculiare del mondo ‘occidentale’: un aggettivo che indica non solo una collocazione geografica ma l’affermarsi nel tempo di precisi valori politici e filosofici legati principalmente al logos greco, che il cattolicesimo da un lato, e il razionalismo dall’altro, hanno trasformato in pensiero dominante. Non ho studiato a sufficienza altre culture, a dire il vero. Però sono certa che in esse, come da noi fino a tutto l’Alto medioevo, la mancanza di documentazione sugli artisti – salvo casi eccezionali – rimane un fatto estendibile a uomini e donne, legato a due fattori: 1) la società non ne riconosceva l’autorità intellettuale; mettere una firma sotto un affresco, una statua, una miniatura, un polittico, non aveva senso, maschi o femmine che si fosse. La figura dell’artista e quella dell’artigiano sfumavano l’una nell’altra. 2) Non ci sono fonti dirette da analizzare, semmai qualche narrazione, che appartiene più al mito che alla storia. A mano a mano che il tempo passa, le fonti – soprattutto scritte – aumentano ed è possibile farsi un’idea più chiara. L’evoluzione del diritto (e della società) in Europa ha fatto sì che prevalesse un carattere patriarcale nell’organizzazione del lavoro, ma si sa che dal Basso Medioevo in poi mestieri e corporazioni (come raccontano le carte dell’Accademia di S. Luca a Roma e altri documenti), comprendevano schiere di operatrici riconosciute nel settore artistico (mi vengono in mente le imperniatrices, che lavoravano nel settore dell’oreficeria, oppure le tante artiste e artigiane qualificate impiegate nella fabbrica di S. Pietro); molte ereditavano le botteghe di padri e mariti, emergendo come imprenditrici ante litteram. La loro legittimazione, tuttavia, passava attraverso rappresentanze maschili; persino Artemisia Gentileschi, che lavorava presso le più importanti corti d’Europa, aveva bisogno della firma del marito o del fratello per chiudere i contratti. Può immaginare che il fenomeno si sia rafforzato con l’andar del tempo. Dunque, di che invisibilità stiamo parlando? Nell’epoca della loro esistenza queste donne erano visibilissime. La mancanza di riconoscimento e soprattutto di narrazione di tali presenze, invece, deriva da una cultura che ha un enorme problema con l’immagine della donna, incarnazione stessa della creatività, prova provata che creare è un fatto naturale e fisiologico, anche quando si è nel campo delle idee. Per secoli, invece, si è voluto spostare tale capacità nella sfera ideale, mistica, religiosa, astratta, e farne il secondo termine del dualismo inconciliabile su cui la nostra cultura è fondata (corpo/anima, materia/spirito, mano/mente, ecc.). Alienarla nella sfera metafisica, dalla quale poi discenderebbe nuovamente nell’uomo (in forma di grazia, ispirazione, idea: Platone docet), trasformava l’ideazione e la creatività – e massimamente l’arte – in un esercizio di potere, che andava dal pensiero soggiacente alla costruzione della polis fino al mito del genio (maschile). Adriana Cavarero lo spiega benissimo e rimando ai suoi libri chi si voglia informare di più. Il mestiere dell’arte non è particolarmente responsabile di discriminazioni. Il pensiero e l’uso sociale dell’arte, sì.
Pensando all’essere artista-donna, ravvede una specificità di punto di vista esclusivamente muliebre; un fil rouge che annoda le plurime e molteplici anime dell’arte declinata al femminile?
È difficile rispondere senza avere un arco temporale di riferimento. Tendenzialmente direi di no. Ogni artista pone in essere la propria individualità e la propria vita nell’opera; pertanto, nel caso si trattasse di una donna, i contenuti sottesi alla forma ne dichiarerebbero le esperienze, la storia, la sensibilità, le riflessioni, la ricerca: se ciò fosse contrassegnato da questioni di genere, queste emergerebbero senz’altro. Accade con molta evidenza oggi nei paesi caratterizzati da un background storico post-colonialista, o in quelli dove vigono regimi politico-teocratici fortemente discriminatori. Nel mondo occidentale è accaduto negli anni Sessanta e Settanta con la nascita del secondo femminismo. L’arte si faceva portatrice di contenuti molto politicizzati, che denunciavano la strumentalizzazione del corpo delle donne, la loro condizione di subalternità sociale, civile, legale, morale: una contestazione fatta con gli strumenti dell’espressione artistica, che il mondo anglosassone, in particolare, ha formulato e mantenuto come filone organico e coerente. In Italia il fenomeno ha avuto esiti differenti. Dall’istituzione dei collettivi di Rivolta Femminile (legati strettamente agli ambienti artistici), alla presa di posizione di Carla Lonzi a favore della militanza politica integrale, alla separazione fra questa e Carla Accardi, si assiste a una specie d’impasse: politica e arte continuano a dichiararsi femministe, in alcuni casi (si veda Tomaso Binga, per esempio); in altri, invece (mi riferisco proprio all’Accardi), la libertà creativa rivendica spazi più ampi, pensando che in essi risieda l’intrinseca azione politica che comprende anche la questione femminile, inevitabilmente.
D’altro canto, da un punto di vista strettamente formale, come si possono ravvisare precise specificità di genere? Nell’Europa dell’età moderna e contemporanea alcune artiste le hanno fatte corrispondere all’eccellenza di alcuni lavori domestici (tessitura, ricamo...), ripresi e separati dall’antica funzione, ma forse le studentesse del Bauhaus avrebbero avuto qualcosa da ridire. In alcune ‘coppie’ d’arte il tocco è indistinguibile. Camille Claudel e Rodin: alcuni periodi delle rispettive produzioni si sovrappongono, perché forte era l’assonanza d’intenti e ricerca; e chi può dire se il tratto di Elaine Fried è più femminile di quello di Willem de Kooning? Porre la questione in maniera preconcetta, senza entrare nel merito delle singole vicende e degli stili individuali, crea un terreno scivoloso. Si rischiano pregiudizi al contrario. Altra cosa è, come ho già avuto occasione di raccontare sulla vostra rivista (cit. n. 12, dicembre 2020, anno X), andare alla ricerca di un ‘femminile’ come ‘categoria dell’essere’, oltre il genere, per definire qualcosa di diverso rispetto a quanto è stato culturalmente detto ‘maschile’. Troveremo, allora, tanti artisti uomini che si dichiarano ‘creativamente’ femmine.
Esiste un network delle peculiari professionalità artistiche, ovverosia un’unione tra i modelli teorici e le prassi artistiche, pensando a collezioniste, critiche, curatrici, artiste della mano e del digitale?
Esistono network di questo tipo soprattutto nel mondo anglosassone, coerentemente con quanto scritto sopra. Per esempio, la Women in the Arts & Media Coalition nata a New York nel 2012 (www.womenartsmediacoalition.org), attenta in particolare alle arti performative e in contatto con enti e istituzioni accademiche; oppure la Association of Women in the Arts – AWITA di Londra (https://awita.london/), che dal 2016 riunisce galleriste, curatrici, studiose ma anche altre professioniste del sistema dell’arte. La loro presenza sul web mette tali associazioni in contatto con il mondo, aprendole a esperienze internazionali; il loro compito è di trovare fondi e risorse a beneficio delle donne artiste, aiutandole a eccellere nel campo che gli compete. Sono solo due esempi – e altri se ne potrebbero fare – che fanno capo a un’impostazione professionale completamente diversa dalla nostra, impostata sul ‘fare rete’, sul peer support, sul mentorship, sul lavoro collaborativo. Non voglio farne la regola d’oro in assoluto, ma non c’è dubbio che è interessante cambiare prospettiva sulla visione individualista predominante nella nostra cultura, che contrappone l’artista a tutti gli altri, ne fa l’antagonista sociale per eccellenza, se non il reietto. L’artista è un/una ribelle, ma il suo è un lavoro e la sua funzione – tramite l’apertura di visioni alternative sul mondo – è eminentemente sociale e pubblica e andrebbe riconosciuta come tale, anche per evitare un eccessivo atteggiamento concorrenziale da parte degli artisti o il monopolio dei nomi legati alle gallerie più influenti, che non danno conto della varietà delle ricerche estetiche esistenti. I collettivi di artiste erano un fenomeno presente anche in Italia, all’epoca delle battaglie per una professionalità riconosciuta prima, e per il diritto a un «pensiero della differenza» poi: penso ai primi decenni del ’900 e a quanto accadde intorno alla rivista «Donna», che promosse una serie di Esposizioni Internazionali Femminili di Belle Arti; successivamente, agli anni Settanta e al loro tipico associazionismo, che dette vita a tantissime esperienze. Trovo interessanti, invece, tutte quelle occasioni che aprono fra artiste e artisti, galleristi/e, storici e storiche dell’arte e tutti gli operatori del settore, un confronto reale, che dia occasione di una ‘militanza’ intesa come ricerca e partecipazione alle contingenze che attraversiamo, alla rivisitazione degli spazi pubblici e urbani, al sovvertimento delle gerarchie. In questo, mi piace ricordare l’esperienza di FEMM[E] cui ho già fatto cenno sopra e che ho la presunzione di pensare abbia anche ispirato questa serie di articoli, cui felicemente partecipo.
Dagli anni ’60 del Novecento il corpo delle donne diviene l’interprete della discussione politica, il movimento femminista esplora i paradigmi e i ruoli stereotipati delle donne, mentre l’azione dei collettivi arricchisce le meditazioni sulla differenza di genere. La sua storia personale può documentare ostacoli dovuti alla sperequazione di genere?
No, niente di cui mi renda conto, almeno, a livello personale. Ciò non significa che non ne sia una vittima indiretta: di un sistema, di un modo di vedere, pensare e agire ormai assunto a norma o a normalità (che è ancora peggio). La sperequazione di genere, allora, diventa una delle tante facce – collegate – di un sistema negante da trasformare in toto. Lavoro in un mondo apparentemente dominato dalle donne, quello della scuola; eppure la pressione dei meccanismi che sposano le logiche economico-politiche a quelle culturali si sente e agisce: sulla visione delle donne, certo, ma anche degli adolescenti, ragazzi e ragazze che il mondo adulto non è in grado di vedere e ascoltare. Che lei abbia citato il ‘corpo’ come elemento di discussione politica è interessante, perché coinvolge diversi soggetti e relazioni. Mi fa pensare alla concretezza dell’esistenza e alla necessità di un sano rapporto, materiale e non, con essa. Se ci guardiamo in giro, troppo spesso la vediamo negata: bambini, donne, migranti, natura, oriente e occidente... è il momento di rivedere i criteri con cui ci rapportiamo a queste realtà.
Può individuare dei campi artistici meritevoli di un’attenzione speciale, oggi?
I modi e i materiali dell’arte seguono le immagini, le ricerche, i processi di realizzazione delle opere, che diventano sempre più numerosi e sempre meno classificabili. Quando un’immagine, e la materia che la rende visibile (che può essere anche effimera), sono ben assortiti ed efficaci, lì nasce la meraviglia dell’arte. Le contaminazioni tra generi e tecniche sono ormai, per fortuna, all’ordine del giorno. La tecnologia spesso è spiazzante e i suoi risultati sorprendenti. Confesso, tuttavia, di rimanere particolarmente affascinata dalle opere che riescono a coinvolgere lo spazio vissuto, che assumono una dimensione ambientale e circondano lo spettatore dislocandone lo sguardo, costringendolo a muoversi, partecipando in qualche modo all’immagine che si ‘fa’ sotto i suoi occhi. La ricerca sul femminile nell’arte mi ha condotto a esplorare quella sulla natura e sulla re-interpretazione che ne danno artisti e pensatori contemporanei. Penso a Stefano Mancuso, a Emanuele Coccia, Fritjof Capra, Gilles Clement e al numero enorme di sperimentazioni artistiche che vanno in questa direzione, spesso coinvolgendo gli spazi urbani. In questo caso, per me, rispetto al pensiero unico, maschile e razionale della tradizione occidentale, il ‘femminile’ è un valore condiviso, plurale, vivente, particolare, metamorfico, che esprime la creazione come proliferazione organica, ispirata dalle piante e dagli organismi viventi. Sono ancora impressionata dalla mostra di Tomás Saraceno a Firenze e dall’ultima installazione di Ólafur Elíasson, Life, alla Fondation Beyeler di Basilea.
Qual è, secondo lei, la funzione sociale dell’arte ai nostri giorni? In che modo le opere d’arte possono offrire strumenti per osservare il mondo e i suoi mutamenti?
L’anno scorso, spinta da alcuni artisti (Veronica Montanino e Francesco Bancheri in particolare) alla riflessione e all’elaborazione congiunta di una proposta progettuale [1] per Roma, non potevo fare a meno di costatare come la pandemia avesse sollevato il velo su problematiche preesistenti, che allora – come ora – venivano alla luce in tutta la loro gravità. Notammo e mettemmo per iscritto, sottoponendo il nostro documento alle autorità competenti, che la sospensione di tutte le iniziative e le attività legate al mondo dell’arte e non solo, lo svuotamento delle aree condivise (strade, piazze, ecc.), il disgiungimento forzato delle persone in entità isolate, acuivano l’esigenza di riconquistare lo spazio pubblico, reinventando il momento della sospensione e facendolo diventare un opificio di pensieri e azioni future. Capivamo che per realizzare quest’aspirazione era necessario innanzi tutto evidenziare un’anomalia tutta italiana, per la quale gli artisti contemporanei rimangono invisibili, salvo essere ripescati per interventi e dichiarazioni di tipo demagogico. Nel paese la cui fama e bellezza è stata costruita grazie all’intervento degli artisti nella vita pubblica e alla trasformazione da essi impressa al tessuto urbano, si assiste alla cristallizzazione di quest’ultimo: dai centri storici alla periferia, permane l’assuefazione ai paesaggi esistenti, spesso imposti dalla cattiva politica, fatti passare per inevitabili e come tali subiti. L’arte, a nostro parere, avrebbe dovuto farsi carico di un nuovo pensiero figurativo, capace di offrire ai cittadini nuove immagini di riferimento, che unissero l’abitare all’immaginazione. Argan, Contardi e Mumford affermavano l’identità arte/città; individuavano la nascita stessa dell’arte nell’occupazione/definizione di uno spazio abitato, di una soglia esterno/interno, di un percorso. Prevedevano, inoltre, anche interventi sui centri storici, che da sempre sono un esempio di stratificazione di epoche diverse. Dov’è finita quell’apertura mentale? Forse la domanda che lei mi pone dev’essere rovesciata: non si tratta (solo) di immaginare come l’artista debba intervenire sul mondo, e neanche di rivisitare il suo ruolo sociale: è la società che dovrebbe decidere di confrontarsi profondamente con il pensiero dell’artista, il quale rappresenta un’alterità di cui non si può fare a meno. A maggior ragione, in considerazione del punto cui ci ha condotto il pensiero corrente, neo-liberista.
La pandemia da Covid-19 quali mutamenti apporterà nel settore artistico, a suo avviso?
Come nella vita di tutti, potenzialmente tanti e nessuno. Dipende dalle persone, dall’ambito operativo, dai mezzi a disposizione. In generale, il digitale ha avuto un grande impatto e la costrizione a usarlo in ogni ambito l’ha reso una risorsa e un grande supporto, per mantenere e talvolta allargare l’offerta di musei e gallerie. Credo che una fetta di pubblico (penso in particolare ai più giovani) – la cui attenzione è altrimenti rivolta – essendo costretta a casa, abbia trovato nelle mostre virtuali un incentivo a ‘visitare’ luoghi altrimenti estranei; il linguaggio digitale, spesso unito a quello analogico, ha funzionato da ‘facilitatore’ per contenuti complessi; ha condotto l’occhio degli spettatori su dimensioni e particolari spesso invisibili, facendo gustare l’opera d’arte da prospettive inedite. Molte strutture e istituzioni hanno così interagito virtuosamente con le scuole e le università. Sarebbe auspicabile che ciò spingesse i musei a ripensarsi; adesso sono luoghi paradossali: da un lato fomentano fenomeni di turismo massificato, fatto di persone che guardano senza vedere (inoltre, i grandi poli sottraggono fondi a quelli più piccoli, che rimangono in affanno); dall’altro sono riservati a un’élite di esperti e le loro biblioteche, gli apparati, i depositi, restano inaccessibili. Una digitalizzazione intensiva permetterebbe, come in molte altre parti del mondo, di avere a disposizione tanto materiale di studio in più. Anche il mercato dell’arte ha subito una svolta in seguito alle restrizioni della pandemia. Le grandi piattaforme di vendite e le aste online hanno incrementato notevolmente la loro attività (non altrettanto le piccole, alcune delle quali sono addirittura fallite), ed è pensabile che tale modalità resti in uso anche in tempi di ritorno alla normalità. Le gallerie private hanno lanciato delle viewing rooms, mantenendo così i contatti con i clienti e proponendo eventi. Anche in questo caso, la disponibilità di mezzi – che deve funzionare su un canale doppio, offerta/utenza – ha fatto la differenza. Un impulso fortissimo hanno ricevuto le attività di studio e approfondimento a distanza, fra webinar, convegni, incontri sull’arte, talvolta di altissimo livello: anche in questo caso, si è assistito a un incremento e a una diversificazione del pubblico e credo che il feedback sia in generale piuttosto positivo (la ricerca, invece, è stata messa seriamente in difficoltà, a causa della chiusura di archivi e biblioteche, come accennavo sopra).
Per quanto riguarda gli artisti, invece, non penso che il momento sia stato vantaggioso. So che alcuni di essi sono riusciti a reinventare il modo di fare ed esporre le proprie opere; la virtualità è ormai materia dell’arte e chi ha saputo usarla ha certamente potuto potenziare la propria attività. La riflessione spesso si è spostata sul tema della pandemia, a volte cavalcando un tema ormai inevitabile, altre volte usandolo davvero per andare a fondo su questioni importanti oggigiorno. Alcune iniziative sono state interessanti. Gli spazi pubblici si sono animati di proiezioni, la rete ha sviluppato contest e iniziative espositive, pertanto... Non vedo l’ora di andare a vedere una mostra dal vivo.

A cura di Giusy Capone e Afrodita Cionchin
(n. 6, giugno 2021, anno XI)
NOTE
[1] R.O.A.R. era l’acronimo, scelto come titolo, di «Roma agli Artisti». |
|

