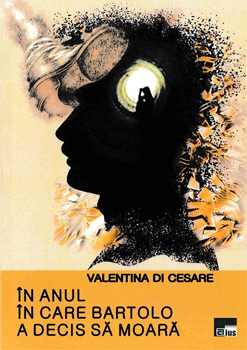|
|
Vacuum vivendi: il malefico esistenziale nell'antica discendenza tragica
 Per vari motivi circostanziali, non ho scritto della pubblicazione in romeno del libro Marta, croitoreasa (Ed. Aius, 2018) della scrittrice italiana Valentina di Cesare (n. 1982), nella squisita traduzione della nostra ex studentessa Carmen Făgețeanu, sebbene abbia partecipato attivamente alla sua presentazione pubblica nell’ambiente del Museo d’Arte di Craiova subito dopo la sua uscita. L’originale italiano, Marta la sarta, è stato pubblicato nel 2014 da Edizioni Tabula fati. Per vari motivi circostanziali, non ho scritto della pubblicazione in romeno del libro Marta, croitoreasa (Ed. Aius, 2018) della scrittrice italiana Valentina di Cesare (n. 1982), nella squisita traduzione della nostra ex studentessa Carmen Făgețeanu, sebbene abbia partecipato attivamente alla sua presentazione pubblica nell’ambiente del Museo d’Arte di Craiova subito dopo la sua uscita. L’originale italiano, Marta la sarta, è stato pubblicato nel 2014 da Edizioni Tabula fati.
A questo primo libro è seguita la traduzione del secondo romanzo dell’autrice, con il titolo În anul în care Bartolo a decis să moară (Ed. Aius, 2020, trad. di Carmen Făgețeanu). L’originale italiano, L’anno che Bartolo decise di morire, è uscito nel 2019 per i tipi di Arkadia Editore.
Propongo qui alcune mie impressioni di lettura di questo suo secondo romanzo, non per rivalutare una tecnica narrativa comune, ma – al contrario – per segnare una differenza strutturale e anche stilistica. Perché, se nel romanzo precedente le riflessioni si impiantano con garbo nel corpo delle storie, suggerendo, apud Susan Sontag, che sembrano sfuggire all'interpretazione, nel secondo, Nel giorno in cui morì Bartolo, il nucleo narrativo è centrato, nonostante ogni impressione superficiale, in una voce totalizzante, del protagonista in qualche modo ritirato nell'ombra delle altre voci che si intersecano e assecondano il suo destino. È una voce, anche di un'intera comunità provinciale, che ricorda la voce corale delle antiche tragedie elleniche.
E, nello stesso ordine riflessivo, Bartolo non parla nel senso discorsivo più stretto. Si limita a dare risposte agli interventi dei suoi commilitoni che in fondo lo riguardano. E, quindi, si ritira dal discorso dei suoi commensali i quali, rapito o irrimediabilmente sconfitto da quel male di vivere che gli toglie il gusto della conversazione. Non è un isolato, uno sperduto – come qualche personaggio di Dostoevskij o Kafka – ma piuttosto un eroe tragico di discendenza eschiliana. Si configura, nel proprio entourage, come un alto carattere di virtù e di ordine morale.
Nel profilo di Bartolomeo prevalgono gli attributi psicologici e morali, ma anche quelli civici, nascosti però nell'alveo di un destino fugace.
L'incipit è fulmineo e istruttivo, come monito semantico, per tutta la mossa di Valentina Di Cesare: «L'anno in cui Bartolo decise di morire nessuno si accorse di niente. Parenti, amici e conoscenti non sospettavano nulla di quanto stava per accadere. “Tutto era come sempre: l'estate era finita, l'azzurro del cielo era sbiadito e il sole di settembre voltava le spalle agli alberi e alle antenne del piccolo paese...»
Ho solo sottolineato queste parole in cui si trova, al livello quasi simbolico, il nucleo dell'intero intreccio narrativo: tutto è come sempre, una specie di Totum nihil est, e il fatto che tra coloro che non sospettavano nulla, sono nominati anche i suoi «conoscenti» si chiama anche, cioè amici della sua cerchia intima, è un'indicazione della categoria che ho assunto prima e che, a una lettura più attenta, mi porta a inquadrare l'intera narrazione nella forma di un tragico atto di monologo. E la prova più evidente di una tale impostazione è fornita da due piccoli capitoli così come gli altri, del romanzo.
Essi nascondono però l'attante verbale, come vedremo a suo tempo. Non può che incarnare la voce dello stesso Bartolo in una funzione co-autoriale: attivatore del registro narrativo, attraverso l'ispirata, rara e allo stesso tempo originalissima opzione dell'autrice.
Torniamo per il momento al romanzo precedente, Marta la sarta, in cui si nota anzitutto una scommessa quasi aperta sull'autenticità, impeccabilmente supportata dalla sequenza di eventi, personaggi, habitat, viaggi, ecc. E lì l'attante narrante è Marta, una sarta di periferia, viva, né felice (le sue momentanee conquiste sono però ben lungi da un destino festoso!), né del tutto sconfitta dai capricci della stessa sorte: Marta non ha passato personale se non evocando ricordi con la nonna, quindi i dialoghi sono diretti e vari a seconda della natura sociale e anche morale degli interlocutori.
In L'anno che Bartolo decide di morire cambia radicalmente tutta la portata e la strategia narrativa. Nessuno, né parenti né conoscenti (ergo, non necessariamente... amici, ma piuttosto amici nell'accezione introdotta in romeno da Caragiale!) sospettava cosa sarebbe successo almeno per due verità già enunciate anticipatamente: primo, l'assenza, chiamiamolo epistemologico, di ogni sintomo di grande cambiamento («Tutto era come sempre...»), e poi perché l'assenza è supportata dalla ciclicità della natura («l'estate era finita, l'azzurro del cielo aveva sbiadito...»).
Giunti ai due capitoli ci si preannuncia come entrambi la stessa voce del protagonista, e quindi come un «eroe tragico» ateniese anticipando quasi coralmente quella che nell'antichità sofocleo-eschiliana sarà chiamata la trama tragica, più importante del personaggio, qualcos'altro intriga nel percorso del monologo: la morte di Lucio, prefigurata in vari momenti e anticipata, anche successivamente, nei brevi dialoghi con lui dallo stesso Bartolo. Anche il suicidio, l'unico fino a quello di Bartolo, è un monito. Ma anche un passaggio attraverso il destino umano condizionato. Questa volta non passa inosservata, non entra più in un «seminterrato» dell'attenzione collettiva in cui si consuma la riconciliazione di Sisifo (camusiano?) con il destino, ma si trasforma quasi in un ammasso delle opinioni più diverse e bizzarre.
Ma anche Bartolo non va dirottato verso una vita perduta (motivo di un altro monologo, di un altro «noto», ma come se fosse ancora nelle parole del protagonista); aveva un lavoro pieno di piaceri e interessi nel campo, aveva la sua cerchia di conoscenti che lo ammiravano e lo onoravano con parole squisite, ecc.):
«Bartolo aveva deciso di morire comunque quell'anno, anche se poi il suo contratto di lavoro era diventato a tempo indeterminato.
– Sei stato fortunato, adesso hai tutto quello che si può desiderare, gli disse Renzo con un sorriso e la solita pacca sulla spalla.
Era vero, e Bartolo ne era consapevole: aveva un buon lavoro e ben retribuito a due passi da casa, un lavoro che svolgeva in autonomia, ma che gli permetteva di conoscere tante persone, informate o semplici curiosi, pronte in ogni momento per assalirlo con domande o raccontargli le sue storie».
Ma eccoci arrivati alla prima pagina, la 17, sottolineata, in cui, a nostro avviso, c'è il primo monologo di Bartolo, nonostante che intervenga una voce narrante che lo infastidisce: perché no, nella logica proposta da Valentina Di Cesare, anche un indirizzo personale?
«Adesso mi sento a pezzi, come se fossi ridotto a pochi filamenti sottili, e non so cosa o chi mi abbia dato il colpo di grazia. Quando si fa riferimento alla fine lo si fa sempre con timore, come se fosse qualcosa di impossibile, fermato, proibito, eppure bisogna capire fin dal primo momento che la morte non è una presenza estranea».
Naturalmente, il finale non poteva, ma in una nota di sfida al destino, non includere e implicare la rabbia, come la parte invisibile, non sentita e quindi del tutto strangolata del profilo psicologico e, dopo tutto, umano di Bartolo. È la rabbia per quell'incipit, entrambi essenzializzando la finitezza dell'essere del condanno a morte negli estenuanti momenti di presa di coscienza di questa tragica e irreversibile verità:
«…Sai cos'è la rabbia? La rabbia è vita, la rabbia è potere, la rabbia è dignità, la rabbia è ciò che provi quando ti viene detto che stai esagerando, che te lo stai inventando, che sei un peso, che sei scortese con la tua rabbia, che sei infantile, che non ha senso sentirsi offesi perché è così, è sempre stato così! Quindi Bartolo è arrabbiato? Lo spero. Sarà così per sempre? Spero di no, anzi, sono sicuro che ora non lo è. Sarebbe stato arrabbiato fino a poco tempo fa, ne sono certo, ma ora non lo è. Ora l'essere una volta arrabbiato è morto. Bartolo, quel Bartolo, finalmente si è deciso a morire.»
Un romanzo notevole per la sua struttura testuale non solo ispirata e originale ai grandi romanzi degli ultimi decenni, ma che offre anche nuovi sensi all'intuizione del lettore sul teatro un po' funesto, «scandaloso», tipico della condizione umana sulla scala della sua rappresentazione nella storia del pensiero e della cultura universale. E un'esatta e affascinante traduzione in romeno, in cui quasi nulla si perde della succulenza della lingua di Dante.
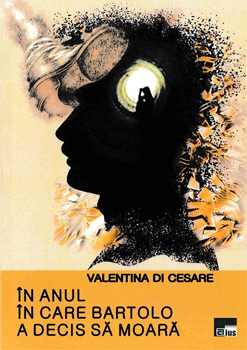
George Popescu
(n. 4, aprile 2023, anno XIII)
| |

 Per vari motivi circostanziali, non ho scritto della pubblicazione in romeno del libro Marta, croitoreasa (Ed. Aius, 2018) della scrittrice italiana Valentina di Cesare (n. 1982), nella squisita traduzione della nostra ex studentessa Carmen Făgețeanu, sebbene abbia partecipato attivamente alla sua presentazione pubblica nell’ambiente del Museo d’Arte di Craiova subito dopo la sua uscita. L’originale italiano, Marta la sarta, è stato pubblicato nel 2014 da Edizioni Tabula fati.
Per vari motivi circostanziali, non ho scritto della pubblicazione in romeno del libro Marta, croitoreasa (Ed. Aius, 2018) della scrittrice italiana Valentina di Cesare (n. 1982), nella squisita traduzione della nostra ex studentessa Carmen Făgețeanu, sebbene abbia partecipato attivamente alla sua presentazione pubblica nell’ambiente del Museo d’Arte di Craiova subito dopo la sua uscita. L’originale italiano, Marta la sarta, è stato pubblicato nel 2014 da Edizioni Tabula fati.