









|
|
Vincenzo Fiore: «Emil Cioran. La filosofia come de-fascinazione e la scrittura come terapia»
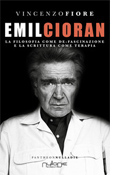 La casa editrice Nulla Die ha da poco dato alle stampe questo pregevole saggio del giovane studioso irpino Vincenzo Fiore, dal titolo Emil Cioran. La filosofia come de-fascinazione e la scrittura come terapia, che rivela, fin dalle prime righe, l’estrema accuratezza che lo stesso pone nell’affrontare alcuni dei temi-chiave che hanno costellato l’opera del geniale pensatore rumeno. Il volume, infatti, si configura come un’eccellente porta d’ingresso al mondo di Cioran da caldeggiarsi senza dubbio per i neofiti che vogliano penetrarvi e, al tempo stesso, contiene tutta una serie di brillanti intuizioni e una dovizia di particolari, notevole in tal senso l’apparato di note a piè pagina, capace di interessare anche il lettore più avvezzo alle atmosfere dell’autore di Squartamento o lo studioso più ferrato nelle «calunnie all’universo» di marca cioraniana. La casa editrice Nulla Die ha da poco dato alle stampe questo pregevole saggio del giovane studioso irpino Vincenzo Fiore, dal titolo Emil Cioran. La filosofia come de-fascinazione e la scrittura come terapia, che rivela, fin dalle prime righe, l’estrema accuratezza che lo stesso pone nell’affrontare alcuni dei temi-chiave che hanno costellato l’opera del geniale pensatore rumeno. Il volume, infatti, si configura come un’eccellente porta d’ingresso al mondo di Cioran da caldeggiarsi senza dubbio per i neofiti che vogliano penetrarvi e, al tempo stesso, contiene tutta una serie di brillanti intuizioni e una dovizia di particolari, notevole in tal senso l’apparato di note a piè pagina, capace di interessare anche il lettore più avvezzo alle atmosfere dell’autore di Squartamento o lo studioso più ferrato nelle «calunnie all’universo» di marca cioraniana.
Le prime pagine del testo tratteggiano la vita dello scrittore transilvano mettendone in luce alcuni episodi particolarmente significativi tra i quali spiccano la visione della ragazza di cui, da adolescente, era segretamente innamorato assieme al «pidocchio» (intrigante il parallelo che Fiore propone tra Cioran e Søren Kierkegaard: «anch’egli…si lasciò influenzare profondamente da episodi la cui entità reale potrebbe risultare sproporzionata») e la «celebre» frase che la madre di un giovanissimo Cioran rivolse al figlio «se avessi saputo, avrei abortito» con la conseguente realizzazione «di essere null’altro che un accidente e di conseguenza nulla andava preso sul serio, essendo tutto privo di sostanza».
E poi l’esordio con Pe culmile disperării del 1933, il libro in cui è già contenuto tutto ciò che il filosofo andrà rielaborando durante un’intera vita. Così Fiore: «Cioran sviluppa già dalla sua prima opera una filosofia auto-sperimentale, che non è uno strumento di conoscenza, ma una terapia che si serve della scrittura al fine di rendere sopportabile l’esistenza». Lo studioso campano ci propone, appoggiandosi a un ampio ventaglio di citazioni, una «scala della consapevolezza» disegnata, al solito in modo asistematico, da Cioran, che, in una sorta di catastrofe progressiva, procede dalla pianta all’animale ai due stadi umani di «dormienti» e di «veglianti», il cui rappresentante, il più torturato tra gli esseri, «non può che essere un fallito in quanto quest’ultima (la conoscenza) è “nemica dichiarata della vita”» (e viene in mente il Manfred di Lord Byron: «Sapere è patire. Sventura è la scienza. Coloro che più sanno più amaramente devono piangere il vero fato: l’albero della scienza non fu mai l’albero della vita»).
Fiore delinea poi la parabola che ha portato Cioran dal «totale disinteresse per quella “immensa porcheria” che è la politica» al suo breve, delirante avvicinamento alla Guardia di Ferro (sebbene Fiore individui diversi punti di notevole distanza tra il giovane filosofo e il movimento legionario) per rientrare poi in un atteggiamento contrassegnato dal pieno rinnegamento delle posizioni espresse in La trasfigurazione della Romania e dalla sua «crociata contro i fanatismi» che lo porterà a concepire la filosofia come «esercizio di de-fascinazione» e a incarnare la figura dell’«anti-profeta» attaccando senza esclusione di colpi la filosofia stessa, il cristianesimo (così Cioran: «il monoteismo giudaico-cristiano ė lo stalinismo dell’Antichità» e Paolo di Tarso sarebbe «le plus considérable agent électoral de tous les temps») e le ideologie («tutti dovrebbero andare a lezione dai sofisti antichi per apprendere l’arte del relativismo» o ancora «la società – un inferno di salvatori! Quello che vi cercava Diogene con la sua lanterna era un indifferente») in direzione di uno scetticismo radicale («[lo scettico] ha la missione di “vedere le cose quali sono” invece di vagare in illogiche astrazioni concettuali»).
Di assoluto rilievo il terzo capitolo il cui titolo, tratto dall’Edipo a Colono sofocleo, non lascia margini a fraintendimenti: μὴ φῦναι. Meglio non esser nati. In queste mirabili pagine Vincenzo Fiore dipana una sorta di genealogia dell’abiura della nascita, presentandoci alcuni illustri precedenti di questa idea in qualche modo convergenti sulla figura di Cioran. Tra questi di singolare interesse risultano essere quelli di ambito religioso: dalle sette gnostiche, i bogomili (dall’antico bulgaro bogumil, «caro a Dio») in particolare, alle religioni orientali (induismo e buddhismo) passando dai testi sacri della tradizione ebraico-cristiana. Fiore cita Il libro di Giobbe («Perisca il giorno in cui nacqui»), Geremia («Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto») e, naturalmente, l’Ecclesiaste, per Cioran «il libro che contiene “tutte le verità”, per cui è evidente che nella mente del filosofo risuonasse il passo dove si proclamano più felici i morti rispetto a coloro che sono in vita, “ma più felici degli uni e degli altri chi ancora non esiste” dato che i non-nati non possono percepire il male che si cela sotto il sole». Fiore affronta poi i classici greci. Segue le tracce della sentenza silenica me phynai tra Sofocle, Bacchilide («Non esistere: è ben questa per l’uomo la ventura delle venture, non vedere il sole») ed Euripide («Sarebbe invero opportuno che noi ci radunassimo a piangere le case dove qualcuno viene alla luce») per approdare infine alla filosofia nei pressi di Anassimandro secondo cui «l’atto di staccarsi dall’apeiron (ovvero la nascita) contiene in sé una colpa che verrà espiata soltanto ritornando alla massa originaria». Nel mondo latino, ci avverte Fiore, è Cicerone a riprendere la sententia sileni mentre non va dimenticato «Lucrezio che canta il lugubre vagito del fanciullo scaraventato fuori dal grembo materno» in una sorta di prefigurazione dell’heideggeriana Geworfenheit. Fiore segue la corrente carsica di questa concezione fino a toccare Leopardi, Schopenhauer, Pedro Calderon («Pues el delito mayor del hombre es haber nacido»), Shakespeare, Byron, Blake, Beckett, Pessoa e innumerevoli altri. Insomma una straordinaria carrellata di grandi ingegni seguaci del “me phynai” che culmina con la terrificante e spietata requisitoria dell’autore de Il funesto demiurgo nel quale si legge «un giorno le donne incinte saranno lapidate, proscritto l’istinto materno e acclamata la sterilità […] procreare significa amare il flagello, volerlo conservare e favorire».
Di qui a una ricognizione sopra le posizioni di Cioran intorno al tema del suicidio il passo è breve. Fiore pone in relazione diretta l’idea del suicidio con il potere auto-terapeutico accordato dal romeno alla scrittura sulla base del fatto che per quest’ultimo «un libro è “un suicide différé”», potere che coinvolge non soltanto Cioran in prima persona ma anche «parte dei suoi lettori» come testimoniato da molti di questi (ma attenzione! Cioran stesso ci informa che «la mia medicina non è universale»).
Completa il volume una bibliografia di notevole accuratezza, uno stuzzicante scritto della giornalista venezuelana Carol Prunhuber che rammenta una visita fatta a Cioran assieme a Vasco Szinetar, fotografo suo connazionale noto per una serie di scatti allo specchio ritraenti se stesso assieme a grossi calibri della cultura mondiale, una specie di antesignano del «selfie» insomma, da cui emerge il Cioran quotidiano, «un uomo sorridente e vibrante che ci invitava a entrare», un essere umano di grande tenerezza, ben lontano dalla figura stereotipa ombrosa che molti immaginano. A proposito della sessione fotografica, di cui il testo propone alcuni, eloquenti scatti, Prunhuber rivela come «l’obiettivo catturò lo sguardo penetrante di Cioran e la sua intensità angosciosa».
La fulminante lettera spedita dallo scrittore rumeno a Szinetar chiude degnamente lo splendido saggio del filosofo irpino.
Alessandro Seravalle
(settembre 2018, anno VIII)
| |

